|
 ...Sezione:
IURA ...Sezione:
IURA |
| |
SCRITTURE
SULL'ACQUA
Testimonianze storiche ed archeologiche
di traffici marittimi di libri e documenti.

Rassegna di Archeologia subacquea di Giardini Naxos
28 ottobre 1995
di Gianfranco
Purpura
In: Annali Univ. Palermo (AUPA), XLIV, 1996, pp. 361 -
382.
|
 |
| Sommario
|
|
L’articolo
si sofferma sulle testimonianze relative a scritture imbarcate
a bordo delle navi antiche ed alla documentazione di bordo,
prendendo tra l’altro in considerazione il P. Vindob.
G. 40822 del II sec. d.C., che contiene le clausole di
un prestito per un viaggio terrestre e marittimo di andata
e ritorno (dáneion amphotéroploun) da Alessandria
d’Egitto a Muziris, noto centro del commercio romano
in India.
Dopo aver accennato al trasporto di intere biblioteche
a Roma sul finire dell’età repubblicana, si
avanza l’ipotesi che la celebre biblioteca di Aristotele,
predata da Silla, possa essere in parte affondata durante
il viaggio per mare verso Roma, in navi come quelle naufragate
a Mahdia o Anticitéra. Alcune epigrafi attiche
ritrovate a Mahdia (Petzl, Die griechischen Inscriften,
in Das Wrack, Der antike Schiffsfund von Mahdia, I, 1994,
Köln, pp. 381-397) ed altre testimonianze e reperti
sembrano confortare tali ipotesi.
|
|
Nel
Satyricon di Petronio viene descritto un naufragio:
“...la tempesta, fedele esecutrice di ciò
che il destino comanda, porta via tutto quel che resta
alla nave; non vi sono più alberi, né timoni,
né cordami, né remi: massa informe e desolata,
il naviglio se ne va in balia delle onde. Subito accorsero
dei pescatori su scafi leggeri in cerca di preda. Ma,
quando videro che v'erano ancora persone vive e pronte
a difendere i propri beni, la loro crudele avidità
cedette a offerte di aiuto. Ed ecco udiamo uno strano
mugolio, quasi un lamento di belva prigioniera, che usciva
dalla diaeta, la cabina del magister. Ci lasciamo guidare
da quel suono, e troviamo Eumolpo, seduto dinanzi a una
pergamena immensa su cui andava accumulando versi su versi.
Sì, pur con la morte alla gola quel pazzo aveva
trovato il tempo di stendere un poema, e che razza di
poema, dèi benigni! ". (Addirittura sulla
distruzione di Troia). "Lo strappiamo di là
che urla e protesta, gli gridiamo di non far follie. `No',
strepita lui, furioso di essere stato interrotto, ` lasciatemi
terminare la frase: sto facendo l'ultimo sforzo per finire!
'(1)”
Se
vele, sandali (relitto di Comacchio), panieri di vimini
(Gelydonia, Ulu Burun, Marsala), mandorle (Kyrenia), grambiuli
di cuoio (Comacchio), foglie d'olivo, canapa indiana (Marsala),
nocciole [Albenga, Punta Crapazza (Lipari)], ramoscelli
(Giens), paglia (Giannutri) ed altri materiali organici
assai deperibili provengono da numerosi scavi archeologici
sottomarini, non solo il forsennato poeta, ma anche l'epica
pergamena stavano correndo il rischio di essere sepolti
con lo scafo e magari di avere la possibilità di
essere ritrovati dopo millenni.
Sebbene
possa apparire un obiettivo assai limitante per la palese
incompatibilità tra acqua salmastra, inchiostri
e scritture, ritengo non privo d'interesse guardare alle
testimonianze di materiali scrittori o di scritti trasportati
a bordo delle navi o che quotidianamente ivi venivano
redatti; testi di solito brevi, relativi più al
mondo del commercio e del diritto, che, ovviamente, alla
letteratura epica. È tuttavia certo che anche opere
letterarie furono concepite in mare, come nel caso sopra
menzionato nel Satyricon. Cicerone in persona ad
esempio ci informa che l'opera Topica fu iniziata a bordo
di una nave in navigazione dopo Velia e che nel percorso
marittimo verso la Cilicia dopo Samo, il medesimo, divenuto
governatore, modificò il testo dell'editto provinciale,
che avrebbe dovuto pubblicare al momento del suo ingresso
in provincia. (2)
Le
relative testimonianze archeologiche subacquee appaiono
finora assai rare e tali sembrano essere destinate a restare,
sino all'improbabile rinvenimento di una nave carica di
libri, simile al relitto degli anni sessanta ubicato intorno
ai cinquanta metri di profondità al largo della
Tonnara di S. Vito Lo Capo, nei pressi di Palermo (fig.
1). Esso contiene numerose copie del Corano, che
nel buio e nel fango della stiva hanno già superato
diversi decenni di immersione nell'acqua salmastra (fig.
2). In attesa di un evento di tal genere attingeremo
alle testimonianze delle fonti antiche, che occasionalmente
ci parlano di un commercio librario transmarino, come
quello sollecitato da Platone che diede incarico di acquistare
in Sicilia, per diecimila denari versati da Dione, le
opere filosofiche di Filolao, introvabili in Grecia o
quello attestato dalla presenza di libri a bordo delle
navi che nel I1I sec. a.C. approdavano ad Alessandria.
L'esistenza infatti nella Biblioteca di Alessandria del
fondo detto "delle navi" pare risalga a Tolomeo
Filadelfo (285 246 a.C.), il quale aveva ordinato
che venissero ricopiati da scrivani degli uffici doganali
tutti i libri in transito e che gli originali fossero
trattenuti per la Biblioteca ed ai viaggiatori venissero
restituite soltanto le copie. (3)
Ad
esigenze di computo e documentazione si ricollega invece
il più antico materiale scrittorio rinvenuto in
scavi subacquei. Risale al XIV sec. a.C. e dimostra la
possibilità della conservazione sul fondo marino
di reperti organici assai deperibili. Si tratta di una
tavoletta cerata lignea con cerniere in avorio (fig.
3), che costituisce in assoluto una delle più
antiche testimonianze dell'utilizzazione di questo tipo
di supporto scrittorio. (4)
Purtroppo la cera della superficie scrittoria risulta
quasi del tutto abrasa, evidenziando le lineole incrociate
incise per favorire l'adesione della gumma al legno. La
composizione del carico dello straordinario relitto di
Ulu Burun non solo trova riscontro nelle lettere di Tell
Amarna, ma anche in raffigurazioni tombali egiziane coeve,
che rappresentano l'arrivo di navi levantine in Egitto
e dimostrano l'usuale impiego del dittico in questione
a fini di registrazione dei prodotti imbarcati. Oltre
che per la trasmissione della corrispondenza, questo dovette
essere uno dei giù antichi usi della scrittura,
soprattutto nel mondo palaziale.
E
di grande interesse valutare l'indubbio e rilevante ruolo
esercitato dal commercio marittimo nella diffusione della
scrittura, ma l'esame dei molteplici aspetti del problema,
indurrebbe a superare ampiamente i limiti di tempo in
questa sede definiti. Mi limiterò quindi a qualche
cenno, maggiormente attinente all'angolazione prescelta:
l'archeologia sottomarina e la situazione siciliana.
La
sorprendente assenza di volumina papiracei micenei è
stata già notata ed appare pressocché impossibile
che segni in lineare B, oltre che su tavolette, non siano
stati tracciati su papiro. (5)
La capacità del fango o della sabbia del fondo
di conservare reperti organici potrebbe offrire la prova
mancante. Ancor più suggestivo è rilevare
che la migrazione coloniaria tra il IX e 1'VIII sec. a.C.
pare abbia richiesto la stesura scritta dei poemi omerici
ed il trasporto per mare dei testi, utilizzati dagli esploratori
che localizzavano, via via nei siti estremi raggiunti,
le imprese in essi descritte. (6)
A
distanza di molti anni dalla prima presentazione, torno
a richiamare l'attenzione su di un reperto rinvenuto a
Terrasini, che ritengo di un certo interesse e rimasto
pressocché ignoto agli specialisti. (7)
Si tratta di una tavoletta di terracotta (fig.
4) ritrovata ad un centinaio di metri dalla spiaggia
tra Cinisi e Terrasini, a circa due metri di profondità
in una zona pertinente ad un antico ancoraggio. I segni
di una scrittura sconosciuta procedono con andamento circolare
dall'esterno verso l'interno in senso antiorario, separati
a gruppi da linee verticali, che evidentemente staccano
singoli termini del testo. Le numerose lineole verticali
al centro potrebbero essere relative ad un computo. Pur
essendo alcuni segni molto caratteristici, simili a minuscoli
oggetti simbolici, non ho trovato per essi alcun riscontro.
Il reperto di Terrasini, consegnato nel 1974 al Museo
di Palermo, risulta fotografato (arch. fotografico, negativo
n. 22451), ma da allora non ne ho più notizia.
Una
delle più accreditate ipotesi sull'origine e prima
utilizzazione della scrittura nel mondo egeo collega la
medesima alle cretule impresse con simboli o nomi di consegnatari,
di generi e quantità di prodotti forniti. Tali
cretule sarebbero state realizzate per render conto di
derrate palaziali consegnate o affidate ad esibitori di
validi contrassegni o addirittura di modelli miniaturistici,
corrispondenti in numero e genere ai prodotti forniti
da chi li custodiva per conto dell'autorità, che
poteva così trasmettere i suoi simboli anche in
absentia, senza il continuo ricorso alla parola parlata.
(8)
È suggestivo notare che di recente è stata
rinvenuta in Sicilia, in un contesto assai antico, una
cretula sigillo con segni di " cordami che dovevano
legare un contenitore di ignote caratteristiche"
nel fossato neolitico di Stretto Partanna (Trapani).
(9)
Oggetti miniaturistici o calculi in terracotta
per il computo (tokens), (10)
che precorrerebbero i segni impressi e i simboli successivamente
tracciati sulla tavoletta d'argilla, furono nel mondo
orientale talvolta contenuti in bolle sferiche d'argilla
(bullae), che venivano spezzate per verifica del
contenuto in caso di contestazione in merito ai segni
tracciati o impressi sulla superficie esterna. A queste
origini si ricollega con ogni probabilità la forma
a cuscinetto della tavoletta d'argilla, che talvolta conteneva
un duplicato del tutto nascosto all'interno, e, adeguandosi
al medesimo principio, nonostante la grande distanza nel
tempo e nello spazio, la doppia scritturazione sigillata
su tavolette lignee dei documenti dell'età greco
romana. Se per un verso, come si è osservato, alcuni
segni della tavoletta di Terrasini hanno l'aspetto di
piccoli oggetti, anche enigmatici corni fittili della
preistoria siciliana sembrano ritrovarsi assai simili
tra i tokens, (11)
lasciando intravedere usi e pratiche di computo e di registrazione
per qualche aspetto analoghe in due ambienti per noi così
lontani, ma che in realtà già con la rivoluzione
neolitica avrebbero potuto essere diffusi in ambiente
mediterraneo.
Ma come tra percettori di imposte e mercanti per millenni
sopravvisse la prassi della doppia scrittura, nonostante
caratteri e materiali assai diversi, così da un
mondo di analfabeti o semianalfabeti potevano giungere
almeno sino all'età arcaica pratiche di computo
mediante calculi, tacche, incisioni in corrispondenza
biunivoca, o di trasmissione di rudimentali messaggi mediante
oggetti miniaturistici. Reperti di questo tipo possono
facilmente sfuggire negli scavi subacquei o essere non
correttamente interpretati ed è realmente sorprendente
che nessun relitto, nonostante la frequente presenza di
pesi e bilance (Yassi Ada, Camarina, Giardini, Palud),
abbia finora restituito una tavola per contare o abaco,
che pur doveva essere un oggetto di frequente impiego
nella pratica del commercio. Un oggetto miniaturistico,
un cinghialetto, è presente nella nave della fine
del VI sec. a.C. di Gela, ma, con alcune arule, è
collegabile ai culti praticati a bordo. (12)
Pesi o tessere plumbee, probabilmente calculi,
si riscontrano nel carico della fine del VI, inizi del
V sec. a.C. di Pointe Lequin, (13)
insieme ad una pisside calamaio, ma è obiettivamente
assai difficile essere certi del tipo d'impiego di reperti
del genere in una società mercantile semianalfabeta,
che tuttavia cominciava già ad utilizzare la scrittura,
come indicano le lamine plumbee del VI V sec. a.C.
di Corfù o di Pech Maho (fig.
5), lo stilo dalla nave di Gela o la tavoletta
lignea del relitto del Giglio (fig.
6). (14)
Quest'ultimo reperto, purtroppo non inscritto, faceva
parte del corredo della fine del VI di un nobile mercante
greco orientale che adoperava le armi, la scrittura, attrezzi
tecnici e musicali per mantenere un potere sapienzale
affidato alla memoria ed alle capacità tecniche.
Tra
il carico del IV sec. a.C. del relitto di Porticello appaiono
già sette contenitori globulari, che sono stati
interpretati come calamai (fig. 7).
E, se modesti reperti dall'impiego così particolare
facevano ormai parte di un carico commerciale, ciò
non può che denotare una diffusione della scrittura
in strati sociali sempre più vasti, anche se siamo
ben lontani dall'ammettere quel fenomeno di ampia alfabetizzazione
del mondo greco e magno greco, che sino a poco tempo
fa si era più propensi ad accettare. (15)
Scritture di bordo
Carichi
di età repubblicana, come quello di Marsala, (16)
della prima età imperiale, come quello di Comacchio
e di Camarina, (17)
o dell'età imperiale inoltrata, come quello del
Plemmiro, (18)
includeranno come reperti abituali penne di legno o stili
e calamai di bronzo (fig. 8).
Sostanze coloranti provengono dai relitti della Triscina
(fig. 9) e di Planier 3 del
I sec. a.C. ed è probabile (almeno nel primo caso
per l'associazione ad una pàtera miniaturistica),
che siano state utilizzate per la preparazione di inchiostri.
(19)
Come è noto, dalla Spagna, oltre che minium
secundarium per la confezione di inchiostro rosso,
veniva spedito a Roma in pacchi sigillati, quale tributo
provinciale, cinabro (cinnabaris) usato per scrivere
sull'oro. Essendo oggetto di monopolio statale, il minerale
poteva essere lavorato solo a Roma, utilizzando una maschera
(vescica) a causa dei gas che esalava durante la
cottura, quindi poteva essere riesportato in provincia.
(20)
Sandaraca (réalgar), impiegata normalmente
per lucidare fogli abrasi, è presente in abbondanza
nel relitto Planier 3. Volumina di papiro, tavolette
cerate (fig. 10) e forse
taccuini di pergamena furono abituali per appunti allo
scopo di favorire il trascorrere nel tempo in navigazione,
per la stesura di documenti di bordo (fig.
11-12), per i contratti. E anche
se i papiri egiziani hanno conservato polizze d'imbarco
di merci, lasciapassare, liste di carico, contratti di
trasporto merci e passeggeri, di prestito marittimo, di
locazione, realizzando talvolta effetti assai vicini a
quelli del moderno leasing o dell'assicurazione,
occorre non dimenticare che nel mondo romano venne riconosciuta
al documento al più un'efficacia probatoria, in
concorso con la ben più importante prova testimoniale,
che restò sempre privilegiata. Ciò dunque
determinava un ricorso non costante ad una documentazione
scritta, più come aiuto della memoria, che per
la costituzione di diritti. (21)
È questa la giustificazione dell'inesistenza, per
quanto ne sappiamo, di una documentazione di bordo, non
tanto per quanto atteneva al titolo di proprietà,
quanto all'origine e costruzione dell'imbarcazione.
Tra gli innumerevoli testi relativi al diritto commerciale
ellenistico e romano vorrei richiamare l'attenzione solo
su di una recente scoperta: un papiro della metà
del II sec. d.C. (Pap. Vindob. G. 40822) che contiene
le clausole di un prestito per un viaggio terrestre e
marittimo di andata e ritorno (daineion amphotéroploun)
da Alessandria d'Egitto a Muziris (recto, col.
II, l. 12), noto centro del commercio romano in India
(fig. 13). (22)
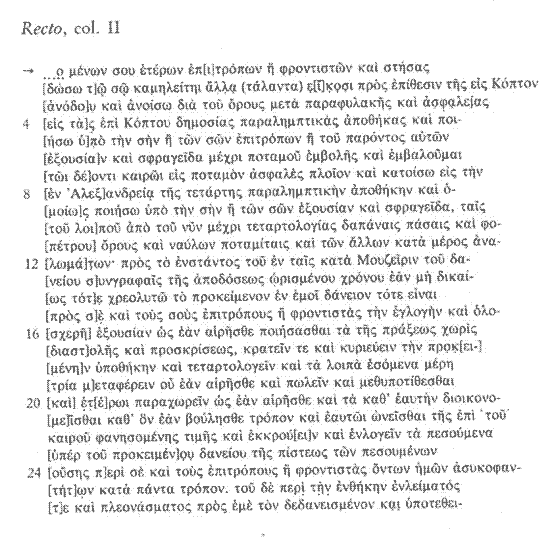 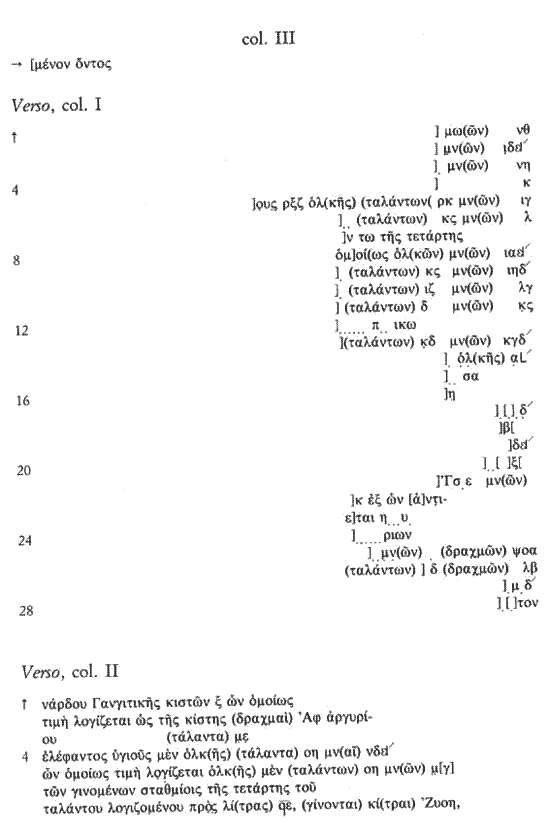
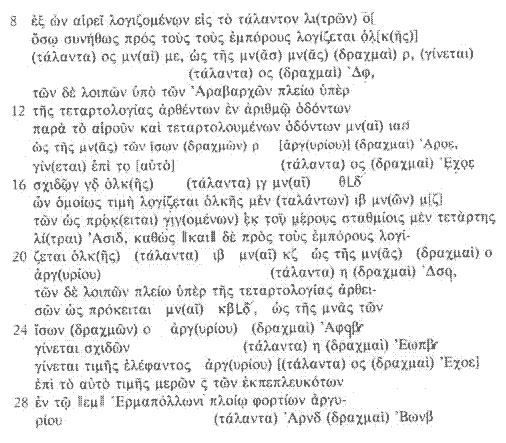
Recto,
col. II:
"...dei tuoi altri procuratori o amministratori,
e peserò e darò al tuo conduttore di cammelli
altri venti talenti per la guida della carovana verso
Coptos. Ed io seguitò il trasporto attraverso il
deserto fino al deposito pubblico della dogana a Coptos
sotto la sorveglianza e con le misure di sicurezza e porrò
(la merce) sotto il tuo diritto di disposizione e sotto
il tuo sigillo, o dei tuoi procuratori o di altro uomo
presente, fino all'imbarco sul fiume; e caricherò
al tempo stabilito nel fiume una nave sicura e trasporterò
(la merce) nel deposito doganale per la tetralogia ad
Alessandria e nello stesso tempo porrò (la merce)
sotto il tuo diritto di disposizione e sotto il tuo sigillo
o, rispettivamente, dei tuoi uomini, (facendo fronte)
a tutte le spese, conformemente alla ripartizione, per
la nave a partire da ora fino alla tetralogia ed ai costi
del trasporto attraverso il deserto e ai noli fluviali
ed alle altre spese. Se è giunto il momento della
restituzione che è stato concordato nelle síngrafi
del prestito concluso per Muziris, ed io non salderò
il mio debito nel tempo stabilito, allora a te ed ai tuoi
procuratori o amministratori rimarrà la libera
scelta ed il potere illimitato (di disposizione) secondo
il vostro parere di compiere l'esecuzione senza dilazione
ed aggiudicazione, di impadronirsi ed amministrare la
suddetta ipoteca e di pagare un quarto del patrimonio
come dazio e di portare i restanti tre quarti dove vorrete;
e di vendere e di pignorare ulteriormente e di cedere
ad un'altra persona, come sempre voi vorrete, e di amministrare
secondo la vostra volontà l'affare; e di prendere
per te stesso al consueto prezzo di mercato e di incamerare
e detrarre dal summenzionato prestito le entrate, accordando
(piena) fiducia per le entrate a te ed ai tuoi procuratori
o amministratori, mentre non agiremo reciprocamente in
ogni modo. Il meno ed il più della somma dell'affare
grava su di me, mutuatario ed ipotecario...".
Verso,
col. I
(Questa
colonna, assai lacunosa, conteneva il computo per il pagamento
del dazio relativo a tre partite di mercanzie non determinabili).
Verso,
col. II
[Prosegue il computo per il pagamento del dazio ed i relativi
conteggi per altre tre partite di mercanzie: nardo del
Gange (11. 1 3), zanne di elefante di buona qualità
(11. 4 15), balle di stoffa (11. 16 25)]
ll.
27 29
"Questo
è l'intero valore delle sei partite di merci, che
nella nave Ermapollo sono trasportate: millecentocinquantaquattro
talenti e duemilaottocentocinquantadue dracme".
Fin dalla pubblicazione nel 1985 il documento ha suscitato
tra gli interpreti discussioni soprattutto sulla natura
dell'accordo: prestito marittimo contratto in India per
un viaggio di sola andata (Harrauer, Sijpesteijn); accordo
sostitutivo o integrativo di un prestito di sola andata,
concesso in India e stilato all'arrivo in un porto del
Mar Rosso (Casson); accordo supplementare relativo alle
garanzie, pagamento dei dazi ed ai compensi, allegato
alle singrafi nautiche redatte ad Alessandria per un viaggio
di andata e ritorno in India (Thür). (23)
Il
testo allude ad un termine massimo per la restituzione,
di solito un anno, "che è stato concordato
nelle singrafi di prestito concluso" katà
Mouzeîrin (r. col. II, l. 12). Da ciò
si è desunto che il papiro non costituisca copia
della singrafe nautica, ma un documento accessorio relativo
alle garanzie ed al pagamento dei dazi. Infatti l'espressione
katà Mouzeîrin è stata intesa
in maniera ellittica, come riferentesi ad un prestito
(concernente un viaggio) a Muziris, piuttosto che concesso
in quella località dell'India . (24)
In sede di revisione del testo, nonostante una migliore
lettura della clausola relativa ad un compenso per un
capo carovaniere di fiducia del creditore, sembra persistere
l'allusione ad un'altra (l. 2: álla) retribuzione
del capo cammelliere, che avrebbe potuto essere prevista
per il viaggio d'andata, come ipotizza Thür. È
da ritenere che previsioni del genere fossero disciplinate
nei più minuti dettagli già ad Alessandria,
fin dalla partenza. Non solo la celebre singrafe di Lacrito
(fine IV sec. a.C.) o il prestito di Callimaco (D. 45,
1, 122, 1) del II d.C. prevedevano fin dall'inizio alternative
dettagliate da seguire nel corso del viaggio, ma un quasi
coevo testo del Digesto (D. 22, 2, 4, 1) contempla il
caso del compenso previsto fin dalla partenza per l'uomo
di fiducia del creditore, che normalmente accompagnava
le mercanzie, per evitare che attraverso la dazione di
questa somma ad un dipendente del creditore potesse essere
eluso il divieto di superare il tasso massimo d'interessi
per il tempo eccedente. (25)
Non
è affatto da escludere che un affare come questo,
che si riferiva all'enorme valore di 1154 talenti d'argento
e 2852 dracme (v. col. II, l. 29), fosse stato minuziosamente
disciplinato fin dall'inizio, prevedendo un compenso per
l'uomo di fiducia del creditore, che accompagnava le merci
(kermakólouthos, epiplous).
Sia
che il papiro abbia attraversato l'Oceano Indiano sulla
nave denominata Ermapollo (verso, col. II, l. 28)
e sia ritornato ad Alessandria (Thür), o sia stato
redatto dopo la traversata all'approdo sulle coste del
Mar Rosso (Casson), esso documenta un lungo viaggio misto,
terrestre e marittimo, come nel caso del prestito di Callimaco,
che si svolgeva "sotto sorveglianza e con le misure
di sicurezza" (r. col. II, 1. 3), prima sul Nilo
con un'imbarcazione fluviale idonea, fino al deposito
pubblico della dogana a Coptos, poi attraverso il deserto
orientale, fino al porto di Berenice o Myos Hórmos
sul Mar Rosso (fig. 14).
Ancora attraverso l'Oceano sfruttando il monsone e, dopo
quasi un anno, si seguiva un identico percorso di ritorno.
Le iscrizioni di mercanti romani nelle nicchie del deserto
(Wadi Menih), (26)
il giacimento di anfore romane Dressel 2 5 e Lamboglia
1 a Zabargad (fig. 15-16-17-18-19),
nella parte meridionale del Mar Rosso nei pressi di Berenice,
(27)
il bassorilievo abruzzese dei Peticii (fig.
20-21) con dromedari che trasportavano
anfore attraverso il deserto (28)
sono altre testimonianze di questo commercio
"oltre i confini dell'impero", (29)
che interessò ben presto i negoziatori italici
(fig. 22), ma che secondo
Plinio sottraeva oro per non meno di 50.000.000 di sesterzi
all'anno.
La biblioteca naufragata
Oltre che a viaggi di scritture tanto lontano, si può
accennare al trasporto per mare di documenti ufficiali
o di interi archivi di magistrati e funzionari, quando
essi, sul finire della repubblica e l'inizio dell'impero,
cominciarono ad essere con costanza alimentati con testi
sistematicamente conservati. I codices ansati (fig.
23) del proconsole di Sardegna Elvio Agrippa nel
69 d.C. (30)
erano talmente manegevoli da poter seguire il governatore
nei suoi spostamenti. Tale prassi non fu certamente isolata.
Ancor più interessanti sono le notizie relative
al trasporto di intere biblioteche dalla Grecia o dall'Asia
a Roma sul finire dell'età repubblicana. (31)
Carichi navali che sono stati valutati in 40.000 50.000
rotoli per una piccola biblioteca, come quella di Aristotele,
in 400.000 500.000 volumi per le maggiori. (32)
Nel 168 a.C., dopo la vittoria sul re Perseo, fu importata
a Roma per mare la prima ampia collezione di libri greci:
Lucio Emilio Paolo permise ai suoi figli, di cui uno era
Scipione Emiliano, di utilizzare la straordinaria biblioteca
appartenuta alla corte di Alessandro Magno, intorno alla
quale gravitò d'allora in poi il Circolo degli
Scipioni. (33)
Altrettanto importante per la cultura latina fu la biblioteca
di Lucullo a Tusculo frequentata da Cicerone, che si ispirava
come architettura e concezione al Museo di Alessandria
e conteneva i libri trasportati nel 66 a.C., anche in
questo caso per mare, come bottino sottratto a Mitridate
VI, re del Ponto. Non può non sorprendere che questa
raccolta venisse nelle fonti ricordata, come "il
pritaneo ed il focolare di tutti Greci che giungevano
a Roma", (34)
a preferenza della ancor più straordinaria collezione
di Silla a Cuma, che addirittura conteneva la biblioteca
e i libri di Aristotele.
Anche
questa biblioteca era stata trasportata per mare dopo
il sacco di Atene, intorno all'84 82 a.C. Infatti
Silla se ne era impadronito sequestrandola all'ultimo
proprietario, il "bibliofilo, piuttosto che filosofo",
Apellicone di Teo, (35)
che era riuscito ad entrare in possesso delle opere aristoteliche,
lasciate da Teofrasto a Neleo e comprendenti, non solo
Aristotele, ma anche molti altri autori. Esse erano state
a lungo nascoste dagli eredi di Neleo per sottrarle alla
cupidigia dei più munifici sovrani ellenistici.
(36)
Come è noto, le opere di Aristotele si presentano
distinte in quelle destinate all'esterno o pubblicate
(tómoi exoterikói) e scritti composti
per essere ascoltati nella scuola (tómoi akroamatikói).
E anche se già Aristotele accenna più di
una volta a tale distinzione, (37)
è possibile che questa netta separazione tra opere
dallo stile tanto semplice, chiaro e fluente (le exoteriche)
da far dichiarare a Cicerone, che aveva studiato in Grecia,
che Aristotele è uno scrittore "che versa
un aureo fiume di eloquenza " e scritti tanto oscuri
e spesso trasandati (gli acroamatici) da far dire al contrario
a Filodemo che il filosofo "parla in modo oscuro",
(38)
si colleghi soprattutto alle vicende della tradizione
manoscritta. Se così non fosse come giustificare
che paradossalmente delle pubblicate, che più facilmente
avrebbero dovuto essere tramandate, avanzano solo frammenti,
ad eccezione dell'Athenaion Politeía ritrovata
in un papiro egiziano, mentre le seconde, salvate per
un'avventura quasi miracolosa, costituiscono il Corpus
Aristotelicum, complesso monumentale di filosofia
e di scienza a noi pervenuto? (39)
Si
potrebbe pensare che in seguito al trasporto navale di
Silla solo le seconde giunsero a Roma e furono destinate
ad essere meglio conosciute, mentre le prime, scomparse
in mare nella versione originale, erano destinate a circolare
attraverso qualche copia realizzata soprattutto dopo il
rinvenimento di Apellicone, che aveva distinto le opere
in precedenza nascoste e tentato anche qualche edizione,
oggetto di severe critiche in Strabone. Non v'è
dubbio che commentarii di Aristotele potevano essere
letti da Cicerone anche nella biblioteca di Tusculo (40)
e che almeno parte della biblioteca di Apellicone era
giunta a Roma, nonostante Luciano ricordi che una nave
diretta in Italia, che conteneva i trofei di Silla fosse
affondata al largo di Capo Malea, perdendo tutto il suo
carico insieme ad un dipinto di Zeusi. (41)
Non solo sono menzionati esemplari tucididei del IV sec.
a.C. compresi nella biblioteca di Apellicone portata a
Roma, (42)
ma anche un'antica Iliade con un'inizío diverso
da quello correntemente noto, detta di Apellicone. (43)
Se dunque Graecia capta ferum victorem cepit, et artes
intulit agresti Latio, (44)
ciò avvenne non solo per il fascino esercitato
dalle opere d'arte addotte in suolo italico e che i rinvenimenti
sottomarini di Anticitéra, Mahdia, Riace, Capo
Artemisio consentono adesso, in qualche caso, di individuare,
ma soprattutto per l'influenza esercitata dalle innumerevoli
opere librarie ellenistiche trasportate a Roma per via
marina.
È
stato, con ironia, osservato che il collegamento con il
sacco di Atene compiuto dalla soldatesca di Silla dei
rinvenimenti sottomarini di opere dell'arte greca, con
eccessiva disinvoltura proposto, è stato un "motivo
evidentemente ricorrente negli studi sui naufragi di opere
d'arte", ma si deve riconoscere che Anticitéra
e Mahdia restano "a tutt'oggi i due più cospicui
documenti del traffico commerciale marittimo delle opere
d'arte". In particolare si propende a non attribuire
il carico navale di Anticitéra (fig.
24) al bottino sillano in base ad una valutazione
complessiva dei materiali, che indicherebbero una datazione
tra 1'80 e il 70 a.C. ed una rotta di navigazione commerciale
con provenienza dall'Asia Minore e successive soste a
Paro, "dove sarebbero state imbarcate le statue di
marmo". (45)
Si trascura tuttavia che i reperti ritenuti caratterizzanti,
come lampade, di un tipo molto diffuso ad Efeso, coppe,
boccali e brocche, provenienti dalla parte centrale della
costa dell'Asia minore potevano essere presenti ad Atene
in un momento di intensi contatti di quella città
con l'Asia, a causa della guerra mitridatica e che dall'area
egea proveniva altra ceramica, come le anfore dodici
esemplari di Coos, di Rodi ed una coppa megarese,
probabilmente fabbricata a Delo. Erano presenti a bordo
anche ceramiche italiche e vetri alessandrini. Silla prima
della spedizione del bottino aveva dovuto compiere una
campagna in Asia e costringere Pergamo alla resa. Nella
primavera dell’83 pare che si trovasse ad Efeso,
con l'intenzione di tornare ad Atene e da lì in
Italia. Ceramica cd. pergamea è presente nel carico,
ma anche monete provenienti da Pergamo e risalenti all'88 86
a.C. Due monete che si è tentato di identificare
con coniazioni efesie del 70 60 a.C. appaiono in
uno stato di conservazione tanto cattivo da non fornire
alcuna certezza. (46)
Non solo la datazione complessiva dei materiali non contrasta
con l'ipotesi sillana, ma l'importanza del carico, realmente,
a mio avviso, fuori dell'ordinario, induce a propendere
per una preda bellica. Erano state imbarcate almeno una
trentina di statue di bronzo e marmo, tutte di grande
valore, forse interi complessi statuari. (47)
Anche il sito del naufragio sembra coincidere con quello
indicato da Luciano. L'isola di Anticitéra, come
è stato notato, (48)
si trova esattamente al largo di Capo Malea, nella rotta
tra la Grecia e l'Italia. Dalla località del naufragio
proviene poi un celebre
calcolatore (fig. 25)della
posizione delle stelle, opera dell'astronomo Gemino, operante
a Rodi nella prima metà del I sec. a.C. Il complesso
reperto appare più consono ad un antico "Museo"
e a raccolte di libri e di curiosità scientifiche,
che utilizzabile come strumento di navigazione. Dalla
posizione delle stelle, fissata dalla catastrofe della
nave e della stessa Grecia, pare accertato che lo strumento
si riferisca ad un periodo successivo all'87 a.C. (49)
Anche il relitto di Mahdia si ritiene connesso al sacco
di Atene (fig. 26). La datazione
dei reperti appare in questo caso fuori discussione, come
riferentesi al periodo della permanenza di Silla in Grecia,
anche se si propende per ritenere la nave un'imbarcazione
adibita al commercio, piuttosto che al trasporto del bottino.
Dal sito provengono capolavori statuari e oggetti di lusso
fuori dell'ordinario; ruote dentate e ghiere che sono
state interpretate come ingranaggi di un pendolo, (50)
strumento che anche in questo caso sarebbe stato degno
di essere esibito nella collezione di un "Museo",
piuttosto che costituire parte di una attrezzatura di
una nave.
Di
recente è stato sostenuto che i meccanismi in questione
abbiano piuttosto costituito parti staccate di tre diverse
catapulte trasportate incomplete (fig.
27), ma resta poco chiara la pertinenza delle
medesime ad un carico commmerciale. (51)
Altrettanto enigmatica è la presenza a bordo "di
alcune stele attiche con iscrizioni e rilievi votivi,
in marmo dell’Imetto e del Pentelico (fig.
28), del IV sec. a.C., che, data la disparità
cronologica con il resto del carico, si è pensato
fossero utilizzate sulla nave come zavorra. (52)
Materiali di zavorra abbastanza insoliti", di peso
insignificante, "non altrettanto invece in un carico
di opere d'arte come pezzi d'antiquariato destinati a
qualche dotto collezionista". (53)
Ma in un accurato riesame di queste epigrafi (una datata
al 363 362 a.C., le altre alla metà o fine
del IV sec. a.C.) si è giustamente osservato che
nessun pezzo appare particolarmente attraente per un collezionista.
I tre reperti per noi più interessanti erano un
tempo posti nel santuario di Páralos, ove con decreto
del popolo di Atene erano collocate offerte votive. La
zona agli inizi del III sec. a.C. fu sconvolta da eventi
bellici.
Occorre
poi sottolineare che siamo ben lontani dall'epoca in cui
monumenti epigrafici poco spettacolari divennero oggetto
di collezionismo e di commercio e che nessun altro relitto
romano con un carico di opere d'arte ha finora restituito
epigrafi greche. (54)
Un
dato, offerto dalle fonti, non è stato finora collegato
con questa presenza insolita. Apellicone, "al tempo
in cui aveva acquistato la biblioteca di Aristotele e
molti altri libri, aveva cominciato ad acquisire furtivamente
epigrafi originali degli antichi decreti del Metróon,
l'archivio di Atene, e di altre città, purché
fossero antiche e rare. Ricercato per queste azioni ad
Atene, avrebbe perduto la sua vita se non si fosse nascosto.
Ma dopo breve tempo tornò ad Atene di nuovo, ottenendo
il favore di molta gente". (55)
È dunque plausibile che abbia conservato, nonostante
tutto, nella sua raccolta le antiche epigrafi. Se si ipotizza
l'imbarco di tali reperti come oggetti sequestrati insieme
a tanti altri, si giustifica un'esportazione di antiche
pietre con caratteri greci, che certo non mancavano in
Italia meridionale ed in particolare nei dintorni di Cuma,
ove era ubicata la villa di Silla e destinata la raccolta
libraria. Come infatti è stato già osservato,
non ha alcun senso ipotizzare un'esportazione di questi
testi dalla Grecia in Italia per scopo di commercio.
Le
fonti consentono di evidenziare un'altra concomitanza.
Apellicone è ricordato come inetto comandante militare
di Delo, che si opponeva ai romani. Quando l'isola cadde
in mano di questi ultimi furono bruciate "tutte le
macchine d'assedio, inclusa la catapulta `cattura città'
che Apellicone aveva costruito, quando era giunto a Delo".
(56)
La presenza di parti di catapulte nel carico di Mahdia,
oltre ad epigrafi greche, potrebbe essere giustificata
dal particolare interesse di un collezionista, proprietario
della biblioteca di Aristotele, che per la sua opposizione
militare ai romani aveva avuto sequestati tutti i suoi
beni e probabilmente perso la vita?
Ovviamente
ci fermiamo qui, ma la doppia concomitanza mi è
sembrata degna di essere evidenziata. Se appare sorprendente
che entrambi i rinvenimenti probabilmente collegati al
sacco di Atene avvenissero ai primordi delle immersioni
sottomarine, occorre ricordare la grande conoscenza dei
fondali dei pescatori di spugne, che in quegli anni potevano
essere sollecitati, non da mucchi di ceramica o di anfore,
ma da situazioni realmente eccezionali, come cumuli di
opere d'arte. E le opere esportate da Silla, talmente
numerose da lasciare tracce ancora oggi apprezzabili nel
Pireo (alludo al rinvenimento di statue nel Kantharos
nel 1959), furono certamente imbarcate in diverse navi
che all'approssimarsi dell'inverno dell'82 si affrettavano
per il trionfo, celebrato sul finire del gennaio dell'81.
(57)
Se si considerano le modalità dei recuperi allora
effettuati, affiora una grande amarezza. Con cognizione
di causa per la lunga pratica con palombari, scrive Throckmorton
di Anticitéra: "Era come se gli scavi nella
tomba di Tutankhamon fossero stati eseguiti in turni di
cinque minuti da facchini ubriachi, che lavoravano nella
semioscurità e indossavano i parastinchi del rugby
e secchi del carbone sulla testa". (58)
I pionieristici recuperi effettuati agli inizi del '900,
nel caso di Madhia appena pervenuti alla pubblicazione
di un catalogo, (59)
non avrebbero potuto certamente tener conto di reperti
tanto fragili ed importanti, come frustuli di volumina,
che un tempo avrebbero potuto far parte della prima e
più importante di tutte le biblioteche: quella
di Aristotele e di Teofrasto,(60)
trasportata per mare in ceste o casse e forse giunta solo
in parte a Roma.
|
©
Gianfranco Purpura
Dipartimento Storia del Diritto
Università di Palermo |
Note:
1
PETRONIO, Satyricon 114 115 (trad. Dèttore,
Milano, 1953).
2
CICERONE, Ad Familiares 7, 19 (luglio, 44 a.C.);
Ad Att. VI, 1, 15 (51 a.C.) e Ad Fam. 3, 8, 4:
Romae composui edictum: nibil addidi nisi quod publicani
me rogarunt quum Samum ad me venissent.
3
GELLIO 3, 17; cfr. DIOGENE LAERTIO 4, 5. GALENO, vol.
17, 1, p. 601 Kühn.
4
BASS, PuLak, COLLON, WiensTEiN, A bronze age shipwreck
at Ulu Burun. 1986 Campaign, AJA, 93, 1989, pp. 10 e s.;
SIRAT, Les tablettes à écrire dans le monde
juif de 1'Antiquité à 1'époque moderne,
Paris, 1990, Bibliologia, 12, Brepols Turnohout,
1992, p. 53 e fig. 1.
5
GODART, L'invenzione della scrittura. Dal Nilo alla Grecia,
Torino, 1992, p. 176; Id., Il disco di Festos, Torino,
1994, pp. 43ss., rileva la morbidezza dei segni del lineare
B e la frequente presenza di cretule, che avrebbero potuto
sigillare rotoli papiracei.
6
Secondo MANFREDI, Mare greco, Milano, 1992, p. 214ss.,
sarebbero stati imbarcati i testi dei poemi, piuttosto
che i cantori. La coppa di Nestore da Pitecusa rappresenta
una straordinaria testimonianza della diffusione di Omero
tra i coloni.
7
PuRPURA, Il relitto di Terrasini, Sicilia Archeologica,
24 25, 1974, p. 56, fig. 19.
8
GODART, L'invenzione della scrittura, cit., pp. 91ss.;
103ss.; 241ss.; CARDONA, Storia universale della scrittura,
Milano, 1986, p. 53; PURPURA, Diritto, papiri e scrittura,
Torino, 1995, pp. 40ss.
9
TUSA, Sicilia preistorica, Palermo, 1994, pp. 67 e s.,
fig. 28.
10
SCHMANDT BESSERAT, Before writing, I, From counting
to cuneiform, Austin, 1992.
11
BERNABò BREA, La Sicilia prima dei Greci, Milano,
1958, p. 108; SCHMANDT-BESSERAT, Before writing, 1, cit.,
pp. 36 e 106, figg. 24.1; 24.2; 24.3 e 52. Anche oggetti
ritenuti gettoni, pedine, contrappesi, vaghi di collane
avrebbero potuto essere utilizzati nel definire complessi
predeterminati nel genere e nella quantità.
12
Panvini, La nave greca di Gela, Archeologia Viva, 37,
1993, p. 61. Etichette lignee intagliate per la distribuzione
di derrate alimentari tra l'equipaggio, bastoni con tacche
per il computo tra analfabeti, secchi da mensa con segni
convenzionali sono frequenti in relitti del '600 e '700.
THROCKMORTON, Atlante di Archeol sub., Novara, 1988, pp.
199 e s.
13
LONG, MIRÒ, VOLPE, Sui fondali di Pointe Lequin,
Archeologia Viva, 41, sett.ott. 1993, pp. 28 29.
14
VÉLISSAROPOULOS, Les symbola d'affaires. Remarques
sur les tablettes archaiques de l’ile de Corfou,
Symposion, 1977, Kóln Wien, 1982, pp. 71 83;
SOLIER, Les tablettes de plomb languedociennes, Atti del
Colloquio del CNRS "Les tablettes à écrire",
cit., p. 107 125; CRISTOFANI, Il testo di Pech Maho,
Aleria e i traffici del V sec., MEFRA, 105, 2, 1993, pp.
833 845; Panvini, La nave greca arcaica di Gela,
Conferenze STAS, Roma, 18 nov. 1993; BOUND, Una nave mercantile
di età arcaica all'Isola del Giglio, Il commercio
etrusco arcaico, Quaderni del centro di studio per 1'archeol.
etrusco italica, 9, 1985, pp. 65 70; Id., Archeol.
Viva, V, 1, 1986, p. 55; CRISTOFANI, Un mercante greco orientale
nel Tirreno: analisi del relitto del Giglio, Atti VIII
Rassegna di Archeol. subacquea, Giardini, 1993, in preparazione.
15
HARRIS, Lettura ed istruzione nel mondo antico, Bari,
1991, pp. 75ss.
16
Frost ed altri, Lilybaeum, Not. Scavi, XXX, 1976 (Roma,
1981), p. 282 e fig. 177.
17
BERTI, Rinvenimenti di archeologia fluviale ed endolagunare
nel delta ferrarese, Boll. d'Arte, Suppl. al n. 37 38,
1987, Archeologia subacquea, 3, p. 31; BACILIERI, GUERRESCHI,
Anatomia di un naufragio, Archeologia Viva, 12, luglio agosto
1990, p. 18; Di STEFANO, Camerino 1990. Nuove ricerche
e recenti scoperte nella baia e nell'avamporto, Atti della
V Rassegna di Archeol. subacquea, Giardini, 1990 (Messina,
1992), pp. 196.
18
GIBBINS, The roman wreck of c. AD 200 at Plemmirio, near
Siracusa (Sicily): second interim report, AJNA, 18, 1,
1989, p. 12, figg. 10 e 11. Il reperto, trovato con strumenti
chirurgici, viene considerato come una stecca lignea,
utilizzata in medicina. Dal porto di Olbia proviene un
vasetto a calamaio con coperchio ed una etichetta lignea
con numerali romani in un contesto del I sec. a.C.
II sec. d.C. Cfr. GANDOLFI, Primi risultati tipologici
e cronologici da un saggio stratigrafico nel porto di
Olbia, Boll. d'Arte, 5uppl al n. 37 38, Archeologia
subacquea 3,1987, p. 121 figg. 8 e 10.
19
PURPURA, Alcuni rinvenimenti sottomarini lungo le coste
della Sicilia nordoccidentale, Sicilia Archeologica, 28 29,
1975, p. 76 e fig. 19; GIANFROTTA, POMEY, Archeol. subacquea,
Milano, 1981, p. 335.
20
PLINIO, Nat. Hist. XXXIII, 118 123; Jacob,
DS, I, 2, pp, 1182 5.
21
Sull'efficacia del documento del mondo ellenistico e romano
cfr. PURPURA, Diritto, papiri e scrittura, cit., pp. 131 153.
22
HARRAUER, SiJPESTEIN, Ein neues Dokument zu Roms Indienhandel,
P. Vindob. G 40822, Anzeiger d. Österreichische Akad.
d. Wissenschaften, Phil. Hist. Klasse, 122, 1985,
1 9 (Wien, 1986), pp. 124 155; Casson, P. Vindob.
G. 40822 and the shipping of goods from India, BASP, 23,
3 4, 1986, pp. 73 79; THÜR, Hypothekenurkunde
eines Seedarlehens für eine Reise nach Muziris und
Apographe für die Tetarte in Alexandreia, Tyche,
2, 1987, pp. 229 245; THÜR, Zum Seedarlehen
katà Mouzeîrin, Tyche, 3, 1988, pp. 229 233;
Casson, New light on maritime loans: P. Vindob. G. 40822,
ZPE, 84, 1990, pp. 195 206.
23
Ma anche sulla determinazione delle parti (proprietari
di navi, secondo gli editori, o mercanti, secondo Casson
e Thür) o sul tipo di garanzie offerte dal debitore
(la nave, secondo Harrauer, Sijpesteijn, le merci importate,
dedotto il pagamento di un quarto del valore per dazi
doganali, secondo Thür, Casson).
24
CASSON, New light on maritime loans, cit., pp. 203 e s.
25
Purpura, Ricerche in tema di prestito marittimo, Annali
Seminario Giuridico dell'Università di Palermo,
XXXIX, 1987, p. 288; GOFAS, Epiplous: une institution
du droit maritime grec antique, hellenistique, byxantin
et postbyzantin, Symposion, 1985, Akten d. Ges. f. Griech.
u. Hell. Rechtsg., 6, pp. 425 444.
26
DE ROMANIS, Viaggi ed esplorazioni oltre i confini dell'impero
fra l'età di Plinio e quella di Tolomeo, Optima
Hereditas. Sapienza giuridica romana e conoscenza dell'ecumene,
Milano, 1992, pp. 261 e s.
27
VERRI, Naufragio al tropico, Archeologia Viva, 45, maggio giugno
1994, pp. 52 5 7.
28
TCHERNIA, Le dromadaire des Peticii et le commerce oriental,
MEFRA, 104, 1992, 1, pp. 293 301.
29
MORTIMER WHHELER, La civiltà romana oltre i confini
dell'impero, Torino, 1963, pp. 127 ss.
30
CIL X, 2, 7852 del 69 d.C.: descriptum et recognitum
ex codice ansato L. Helvi Agrippae proconsulis.
31
CANFORA, Le biblioteche ellenistiche, in Le biblioteche
nel mondo antico e medioevale, Roma Bari, 1989, p.
17; FEDELI, Biblioteche private e pubbliche a Roma e nel
mondo romano, in Le biblioteche nel mondo antico, cit.,
pp. 31ss.; PESANDO, Le biblioteche, in Libri e letture
nel mondo romano, Archeo, 6 1995, p. 91.
32
CANFORA, Le biblioteche ellenistiche, cit., pp. 13 e s.;
pp. 20 e s.
33
ISIDORO, Orig. 6, 5, 1; PLUTARCO, Vita di Emilio
Paolo 28.
34
PLUTARCO, Vita di Lucullo 42.
35
STRABONE, Geogr. XIII, 1, 54; PLUTARCO, Vita di Silla
26; ATENEO V, 214 215.
36
DIOGENE LAERZIO 5, 5, 2; FEDELI, Biblioteche private e
pubbliche, cit., pp. 32 e s.; CANFORA, La biblioteca
scomparsa, Palermo, 1986, pp. 34ss.
37
ARISTOTELE, Poetica p. 1454 b 18; GELLIO, Noctes
Att. XX, 5, 12.
38
CICERONE, Acad. pr. II, 38, 119; Rhetor. II, 51 (Sudhaus).
39
COLONNA, La letteratura greca, Torino, 1968, pp. 481 e
s.
40
CICERONE, De fin. III, 10.
41
LUCIANO, Dialoghi 22 [63], 3.
42
LUCIANO, Dialoghi 58 [31], 4.
43
Anecdotum Romanum (ed. Nauck del Lexicon Vindobonense,
p. 273); DZIATZKO, PWRE, I (1894), coll. 2693 ss., v.
Apellikon; CANFORA, Le biblioteche ellenistiche,
cit., pp. 6; 17 e s.
44
ORAZIO, Ep. II, 1, 156 7.
45
WEINBERG (a cura di), The Antikythera shipwreck reconsidered,
55, 3 (1965); GIANFROTTA, POMEY, Archeol, subacquea, Milano,
1981, pp. 198 e S.; HELLENKEMPER, Der Weg in die Katastrophe,
in Das Wrack, Der antike Schiffsfund von Mahdia,
a cura di Hellenkemper Salies, Hoyer v. Prittwitz u. Gaffron,
Bauchhenss, I, 1994, Köln, pp. 158 e s.
46
THROCKMORTON, op. cit., p. ZO; HELLENKEMPER, Der
Weg in die Katastrophe, cit., p. 158.
47
L'elenco è impressionante: in bronzo, un efebo
del IV, una statua femminile con peplo dorico, due giovani
ignudi, un'altra statuetta di efebo, dei piedi calzati,
un braccio di pugilatore, due spade di statue, uno strumento
musicale, una statua di filosofo, rivestimenti di letti
e mobili, coppe d'argento, erote e piccole lire d'oro,
un orecchino; in marmo, due Afrodite, due Eracle colossali,
due Hermes, due Apollo, un Zeus, due statue sedute, un
giovane atleta, due Ulisse, un Achille, un Filottete,
una guadriga. Inoltre secondo THROCKMORTON, Atlante, cit.,
p. 16 pare che molti bronzi siano stati venduti ad Alessandria
proprio in quel periodo.
48
THROCKMORTON, Atlante, cit., p. 20.
49
DE SOLLA PRICE, Geras from the Greeks, Trans. Am. Phil.
Soc., 64, 7 (1974). Cfr. anche WEINBERG (a cura di), The
Antikythera shipwreck reconsidered, 55, 3 (1965).
50
KAPITÄN, A toothed gear and water drawing pendulum
from the Mahdia wreck, IJNA, 12, 2, 1983, pp. 145 153.
51
La diversa interpretazione è stata proposta da
BAATZ Die Katapultteile, in Das Wrack, I, cit.,
pp. 701 707, che ipotizza un'imbarco come vecchio
metallo, ma mancano altri reperti del medesimo tenore
nel carico.
52
DAIN, Inscriptions attiques trouvées dans les fouilles
sous marines de Mahdia, REG, 1931, pp. 290 303
= Inscriptions grecques du Musée du Bardo, 1936,
pp. 9 33.
53
GIANFROTTA, Archeol. sub., cit., p. 201.
54
PETZL, Die griechischen Inschriften, in Das Wrack, cit.,
pp. 381 397, finisce per concludere che, o le epigrafi
erano rimaste nell'enorme cala della nave come pezzi dimenticati,
o dobbiamo ammettere che la questione resta senza risposta.
55
ATENEO, Deipnosophistae 214 d e.
56
ATENEO, Deipnosophistae 215 a.
57
PLUTARCO, Vita di Silla 34. HELLENKEMPEK, Der Weg, cit.,
p. 154.
58
THKOCKMOKTON, Atlante di archeol. sub., cit., p.
17.
59
Cfr. il catalogo della mostra Das Wrack. Der antike Schiffsfund
von Mahdia, cit., voll. 2.
60
STRABONE, 13, 1, 54
|
|
|





