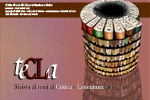È probabilmente il fenomeno artistico più controverso degli ultimi anni, perturbante a tal segno da scompaginare ogni convinzione sullo statuto e sul destino dell’arte attuale. Al cospetto delle sue “opere” gli interrogativi si moltiplicano, ma uno o due – credo – particolarmente incalzino: siamo ancora nel territorio dell’arte? O più semplicemente di fronte a una provocazione atroce? I cadaveri che popolano le sale delle sue esibizioni, mostrati privi di pelle, affettati o “esplosi”, gli organi escissi rispondono a una miliardaria trovata pubblicitaria, o danno vita a una istruttiva operazione scientifica? Enigmi che sono molto lontani dal trovare una soluzione, ma che stimolano a una riflessione soprattutto intorno a che cosa pretenda oggi il pubblico dall’arte.
In effetti Gunther von Hagens è il prodotto estremo di una deriva che parte da molto lontano, e che giunge a reificare – in una forma sconcertante, eppure (stando al numeroso concorso di visitatori) attrattiva e spettacolare – il concetto di “morte dell’arte”, rovesciandolo nell’epifania di una inquietante “arte della morte”. Le quattro mostre tenutesi in Italia nel 2012, ennesime tappe del circuito itinerante di Body Worlds1, oltre che occasioni di richiamo per un pubblico di migliaia di fruitori, hanno per la prima volta abbattuto alcuni tabù che nella nostra cultura parevano intangibili: la sacralità cristiana del corpo come oggetto indisponibile, la legittimità della sua ostensione post mortem laddove non si tratti di “reliquie”, la sua trasformazione in un aspetto che – pur formalmente rivelandone il funzionamento, impossibile da osservare in vita – non corrisponde né alla realtà, né al suo destino biologico. Persino i dubbi sulla provenienza dei corpi “plastinati” (su internet è disponibile un’ampia rassegna di notizie sulla loro origine, che qui non conviene riassumere), piuttosto che allontanare il pubblico dalle loro esposizioni hanno costituito una specie d’incentivo a visitarle, quasi che l’orrore che li soffonde rappresenti invece il piacere e la meraviglia di uno spettacolo nuovo2. Al di là di ogni valutazione d’ordine etico, che deve di necessità restare astratta da quelle di natura artistica, le statue di von Hagens aprono a chi le osserva non solo i loro apparati interni (non di rado in forma bizzarra), ma anche la strada ad alcuni quesiti: è un’arte nuova quella dell’anatomopatologo tedesco, una declinazione inusitata della creatività contemporanea? Le installazioni, indubbiamente esempi di virtuosismo compositivo e di complicata costruzione, appartengono ancora al mondo umano o piuttosto – paradossalmente – sono transitate nell’inorganico? Qual è insomma l’aura che promanano?
Qui – lungi da tentare spiegazioni sul successo di Body Worlds –vogliamo ipotizzare alcune chiavi di lettura utili, probabilmente, a comprendere le radici del “caso” von Hagens. Radici che riteniamo non affondino nel presente, ma che discendono a un tempo in cui estetica e critica d’arte erano ancora all’aurora delle loro formulazioni teoriche.
«Non conosco un nome per questo carnefice del nostro piacere…»
Quando alla metà del XVIII secolo l’estetica pervenne alla sua configurazione sistematica, il Bello parve essere la marca distintiva di ogni fenomeno artistico che aspirasse a legittimità nell’ambito della fruizione. La “fondazione” della disciplina da parte di Baumgarten aveva di fatto posto la bellezza come una specie di archetipo antropologico, cosicché nella costruzione concettuale del filosofo tedesco il “pensare in modo bello” rappresenta l’oggetto principale della riflessione umana, e la stessa “perfezione della conoscenza sensibile” s’identifica in tutto con la bellezza3. Eppure è da pensare che, tanto nel campo delle arti figurative quanto in quello della produzione poetica, il valore della bellezza abbia storicamente rappresentato un modello “perdente”, destinato a una posizione minoritaria che invano il Classicismo tentava di riabilitare: nel momento medesimo in cui – con ogni probabilità innaturalmente – il concetto di Bello sposava quello di Arte (nella formulazione del tutto ideale escogitata da Batteux4), il sistema delle Belle Arti perveniva a una crisi irreversibile non tanto e non solo nella problematica omologabilità di arti reciprocamente dissimili (la pittura analoga alla poesia ad esempio, l’architettura all’eloquenza), ma anche e soprattutto nel valore assoluto assegnato a una bellezza che in realtà è frutto di un processo astratto. L’arte bella, insomma, proviene da una mimesis condotta con una lente – diremmo – a focalizzazione differenziata: l’artista per Batteux deve individuare solo alcuni brani della natura e ricomporli in una unità artificiale, relegando il Brutto a una posizione periferica.
Eppure il Brutto rivendicava le sue ragioni, le quali non potevano solo concretarsi in una specie di cornice che consentisse al Bello di meglio risaltare. A una data (1719) che parrebbe “preistorica” rispetto alle vicende della nascita dell’estetica e della critica d’arte, Jean-Baptiste Du Bos aveva intuito che il sottofondo più riposto, ma al contempo più vivo, del gusto dello spettatore sta in un’attitudine al “piacere doloroso” che gli fa preferire spettacoli cruenti, rappresentazioni orride, oggetti che apparterrebbero più al dominio della ripugnanza che a quello del diletto: «un fascino segreto ci attrae dunque – scrive Du Bos nel presentare le sue ponderose Réflexions – verso le imitazioni fatte dai pittori dai poeti proprio quando la natura testimonia con un fremito interiore la sua ribellione contro il nostro piacere»5. È vero, già Aristotele6 e Lucrezio7 avevano pensato possibile una legittimazione estetica del Brutto e del dolore, l’uno nella perfezione del risultato imitativo pur alla presenza di un soggetto deforme, l’altro nello spazio che corre tra l’osservatore e la catastrofe lontana8. Tuttavia è nelle Réflexions che per la prima volta – con spiccata attenzione alla componente antropologica – s’individua in un sostrato biologico la necessità di un correttivo alla noia che sottragga l’uomo alla autodistruzione. Al punto che – ha acutamente osservato Luigi Russo – proprio nell’opera di Du Bos va ricercata la germinazione di quella Neoestetica che oggi costituisce il più accreditato orizzonte disciplinare degli studi filosofici sull’arte9. Da Du Bos doveva partire infatti quella linea che avrebbe condotto a considerare, già nell’estetica del tardo Settecento, il Brutto come fattore ineliminabile dell’esperienza umana. E nella Plastica di Joahnn Gottfried Herder (1778) è possibile ritrovare risonanze (fino a un certo punto sorprendenti) con le “plastinazioni” di Gunther von Hagens. Preciso che qui non ci si vuole, warburghianamente, richiamare a una “memoria dei fantasmi” o alla persistenza, oltre la corrosione del tempo, di forme che tornano caricate di nuova potenza. Ma è vero che mai come nel caso delle opere di von Hagens l’immagine-oggetto resta insepolta – e qui il riferimento ovvio è al testo illuminante di Georges Didi-Huberman10 – e la sua innaturale (o persino mostruosa) durevolezza è l’ipoteca alla sua uscita di scena dal palco dell’uso estetico.
La citazione che abbiamo posto all’esergo di questo paragrafo potremmo mistificarla come la registrazione del disappunto di uno spettatore, magari troppo legato alla tradizione rinascimentale, dopo avere visitato una delle esibizioni di Body Worlds: si tratta invece, com’è noto, di uno dei passi cruciali del breve scritto herderiano, l’atto fondativo dell’estetica della scultura. Assegnando al tatto una capacità conoscitiva persino superiore a quella di altri sensi (vista e udito) fin allora ritenuti i più nobili del corredo fisiologico dell’uomo, Herder per prima volta riduce a una specie di grado zero la prossemica tra fruitore e statua, diremmo a una “distanza intima” (per prendere a prestito la formula di Hall11) nella quale paiono annullate le differenze tra mondo biologico e arte: «una statua mi può abbracciare, può farmi inginocchiare, fare che io diventi il suo amico e compagno di gioco, essa è presente, è qui»12. La scultura diviene perciò a tutti gli effetti una forma vivente, un corpo13 con il quale il fruitore intrattiene un rapporto sottilmente erotico: perciò la statua è nuda. Herder, evidentemente, non può non guardare ai Gedanken di Winckelmann che ancora rappresentavano – in fatto di orientamenti del gusto – un testo sacrale. Il nudo per Winckelmann, prima ancora che esibizione di bellezza, è la posa di un equilibrio morale inattaccabile dalle malattie: la lue, l’orrore del secolo e lo stigma della depravazione, era sconosciuta ai Greci che potevano dunque ostentare, senza vergogna, le loro forme svelate14. La pelle delle statue greche, perciò, si distende docilmente sulla struttura corporea quasi ad annullare ogni scoglio percettivo. Herder amplifica il dettato winckelmanniano: la scultura vestita costituisce un assurdo estetico, e la mano che toccasse i panneggiamenti di una statua invano tenterebbe la propria ispezione conoscitiva, inutilmente cercherebbe di esperirne la bellezza15. Osservando perciò attraverso le considerazioni di Herder una Santa Teresa di Bernini, ne arguiremmo che si tratta di un’immagine doppiamente oscena: da una parte per la sovrabbondanza dell’abito monacale che ne fa una massa informe nemmeno classificabile come umana, dall’altra perché quell’orpello cela ai nostri occhi cosa realmente si svolga al di sotto dello schermo, qualcosa che ambiguamente ha più a che fare con la lussuria che con l’ascesi. Ora, se la statua vestita costituisce un estremo per eccesso, nella teoria di Herder all’opposto di questa linea diametrale (con la statua nuda in una posizione d’ideale equilibrio) sta un estremo per difetto, unoggetto ripugnante, un ostacolo che interdice alla mano la sua funzione estetica. Il terzo paragrafo del secondo capitolo, come accennavamo, costituisce uno snodo cruciale nella teoria di Herder poiché introduce al discrimine tra la possibilità di toccare e il ribrezzo del contatto con una materia disgustosa. Egli sa bene che il Brutto non è un oggetto estraneo alle arti, e che anzi ne è stato (e ne è) in molte fattispecie il motore dell’ispirazione. E a suo modo ne è attratto. Diversamente non spiegheremmo la straordinaria perizia con la quale egli si muove, fin sulle vette di un’informazione straordinariamente erudita, in un dominio molto particolare della scultura:
Ma lo scultore che diede forma per il nostro tatto in modo tanto orrendo a un cadavere, il ripugnante cibo dei vermi, facendolo penetrare in noi e dilaniandoci, ungendoci di pus e di ripugnanza: non conosco un nome per questo carnefice del nostro piacere16.
Herder resta volutamente indeterminato, ma è certo che il riferimento della sua nota va a Gaetano Giulio Zumbo17, il ceroplasta siciliano che allo scadere del Seicento aveva “incantato” le corti d’Europa con i suoi meravigliosi “teatri” della morte. L’opera che il tedesco adduce a paradigma del raccapriccio18 è con ogni probabilità la celebre Testa anatomica del Museo della Specola di Firenze, un autentico capolavoro di abilità mimetica e sapienza medica. Il brivido che Herder immagina pervadere le membra dello spettatore al cospetto della scultura, e che lo arresta alla soglia della tattilità, è evidentemente il risultato dello straordinario trompe l’œil plastico dello scultore siciliano: utilizzando un cranio reale, e rivestendolo di tessuti muscolari, tendini, epidermide e corredandolo degli organi interni il tutto modellato in cera, Zumbo crea una testa che appare già avanzatamente decomposta, dalla quale davvero sembra stillare il pus che contamina – anche solo allo sguardo – chi osserva. D’altra parte, Zumbo era stato l’iniziatore forse insuperato di un’arte della quale adesso von Hagens è l’ultimo, esangue codificatore: nel secolo di Herder, Ercole Lelli19 e Clemente Susini20 avevano di fatto condotto all’akmé l’efficacia imitativa e scientifica dei preparati anatomici, utilizzando vere strutture ossee sulle quali “montavano” i diversi apparati organici esattamente riprodotti, forse però perdendo quel sottofondo vagamente decadente che il ceroplasta siracusano aveva conferito alle sue creature.
Laddove la cera, probabilmente anche per la natura stessa del suo composto21 mal si presta a essere toccata, e il ribrezzo che suscitano le composizioni anatomiche è più frutto di associazioni d’idee che di una reazione fisiologica, il marmo può tuttavia restituire effetti che – quantunque meno illusionistici – ugualmente conducono all’orrore del contatto. Come una specie di larva, esattamente corporea, d’un tratto nel discorso appassionato di Herder compare l’immagine dello scorticato nella figura del San Bartolomeo di Marco d’Agrate (1562), custodito nel Duomo di Milano. Immagine “accademica” per definizione, sia che alluda a Marsia, all’Apostolo martire, al corrotto Sisamnes suppliziato per volontà di Cambise (nel grandguignolesco dipinto di Gerard David, 1498) o a Marc’Antonio Bragadin scuoiato a Famagosta, l’ecorché rappresenta il paradosso di un morto che si muove o sta in posa come un vivo: una figura “neutra” alla quale l’iconografia sacra o quella mitologica avevano affibbiato l’identità di un personaggio “reale”. D’altro canto, agli studenti del “nudo”, il personaggio privo di pelle esibiva il funzionamento dell’apparato muscolare, i movimenti reciproci delle diverse fibre e la loro posizione in ciascuno degli atteggiamenti possibili occultati in vita dal tegumento dermico. Ma il San Bartolomeo dello scultore cinquecentesco è per Herder ancor più orrendo delle cere anatomiche zumbiane poiché la legalità tattile della materia nella quale è scolpito collide con il suo trattamento scultoreo: una mano che tastasse il corpo del santo (peraltro tra i meno scioccanti dell’intera storia di questo genere iconografico) urterebbe tra muscoli scoperti, tendini e nervi e questo percorso “accidentato” in breve lo porterebbe a “immaginare” di stare davvero sfiorando un cadavere spellato. La statua stessa, la statua della quale sia possibile l’esperienza del tatto, deve dunque avere una specie di pelle metaforica che è al contempo sussidio e supporto della conoscenza: nei due estremi opposti (il positivo di una veste sovrabbondante, il negativo dell’assenza di epidermide), l’aisthesis è come irrimediabilmente attratta dal campo gravitazionale del Brutto, il campo in cui la cognizione è oscurata del tutto dall’esorbitare dell’emozione.
C’è probabilmente una linea, il cui estremo – come presto vedremo – è rappresentato dai “plastinati” di Gunther von Hagens e la cui origine non va tanto ricercata nella scultura esecrata da Herder, o nello scorticato di Ludovico Ciardi detto il Cigoli (1578, Firenze, Museo Nazionale del Bargello) che pure attrasse largo seguito d’imitatori. È piuttosto la celebre tavola I del secondo libro della Anatomia del corpo humano (Roma 1559) di Juan Valverde de Amusco, incisa da Nicolas Béatrizet su disegno di Gaspar Becerra, il prototipo da cui si diparte quel percorso – diremmo – di ridefinizione iconografica della corporeità. Su suggestione del San Bartolomeo michelangiolesco alla Sistina, “Beatricetto” e Becerra trasformano un’immagine strettamente “tecnica” in un prodotto artistico: lo scorticato dell’incisione è sì una mappa anatomica della localizzazione dei singoli muscoli, ma ancor più una specie di martire suicida, un San Bartolomeo che da se stesso s’è spogliato della pelle. Più d’uno ha visto in quest’opera la fonte d’ispirazione per The Skin Man (1997) di von Hagens, tra le prime e più celebri installazioni dell’anatomopatologo tedesco. Egli stesso, quasi a farne una citazione colta, ne denuncia la derivazione cinquecentesca22. Eppure non si tratta che di una, e nemmeno l’ultima declinazione di un soggetto particolarmente congeniale all’arte rinascimentale e barocca: nel 2006 Damien Hirst23 ha esposto per la prima volta una scultura in bronzo dal titolo Saint Barthelemew. Exquisite Pain (“San Bartolomeo. Squisito dolore”), che parrebbe la risposta in termini “tradizionali” all’opera di von Hagens24. In effetti, negli ultimi anni sembra sia corso una specie di certame tra i due artisti, un duello condotto – con risultati il più delle volte sconcertanti – sul tema della sofferenza, della malattia e della morte. La statua di Hirst è certamente quanto di più “classico” possano avere prodotto ultimamente le arti figurative: proporzioni perfette, persino “canoviane”, si sposano a un’akríbeia rappresentativa talmente parossistica da non retrocedere nemmeno al cospetto dei particolari più cruenti. Sul desco che fa da podio alla statua, il bisturi e il compasso, il pelvimetro e la stecca dello scultore sono gli strumenti di due professioni riunite in un unico esecutore. Il santo, non diversamente da quello dell’Atlante anatomico di Valverde de Amusco, s’è scucito da sé la veste epidermica con delle forbici da sarto: che poi la statua di Hirst, sfacciatamente, sia una traduzione in bronzo o più precisamente una copia dell’Ecorché (1767) di Jean-Antoine Houdon25 (Roma, Académie Française) poco importa. L’artista medesimo, ammettendo piuttosto d’essersi ispirato a Marco d’Agrate, afferma: «mi piace la confusione che c’è tra scienza e religione… è lì che la fede inganna tanto quanto l’arte»26. Il titolo della statua, volutamente ossimorico, evoca una specie di voluptas dolendi che Hirst spiega in termini quasi masochistici: «la sua posa e la sua sofferenza danno l’idea che egli si sia auto-inflitto il martirio. È una bellezza non di meno tragica»27. D’altra parte, nella produzione di Hirst l’ossessione del corpo anatomizzato, del tavolo dissettorio e della ispezione postuma sul cadavere costituiscono una costante almeno dagli anni ’80, dall’autoritratto fotografico in cui l’artista si rappresenta al fianco di una sconciata e grottesca testa di morto. In Adam and Eve Together at Last (2004) il “gioco” si sposta verso l’orripilante: l’installazione – a cavallo tra humour nerissimo e ribrezzo – riflette sui temi dell’immaginazione, della morte e del raccapriccio. Su un tavolo d’autopsia entro una teca, un sudario cela qualcosa che intuiamo uno scheletro. Brandelli di carne (che poi scopriamo essere niente più che pezzetti di pelle di pollo) si mescolano agli strumenti del medico legale. Ancora una volta però l’artista, piuttosto che mostrare l’orrore in tutta la sua flagranza, preferisce – diremmo al pari di un nuovo Timante – delegare alla fantasia l’agio di ricostruire cosa si celi sotto il lenzuolo: «ciò che non poteva dipingere, – avrebbe probabilmente affermato Lessing al cospetto dell’opera, ove non fosse fuggito scandalizzato – lo lasciò indovinare»28. Un tentativo di “rappresentare l’irrappresentabile” che, invece di depotenziare il sentimento del Brutto, ne amplifica i toni fino a rendere del tutto indifferente l’osservatore.
«…è il pennello della verità, non di un mercenario che desidera soltanto adulare…»
Si va in un museo, o ad una mostra, come se si visitasse un cimitero… La condizione dello spettatore di fronte all’arte contemporanea, di fronte alle opere di von Hagens, di Hirst, di Witkin, di Serrano e di molti artisti del presente, è quella di chi compie un atto di pietà spoglio tuttavia d’ogni sottofondo affettivo. È una situazione caratteristica ed esclusiva dell’oggi? O ancora una volta l’eredità di un tempo che non ha cessato di produrre i suoi effetti? Torniamo dunque brevemente a Herder per tentare una risposta. Nel passo che più sopra riportavamo, a un certo punto il tedesco cita – a modello di una descrizione esemplare del Brutto nelle arti figurative – «il più piacevole fra gli scrittori di viaggi in Sicilia»29. Si tratta, com’è noto, di Patrick Brydone il cui Tour Through Sicily and Malta (1770) rappresentò una specie di archetipo letterario per la generazione di viaggiatori che, nel circuito del Grand Tour, giunsero nell’Isola alla ricerca delle radici della Classicità. Il breve rimando di Herder evoca una delle costanti dell’approdo in Sicilia, una tappa che dallo scozzese in poi avrebbe rappresentato una meta irrinunciabile per chi volesse restituire un quadro efficace (ma non sappiamo fino a che punto realistico) di quei luoghi. Lungi qui dal ripercorrere la vicenda teorica del Pallagonico30, la categoria estetica che Goethe porrà a battesimo qualche anno dopo, ma che Brydone aveva certamente delineato in anteprima, è utile però osservare come – tra gli elementi che immancabilmente sembrano comporre il quadro della formazione estetica del viaggiatore settecentesco – compaia (oltre alla scalata all’Etna, alla visita delle vestigia classiche e all’“avventura” tra i demoni di pietra della Villa Palagonia) la discesa alle Catacombe dei Cappuccini di Palermo, la vasta collezione di mummie allineate nei sotterranei del Convento allora poco fuori città. Brydone è forse il più disincantato tra i viaggiatori che allo scadere di quel secolo giunsero a immergersi in quell’atmosfera da romanzo gotico, a esercitare nel buio di quei cunicoli sotterranei la fantasticheria di una sensibilità preromantica. I cadaveri appesi gli appaiono «una grande collezione di statue»31, e i colori «un po’ sbiaditi», dipinti da un «pennello che non è stato molto lusinghevole; ma non importa, è il pennello della verità, e non di un mercenario che desidera soltanto adulare»32. Qualche tempo dopo, Jean Houël avrebbe rilevato che quelle figure «hanno un atteggiamento particolare e sembrano conversare; è un quadro al tempo stesso odioso e grottesco, spaventoso e ripugnante; si è tentati di ridere e di fuggire. Tuttavia, data la singolarità di questo spettacolo, credo che un pittore non possa evitare di soffermarvisi per qualche tempo»33. Viene il sospetto che l’esperienza in quel sepolcreto a un certo punto si tramutasse in una specie di topos narrativo, la trasfigurazione in termini letterari di quel gusto morboso che avrebbe toccato le corde più acute nel secolo seguente nelle memorie di Guy de Maupassant e René Bazin. Tuttavia, almeno un elemento della descrizione dei due visitatori settecenteschi credo vada rilevato: il legame che tiene insieme l’idea della morte, espressa da quella immensa vanitas in forma di città sotterranea, e l’arte come strumento capace a un tempo di dare forma all’informe, di preservarla in un aspetto quantunque il più sconcio e di restituirne l’impressione caricata di potere emotivo. Un’esperienza estetica che tuttavia ha perduto l’originaria connotazione etica e antropologica, ed è divenuta divertimento macabro.
«To some, the creator of Body Worlds is an imposter, to others, he is a genius…»
È probabilmente indicativo il fatto che, nell’apparato del catalogo che correda le sue esibizioni, von Hagens faccia esplicitamente riferimento alle Catacombe palermitane34, come a tentare di dimostrare il fondamento “storico” della propria attività, al di là del legame al massimo grado profondo che tiene insieme arte e anatomia35. Ma nell’opera del tedesco questo nesso è saltato poiché in realtà le due pratiche ora sono un’unica entità: l’arte non studia più il corpo per riprodurne esattamente le posture e il funzionamento, ma agisce sul corpo per dare nella morte l’illusione della vita. Cadaveri che coitano o giocano a basket, barano a carte come in un quadro di Bartolomeo Manfredi o di Georges de Latour, disegnano esatte proporzioni come nell’Uomo Vitruviano di Leonardo o stanno in un equilibrio persino incredibile, da una parte indubbiamente accendono un senso di meraviglia e di ammirazione, dall’altra inducono a chiedersi se davvero questo sia un trattamento condivisibile della morte. In quella specie di dispositivo legittimante che chiude Body Worlds, il catalogo “ufficiale” delle esibizioni, Franz Josef Wetz si chiede se le mostre rappresentino una «impropria estetizzazione dei plastinati», se insomma sia eticamente sostenibile che i corpi esposti appaiano atteggiati allo stesso modo dei protagonisti di celebri opere d’arte, da Michelangelo a Hans Bellmer.Somiglianze puramente casuali, ammette (o falsifica) l’autore, poiché «quando von Hagens iniziò la sua attività, sconosceva l’esistenza di quei prodotti dell’arte»36. In realtà, sebbene ricusi la patente di artista, il look stesso col quale egli si presenta in pubblico (vagamente ispirato a Joseph Beuys) e le continue e sempre più frequenti “citazioni” da opere celebri non fanno che accrescere il sospetto che l’aspirazione dell’anatomopatologo sia quella di acquisire la cittadinanza nel mondo delle arti, di stupire il pubblico con trovate sconcertanti e argute a un tempo. Così nell’opera di von Hagens, non meno che in quella di Hirst, la pretesa di un’arte che si legittimi come depositaria della tradizione “classica” ha riportato in primo piano la figurazione, la messa in scena in paradossali tableaux vivants. Nascono così Drawer Man (1999), ispirato alla celebre Venere di Milo con cassetti (1936) di Salvador Dalì, più volte replicata, o Surgery in Still Life (2007), che rifà con materiale (che era) umano i celebri quadri con le lezioni di anatomia di Rembrandt. The Rearing Horse with Rider (2000) è probabilmente tra le installazioni più “spettacolari” di von Hagens: una specie di monumento equestre, con tanto di cavallo plastinato, che nella postura richiama – non sappiamo se volontariamente – al cavaliere distruttore del Trionfo della Morte palermitano. Reclining Pregnant Woman (1999) merita una o due parole in più: traducendo biologicamente le illustrazioni del corpo femminile dei trattati anatomici, von Hagens presenta il cadavere di una donna incinta (il ventre aperto a mostrare il feto) nell’atteggiamento caratteristico di alcune delle Veneri dormienti della tradizione rinascimentale. Anche in questo caso la risposta di Hirst non si è fatta attendere, nelle forme tuttavia tipiche della sua arte a metà tra esaltazione della iconografia scientifica ed esibizione di virtuosismo tecnico. Virgin Mother (2005), ideale prosecuzione di Hymn(1999), una specie di gigantesco manichino di studio anatomico,mescola il tema estetico del colossale (la statua è alta oltre 10 metri), la citazione da antecedenti della tradizione “classica” (il riferimento indissimulato è alla Ballerina di 14 anni, 1881 ca., di Edgar Degas), e il tormento della resa di un corpo aperto sempre più chiodo fisso dell’artista. Caratteri che si ritrovano esattamente riprodotti, o semmai amplificati, in Verity(2012), l’enorme statua che l’artista ha posto sulla banchina del porto di Ilfracombe nella contea inglese del Devon.
Qual è allora lo statuto dell’opera di von Hagens, scontato che la parallela produzione di Damien Hirst appartenga ormai solidamente all’orizzonte dell’arte attuale? «Per alcuni – recita la presentazione della lunga intervista biografica nella quale von Hagens cerca di abilitarsi come una personalità eccezionale – il creatore di Body Worls è un impostore, per altri un genio»37. Quale che sia il partito da assumere, non c’è alcun dubbio che quella dell’anatomopatologo tedesco vada pienamente considerata arte, almeno per come il tempo attuale la concepisce: ma è un’arte “morta”, e non solo per via dei materiali di cui s’avvale. Nel momento in cui la téchne è riassunta a fattore esclusivo della produzione artistica (nel senso che “esclude” ogni possibilità d’intromissione nel suo ambito a chi non ne possiede gli strumenti operativi), ridatandola al tempo dei mummificatori egizi, l’oggetto perde tutta la propria capacità auratica, e dunque l’efficacia estetica. Esaurita la mimesis, scomparsa la creatività, l’arte non può che ricorrere alla messa in scena, all’installazione diretta così che l’oggetto artistico si dà nel suo modello (piuttosto che nella sua raffigurazione). Ne deriva allora una nuova riduzione del ready made: l’oggetto non è più investito di un valore assente nel suo statuto originario, ma è semmai tramutato in una nuova composizione chimica. Ne deriva dunque da un lato il paradosso della esibizione di corpi che – divenuti cose – sono destinati persino a sopravvivere alla loro anima (e ciò almeno in una prospettiva escatologica); dall’altro il singolare rovesciamento del mito di Pigmalione, che era stato lo spunto simbolico alla riflessione di Herder: il corpo che si fa statua, quantunque formalmente intangibile. Eppure, il divieto di toccare nelle mostre di Body Worlds è piuttosto la lusinga della tattilità: confesso che, contravvenendo alle rigide disposizioni della mostra romana, ho sfiorato con la mano una delle creature di von Hagens, come a chiederle un brivido, un moto d’orrore, la repulsa di un oggetto che un tempo non lontano pensava, amava, parlava e che probabilmente è passato dal patibolo... macché! Una muta da sub, un pupazzo di gomma, un tappetino da ginnastica restituirebbero una reazione emotiva più intensa. Il vero shock nell’arte di oggi, probabilmente, appartiene alla bellezza.
1 Nel 2012 Body Worlds ha fatto tappa in Italia a Roma (Officine Farneto, 14 settembre 2011-12 febbraio 2012), a Napoli (Reale Albergo dei Poveri, 12 aprile-8 luglio 2012), a Torino (Palaolimpico, 29 settembre 2012-13 gennaio 2013) e a Milano (Fabbrica del Vapore, 3 ottobre-17 febbraio 2013).
---------------------------------
2 In occasione della festa di Halloween, il 31 ottobre 2012 la Fabbrica del Vapore (sede della esposizione milanese) ha organizzato una “festa” per i più piccoli, una specie di riprova del sottofondo ludico che von Hagens ha voluto conferire all’evento.
3 A. G. Baumgarten, Æsthetica (1750-58), § 14; ed. it. a cura di S. Tedesco, L’Estetica, Palermo 2000; per un commentario al testo, cfr. S. Tedesco, L’estetica di Baumgarten, Aesthetica preprint – Supplementa, 6, dicembre 2000.
4 Il testo di riferimento è ovviamente Ch. Batteux, Le Beaux-Arts reduits à un même principe (1747), nell’ed. a cura di E. Migliorini, Le belle arti ricondotte a unico principio, Aesthetica, Palermo 20024.
5 J.-B. Du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719); ed. a cura di M. Mazzocut-Mis e P. Vincenzi con introduzione di E. Franzini, Riflessioni critiche sulla poesia e sulla pittura, Aesthetica, Palermo 2005, p. 37.
6 Aristotele, Poetica, IV 1448b, 12-18.
7 Lucrezio, De Rerum Natura, II, 1 e ss.
8 Per tali questioni, cfr. P. Giordanetti, M. Mazzocut-Mis, Rappresentare il brutto, Scriptaweb, Napoli 2006; H. Blumenberg, Naufragio con spettatore: paradigma di una metafora dell’esistenza, trad. it. di Francesca Rigotti, il Mulino, Bologna 1985.
9 L. Russo, Neoestetica: un archetipo disciplinare, in “Rivista di Estetica”, anno LI, n.s., 47 (2/2011), pp. 197-209.
10 G. Didi-Huberman, L’Image survivante. Histoire de l’Art et Temps des Fantômes selon Aby Warburgh, Les Éditions de Minuit, Paris 2002; trad. it. a cura di A. Serra, L’immagine inspolta. Aby Warburgh, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte, Bollati Boringhieri, Torino 2006.
11 E.T. Hall, The hidden dimension, Doubleday, New York 1966; trad. it. di M. Bonfantini, La dimensione nascosta, Bompiani, Milano 2001 (1968).
12 J.G. Herder, Plastik: Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions bildendem Traume (“Plastica. Alcune osservazioni su forma e figura a partire dal sogno plastico di Pigmalione”, 1778); ed. a cura di D. Di Maio e S. Tedesco, Plastica, Aesthetica, Palermo 2010, p. 39.
13 Cfr., a tal proposito, le illuminanti osservazioni di S. Tedesco nell’introduzione all’edizione testé citata, soprattutto pp. 15-18.
14 J.J. Winckelmann, Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in Malerei und Bildhauerkunst (1755); ed. it. a cura di M. Cometa, Pensieri sull’Imitazione, Aesthetica, Palermo 2001, p. 30.
15 J.G. Herder, Plastica, cit., pp. 41-44.
16 Ivi, p. 49.
17 Gaetano Giulio Zumbo (Siracusa, 1656-Parigi, 1701), tra i maggiori ceroplasti di ogni tempo, si rese celebre per avere messo a punto un metodo che consentiva lo studio dell’anatomia senza la necessità di far uso dei cadaveri, con un notevole “risparmio” in termini di approvvigionamento di “materia fresca” e d’igiene. La realizzazione di modelli corporei in cera, attraverso la virtuosistica imitazione dei più minuti dettagli fisiologici, permetteva infatti il riutilizzo degli oggetti di studio per un tempo di fatto illimitato. Nacquero così le teste anatomiche del Museo della Specola di Firenze e del Muséum National d’Histoire Naturelle di Parigi, integralmente smontabili, che destarono la meraviglia di tutta la comunità scientifica d’Europa (ma anche molte invidie), e i “Teatrini” con la raffigurazione della Peste, del Morbo gallico e della Vanità della Gloria umana, esempi tra i più sconcertanti per gusto del macabro dell’intera arte barocca. Per Zumbo, cfr. P. Giansiracusa, Antologia degli scritti sull’opera di Gaetano Giulio Zumbo, Siracusa 1988; e Id. (a cura di), Vanitas Vanitatum. Studi sulla ceroplastica di Gaetano Giulio Zumbo, A. Lombardi editore, Siracusa 1991.
18 Per il concetto di “raccapriccio” come paradigma estetico, cfr. F.P. Campione, La regola del Capriccio. Alle origini di una idea estetica, Aesthetica preprint – Supplementa, 27, dicembre 2011, soprattutto al cap. I, § 1, Il gregge e l’orrore.
19 Ercole Lelli (Bologna, 1702-1766), probabilmente il maggiore scultore di pezzi anatomici del Settecento, intrecciò significativamente la professione di anatomista a quella di pittore e scultore. La gran parte della produzione di Lelli è oggi custodita presso il Museo dell’Anatomia di Palazzo Poggi a Bologna, in raffinate teche lignee progettate dallo stesso scultore nel 1742. Per Lelli, cfr. Le cere anatomiche bolognesi del Settecento, Catalogo della mostra, Clueb, Bologna 1981.
20 Clemente Susini (Firenze, 1754-1814) proseguì idealmente la lezione di Zumbo, impiantando nel Museo della Specola fiorentina (a partire dal 1773) una vasta collezione di preparati anatomici in cera straordinariamente realistici. In Susini è evidente però il tentativo di conciliare le ragioni della scienza a quelle della bellezza: una prova ne è la celebre Venerina di Palazzo Poggi, una statua in cera dalle caratteristiche forme neoclassiche “apribile” per ispezionarne gli organi interni. Per Susini, cfr. A. Riva (a cura di), Le cere anatomiche di Clemente Susini dell'università di Cagliari, Ilisso, Nuoro 2007. Per alcune considerazioni simboliche sulla Venerina, cfr. G. Didi-Huberman, OuvrirVénus. Nudité, rêve, cruauté, L’image ouvrante,1, Gallimard, Paris 1999; trad. it. di S. Chiodi, Aprire Venere. Nudità, sogno, crudeltà, Einaudi, Torino 2001.
21 Per l’utilizzo della cera, soprattutto come materiale per il ritratto, il testo classico è quello di J. von Schlosser, Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs. Ein Versuch (1911); ed. it.a cura di P. Conte, Storia del ritratto in cera, Quodlibet, Macerata 2011. In ultimo è possibile consultare F. Simonetti, Sortilegi di cera. La ceroplastica tra arte e scienza, SAGEP, Genova 2012.
22 Cfr. A. Whalley (ed.), Gunther von Hagens’ Body Worlds. The Original Exibition of Real Human Bodies, catalogo della mostra, Arts & Sciences, Heidelberg 2009, p. 244.
23 Su Hirst, in considerazione del rilievo mediatico che hanno acquisito le esposizioni delle sue opere e lo statuto provocatorio che ostentano, la bibliografia è ovviamente amplissima. Mi limito qui a indicare il testo a cura di E. Cicelyn, M. Codognato, M. D’Argenzio, Damien Hirst, catalogo della mostra (Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 31 ottobre 2004-31 gennaio 2005), Electa, Napoli 2004; e D. Hirst, B. Gordon, Manuale per giovani artisti. L’arte raccontata da Damien Hirst, Postmedia, Milano 2004, oltre alla vastissima sitografia disponibile in rete.
24 Per saggiare la declinazione estetica del dolore espresso da questa scultura, sarebbe utile probabilmente individuare una correlazione all’esempio “classico” rappresentato dal Laocoonte. Per questo rimando al saggio fondamentale di S. Richter, Laocoon’s Body and the Aesthetics of Pain: Winckelmann, Lessing, Herder, Moritz, Goethe, Waynes State Up, Detroit 1992.
25 Jean-Antoine Houdon (Versailles, 1741-Parigi, 1828) fu probabilmente il maggiore ritrattista scultoreo del Neoclassicismo, avendo raffigurato praticamente tutti i maggiori personaggi del secondo Settecento, da Voltaire a Benjamin Franklin, da Washington a Rousseau. L’Ecorché in gesso dell’Académie Française, replicato in una pluralità di versioni, rappresentò il modello per definizione della formazione accademica degli artisti di quel tempo. Era stato in realtà modellato per servire da archetipo alla statua di San Giovanni Battista per la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma, realizzata anch’essa in gesso e distrutta nel 1894.
26 Damien Hirst, An Interview, in H.U. Obrist (ed.), Beyond Belief, catalogo della mostra, Other Criteria/White Cube, London 2008, pp. 26-27.
27 Id., citato in Beyond Limits, Sotheby’s at Chatsworth: A Selling Exhibition, catalogo della mostra Sotheby’s, London 2006.
28 G.E. Lessing, Laokoon. Oder: Über die Grenzen der Malerei und Poesie. Mit beiläufigen Erläuterungen verschiedener Punkte der alten Kunstgeschichte (1766); ed. it. a cura di M. Cometa, Laocoonte, Aesthetica, Palermo 1991, p. 31.
29 J.G. Herder, Plastica, cit., p. 51.
30 Sul Pallagonico, la marca formale ed estetica che Goethe individua come costante del Brutto nell’arte siciliana, e che egli vede compiutamente esemplificata dai “mostri” della Villa Palagonia a Bagheria, cfr. F.P. Campione, La cultura estetica in Sicilia nel Settecento, “FIERI – Annali del Dipartimento di Filosofia Storia e Critica dei Saperi”, 2, giugno 2005, § 4, Dal Sublime al Pallagonico, pp. 125-37.
31 P. Brydone, A Tour trough Sicily and Malta in a Series of Letters to William Beckford esq. of Somerly in Suffolk, 2 voll., W. Strahan & T. Cadell, London 1773; ed. it. a cura di V. Frosini, Viaggio in Sicilia e a Malta, Longanesi, Milano 1968, p. 201.
32 Ivi, p. 202.
33 J. Houël, Voyage pittoresque des Isles de Sicile, de Malthe et de Lipari […], 4 voll., Paris, 1782-87; vol. I., p. 70; trad. it. a cura di C. Ruta, Viaggio in Sicilia, Edi.bi.si, Palermo 1999, p. 36.
34 A. Whalley (ed.), Gunther von Hagens’ Body Worlds, cit., p. 256.
35 Per questi aspetti, cfr. L’anatomia tra arte e medicina. Lo studio del corpo nel tardo Rinascimento, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2010.
36 F.J. Wetz, The Dignity of Man, in A. Whalley (ed.), Gunther von Hagens’ Body Worlds, cit., p. 259.
37 A. Whalley (ed.), Pushing the Limits. Encounters with Body Worlds Creator Gunther von Hagens, Arts & Sciences, Heidelberg 2007.