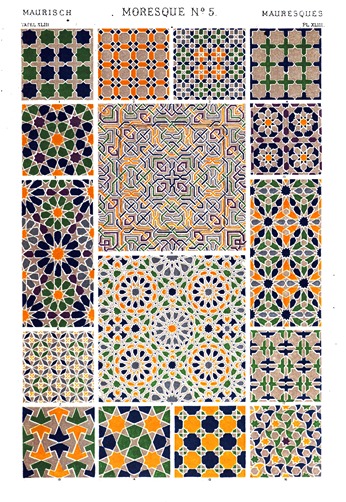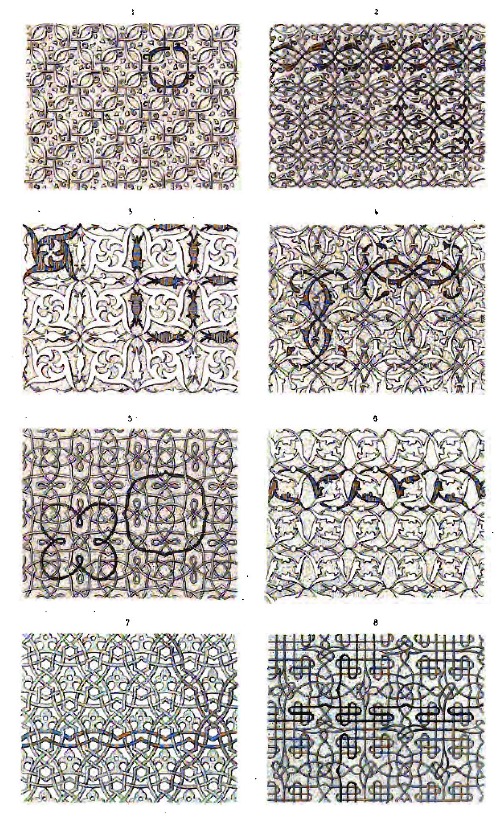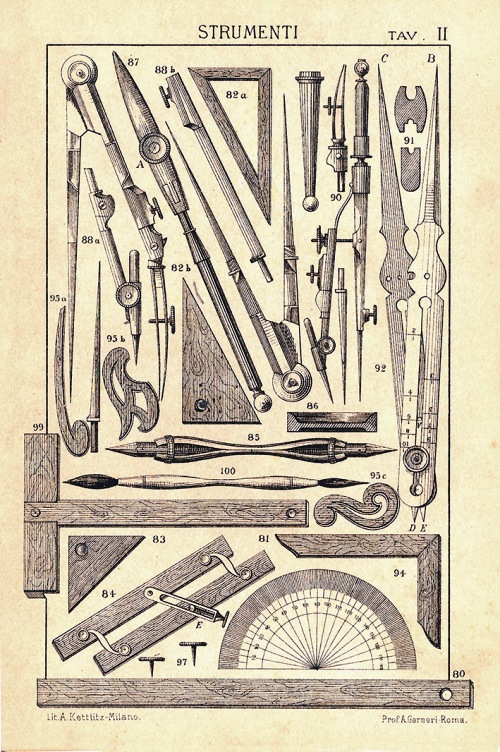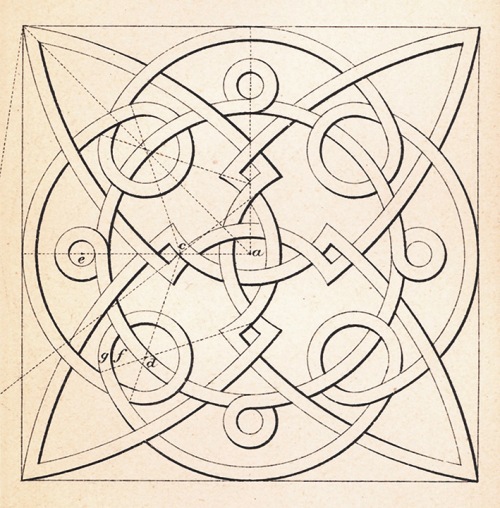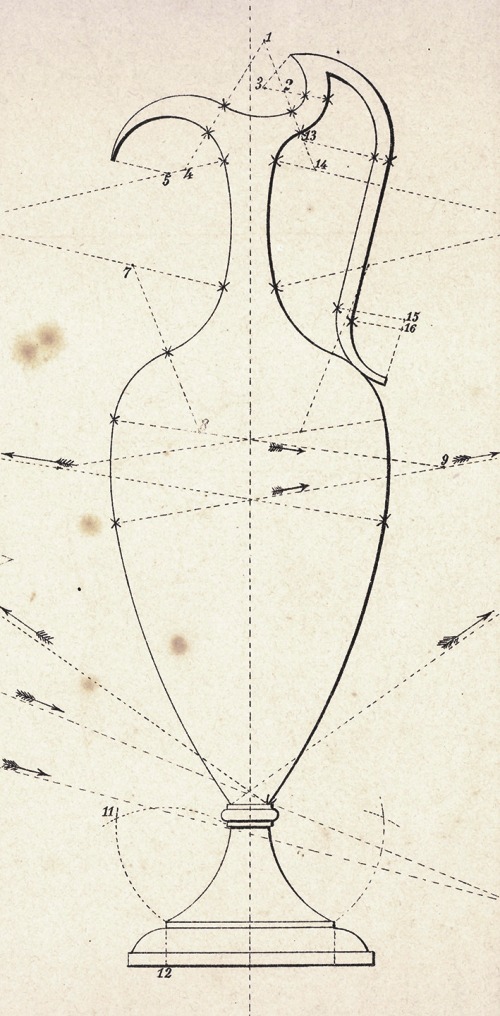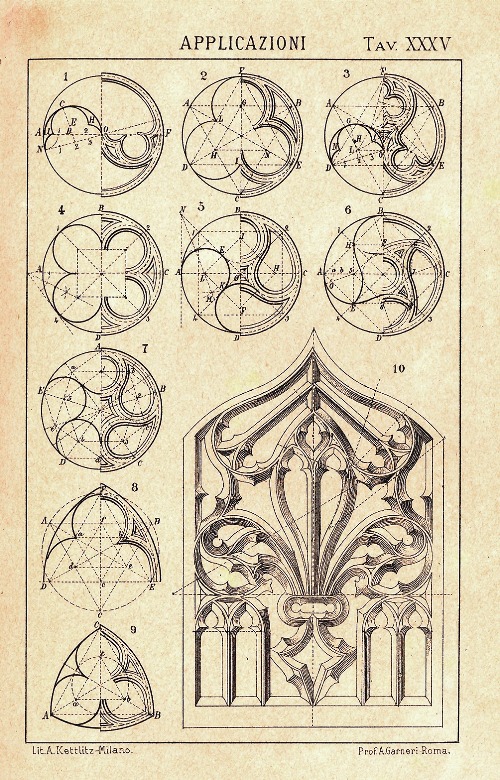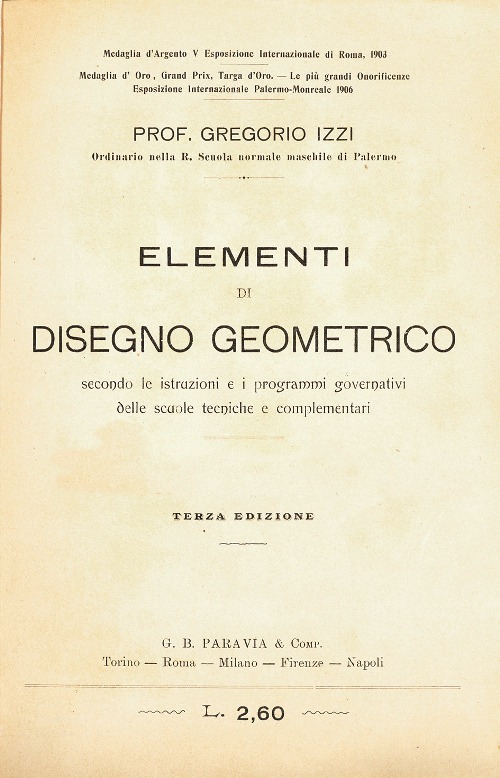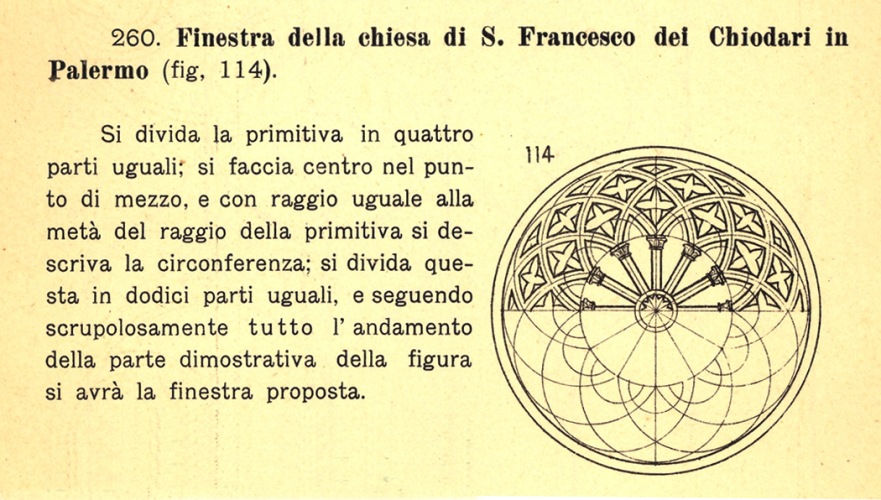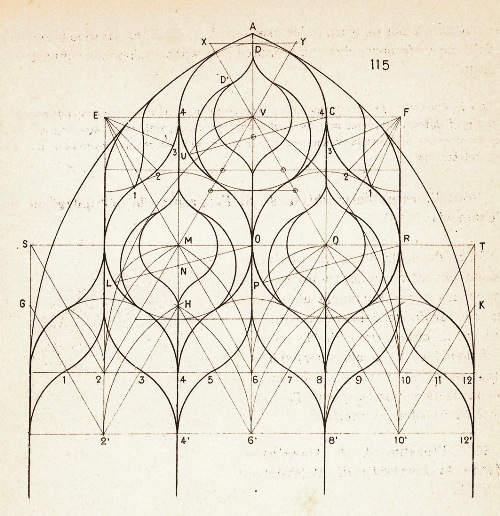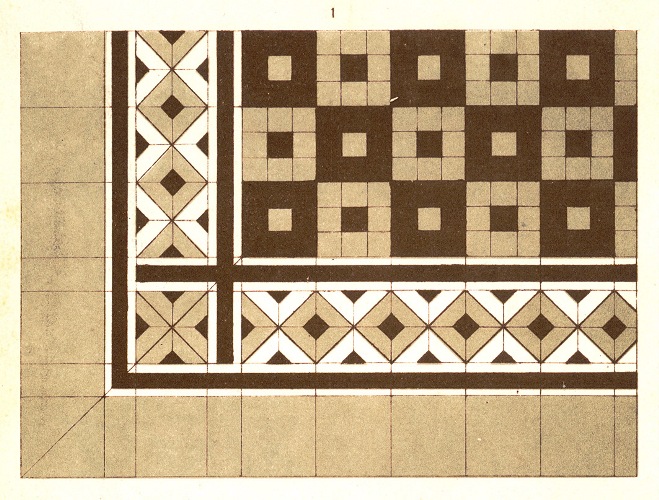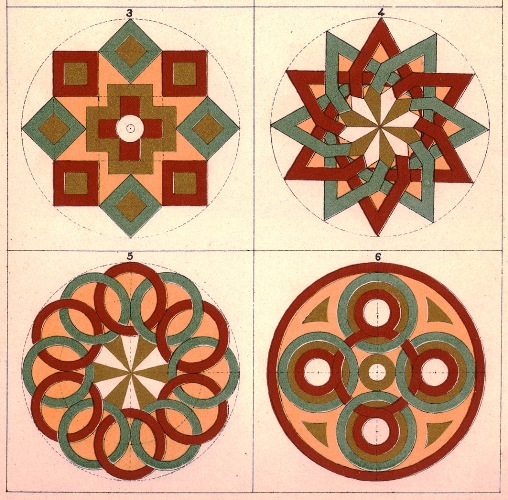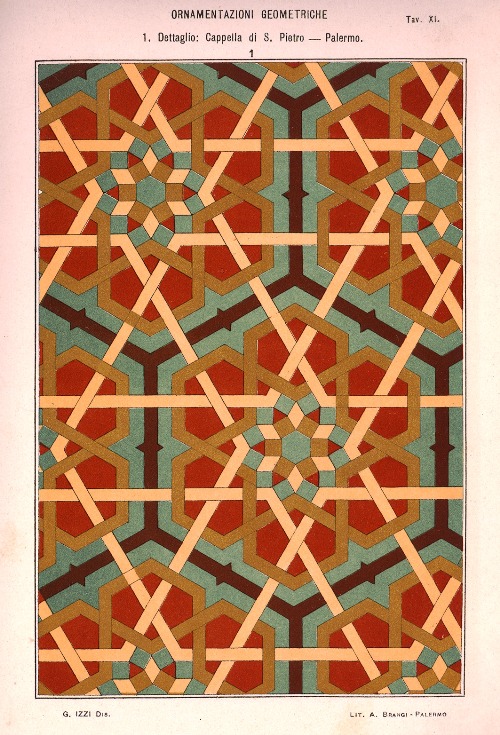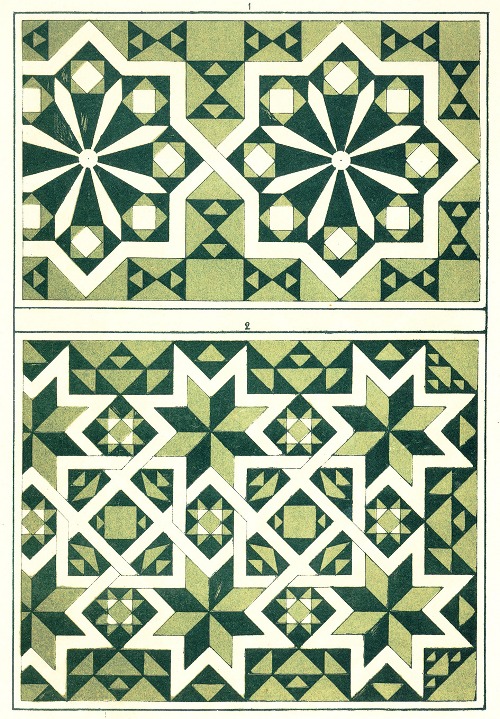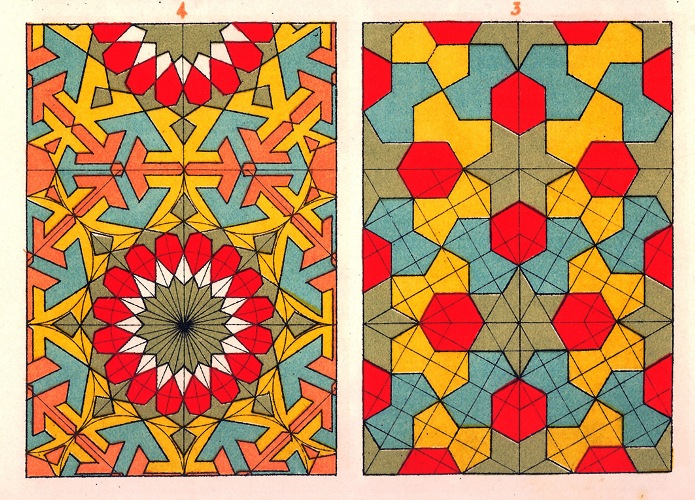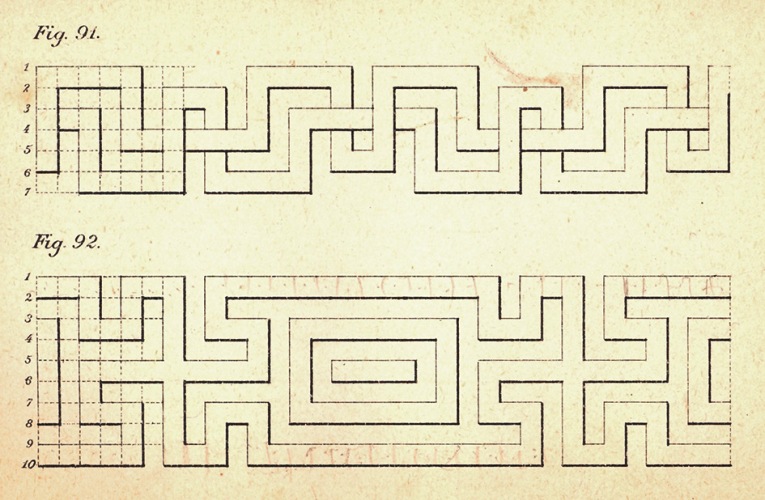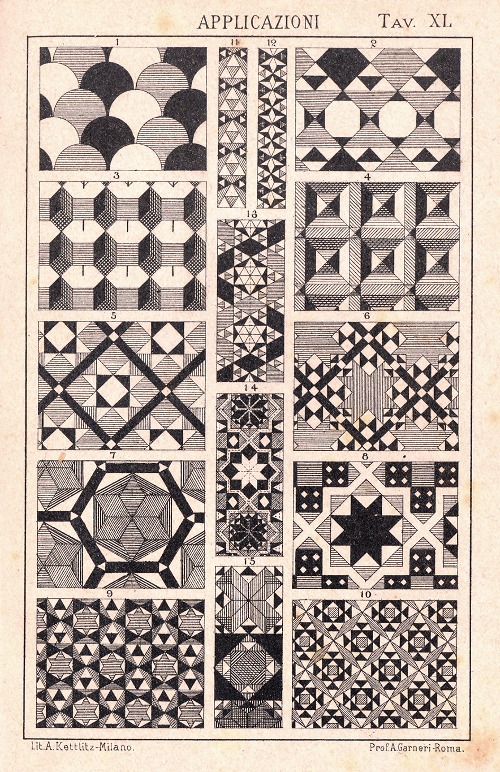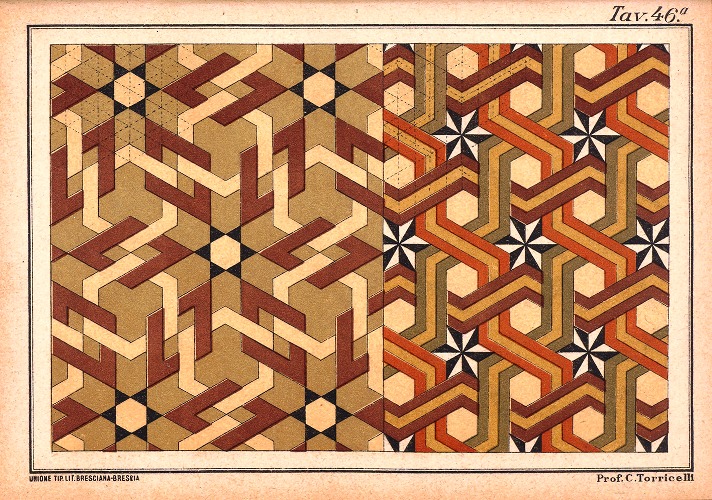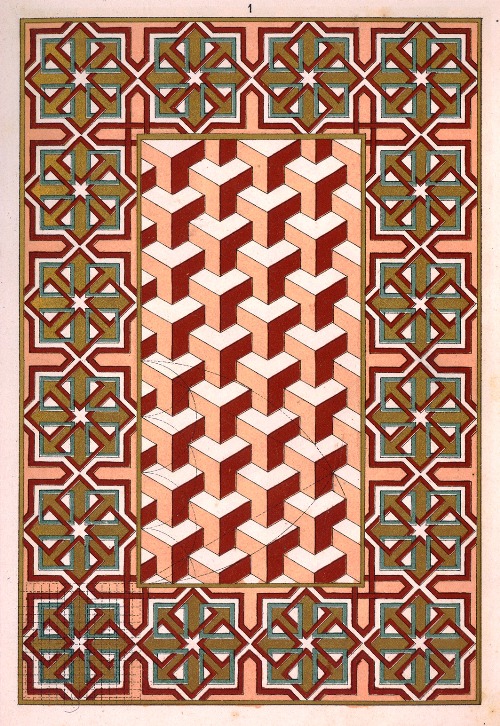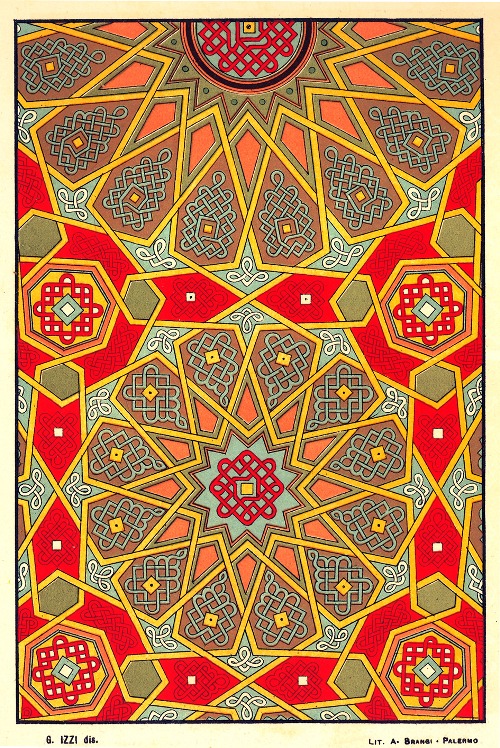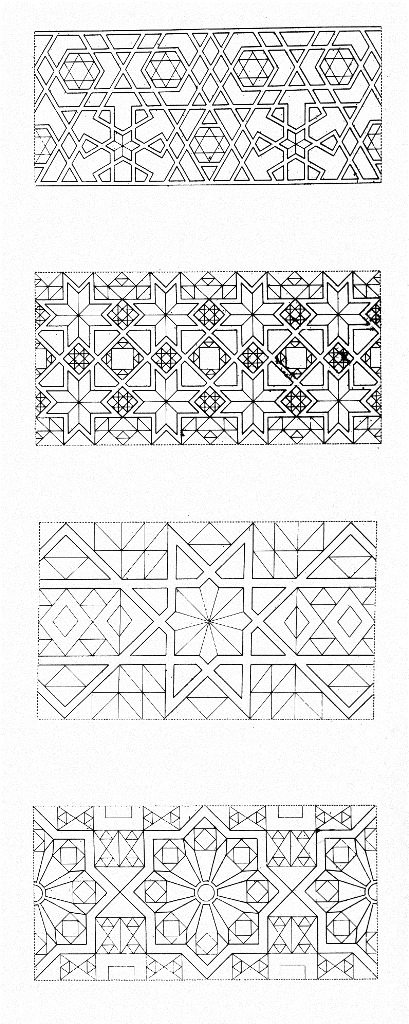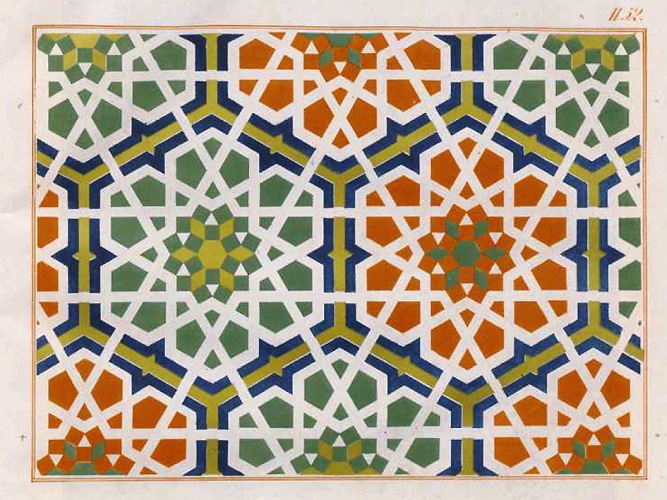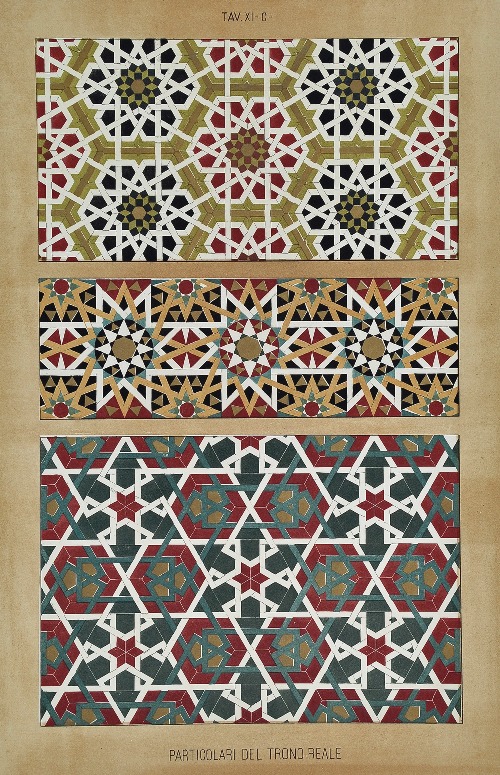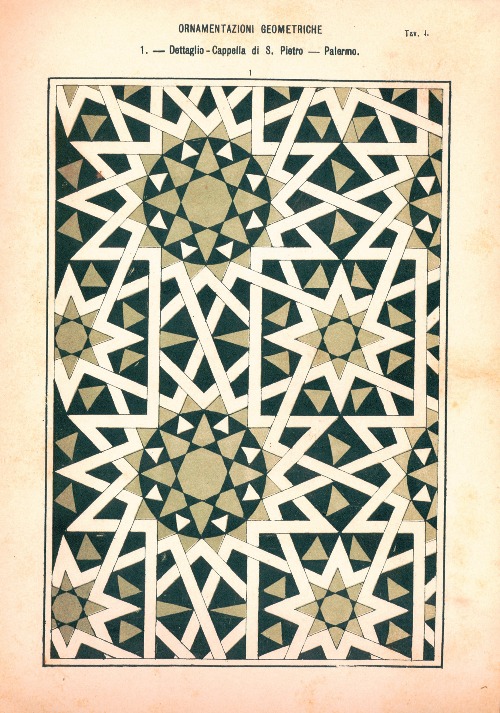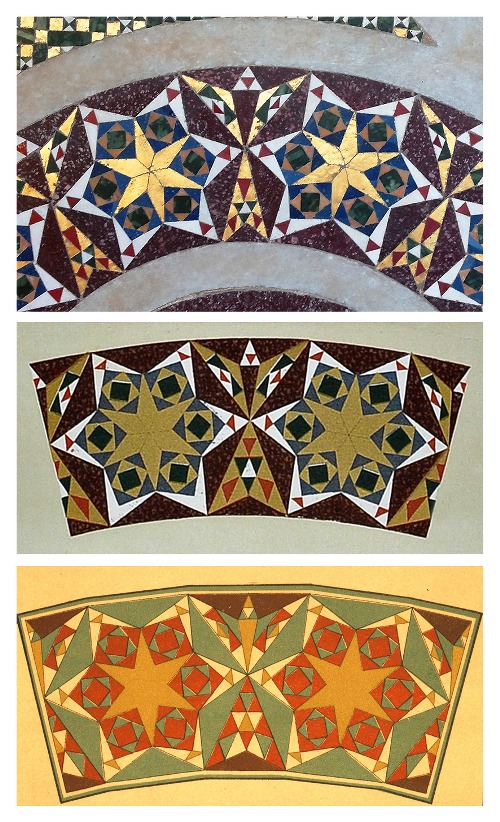Le
complesse
vicende
dell’ordinamento
didattico
nell’Italia
postunitaria
hanno
portato
attorno
al 1870
ad una
febbrile
revisione
dei
programmi
di
studio.
Un
dibattito
fertile
e
faticoso
ha
percorso
gli
ultimi
decenni
del XIX
secolo,
mettendo
in campo
soluzioni
–
talvolta
semplicistiche,
talvolta
illuminate
– che
hanno
stimolato
gli
studiosi
del
periodo
ad una
profonda
verifica
dei modi
di
approccio
alle
varie
discipline,
puntualmente
riflessa
nella
struttura
dei
nuovi
libri di
testo.
Nelle
note che
seguono
si
prenderà
in
considerazione
un’opera
didattica
per il
disegno,
destinato
agli
studenti
delle
scuole
tecniche,
redatto
dal
professore
Gregorio
Izzi[1]
e
pubblicato
a
Palermo
in
diverse
edizioni,
a
partire
dal
1903. La
particolarità
del
volume,
oltre a
quella
di
distinguersi
per la
straordinaria
qualità
delle
tavole
illustrate,
sta nel
proporre,
accanto
ad
esempi
di
ornamentazioni
pavimentali
e musive
generiche
e
decontestualizzate
- come
avveniva
di
consueto
in opere
didattiche
analoghe
- anche
un
importante
numero
di
disegni
riferibili
alle
decorazioni
geometriche
della
Cappella
San
Pietro
del
Palazzo
Reale di
Palermo,
la
cosiddetta
Cappella
Palatina.
L’istruzione
tecnica[2]
in
Italia,
assimilabile
in
qualche
misura
ad un
corso di
studi di
carattere
scientifico,
la cui
struttura
venne
mutuata
dalla
legge
Casati
del 1859
e rimase
sostanzialmente
invariata
sino
alla
riforma
Gentile
del
1923,
prevedeva
che alla
scuola
primaria,
divisa
in due
cicli di
due anni
ciascuno
comuni a
tutti
gli
studenti,
seguissero
altri
due
cicli di
studi,
un primo
ciclo
inferiore
di tre
anni e
un ciclo
superiore,
della
durata
di due o
tre
anni.
Quest’ultimo
era
caratterizzato
da
diversi
indirizzi
e poteva
consentire
l’accesso
all’istruzione
di
livello
universitario.
I
programmi
di
studio e
la
ripartizione
degli
indirizzi
furono
modificati
piuttosto
di
frequente[3],
nel
tentativo
di
strutturare
un
sistema
dell’istruzione
che
rispondesse
alla
rapida
evoluzione
delle
nuove
necessità
educative
ed
occupazionali.
Nell’ambito
dell’istruzione
tecnica,
l’importanza
attribuita
all’esercizio
del
disegno
era
notevole.
L’indirizzo
di
agrimensura
e quello
fisico-matematico[4],
prevedevano
rispettivamente
quattro
e sei
ore
settimanali
di
insegnamento
del
disegno.
Nella
sezione
fisico-matematica,
in
particolare,
si
prevedevano
nei
primi
due anni
del
ciclo
superiore
quattro
ore di
Disegno
ornamentale
a mano
libera
durante
le quali
ci si
dedicava
alla
copia di
ornati e
due ore
di
Disegno
geometrico
ornamentale
in cui
si
prendeva
in
considerazione
la
struttura
compositiva
geometrica
dell’ornamento.
Inoltre
negli
stessi
anni,
all’interno
del
modulo
di
insegnamento
di
Matematiche,
per
altre
due ore
alla
settimana
si
studiavano
anche i
Principii
di
geometria
proiettiva
e
descrittiva[5].
L’insegnamento
nel
corso
dell’ultimo
anno di
scuola
era
dedicato
allo
studio
delle
Forme
dell’architettura
classica
e loro
ornamentazioni.
Era
anche
previsto
che agli
studenti
più
dotati
fosse
concesso
di
iniziare
ad
esercitarsi
nella
composizione
di forme
ed
immagini
decorative.
A
partire
dal
1861,
diverse
commissioni
ministeriali
di
studio –
tra cui
ben
quattro
dedicate
alle
discipline
del
Disegno[6]
–
elaborarono
proposte
dettagliate
di
programma
che
potessero
essere
da guida
per
l’insegnamento.
In
questa
occasione
gli
esperti
strutturarono
le loro
riflessioni
anche
sulla
base
dell’esame
degli
elaborati
di
studio
prodotti
negli
anni
precedenti
e
raccolti
nelle
diverse
scuole
del
territorio
nazionale.
Nel 1869
la
quarta
Commissione
Ministeriale
consegnò
la
Relazione
sulla
riforma
dell’insegnamento
del
disegno
negl’Istituti
tecnici[7],
nella
quale si
ridefinivano
profondamente
i
criteri
didattici,
alla
luce di
un
atteggiamento
consapevolmente
pragmatico.
Gli
esiti
della
consultazione
spingevano
ad una
rottura
con la
tradizione
classicista
che
imperava
nell’insegnamento
del
disegno,
fino al
punto di
proporre
l’eliminazione
dello
studio
degli
ordini
di
architettura
secondo
la
regola
di
Vignola[8].
La
quarta
Commissione
era
presieduta
da
Pietro
Selvatico
Estense[9],
uomo di
grande
personalità,
storico
dell’arte
ed
architetto,
le cui
aggiornate
aperture
di
carattere
europeo
avranno
certamente
orientato
i
lavori.
Nei
programmi
di
studio
per il
disegno
nella
scuola
tecnica
del 1876[10],
direttamente
ispirati
dai
lavori
della
Commissione,
si fa
riferimento
in modo
esplicito
ad opere
di ampio
respiro,
molto
recenti
o
addirittura
appena
pubblicate
da
utilizzarsi
come
modello
per lo
studio
degli
ornati:
La
grammatica
dell’ornamento
di Owen
Jones
del 1856
[fig.
1],
L’ornamento
policromo
di
Auguste
Racinet
pubblicato
dal 1869
al 1873
e la
Teoria
dell’ornamento
di Jules
Bourgoin
[fig. 2]
pubblicato
nel 1873[11].
Alla
metà
dell’Ottocento,
il
dibattito
– acceso
e
stimolante
– che
attraversò
l’Europa
sulla
deplorevole
qualità
del
disegno[12],
portò
infatti
ad una
attenzione
ampiamente
condivisa
per le
tradizioni
straniere,
anche
extraeuropee,
e per la
storia
della
decorazione[13]
che ebbe
un
immediata
ricaduta
nel
campo
editoriale.
Accanto
ad una
serie di
straordinari
repertori
di trame
ed
elementi
decorativi,
pubblicati
spesso
in
edizioni
di
qualità
sopraffina
con il
corredo
di
mirabili
tavole
policrome,
si
collocarono
di
sovente
opere di
carattere
speculativo
nelle
quali si
indagava
sulle
regole e
sulla
teoria
dell’ornamento[14].
La
generale
fascinazione
per i
neostili
in
architettura
favoriva
lo
studio
puntuale
ed il
rilievo
di
gruppi
di
architetture
o di
opere
singole
del
passato
– specie
medioevali
–,
rendendo
disponibili,
attraverso
i
disegni,
informazioni
che sino
a pochi
decenni
prima
sfuggivano
del
tutto
all’attenzione
di
studenti,
studiosi,
progettisti.
In
questo
modo ad
opere
come
quelle
di Jones
– che si
pone in
modo
esplicito
l’obbiettivo
di
tracciare
le
regole
che
sottendono
l’uso
corretto
ed
efficace
dell’ornamento
e di
fornire
un
repertorio
di
riferimento,
esplorando
tempi e
luoghi
lontani
– o al
repertorio
sistematico
di
Racinet
–
mirabilmente
e
fittamente
illustrato
– o
all’approfondimento
di
Bourgoin
sulle
superfici
musive
islamiche
in Les
éléments
de l’art
arabe[15]
–
descritte
con un
linguaggio
grafico
estremamente
sintetico,
attraverso
l’uso
esclusivo
di
sottili
tratti
monocromi
– si
affiancarono,
pur se
in tempi
diversi,
lavori
che come
nell’opera
di Boito[16]
Architettura
del
Medioevo
in
Italia,
o
nell’opera
di
Serradifalco[17]
Del
Duomo di
Monreale
e di
altre
chiese
Siculo
Normanne,
affrontavano
gruppi
omogenei
di
architetture.
Furono
realizzati,
inoltre
studi
monografici,
sostenuti
da
mirabili
campagne
di
rilievo,
come il
lavoro
di De
Dartein[18]
sulla
chiesa
di
Sant’Ambrogio
a Milano
o la
monumentale
opera di
Gravina[19]
sul
Duomo di
Monreale.
Opere di
questo
genere
erano
spesso
frutto
dell’impegno
profuso
da
gruppi
numerosi
di
studiosi
e di
disegnatori.
Di
frequente
le
sottoscrizioni
per
l’acquisizione
delle
risorse
economiche
necessarie
per la
pubblicazione
di opere
simili
si
protraevano
per anni
e non
era raro
che
fosse
necessario
l’intervento
diretto
della
finanza
pubblica.
Ad ogni
modo,
nel
corso
della
seconda
metà
dell’Ottocento
si è
ridefinito
in
Italia,
come in
alcuni
paesi
d’Europa,
un nuovo
standard
per le
pubblicazioni
di
studio
sull’architettura
e sulla
decorazione,
solidamente
fondato
su un
profondo
ripensamento
degli
strumenti
tecnici
e
teorici
del
disegno
e del
rilievo
ed
originato
dalla
spinta
propulsiva
del
diffondersi
maturo e
capillare
dei
principi
della
geometria
descrittiva[20].
Queste
opere,
mentre
costruivano
un
diverso
approccio
alla
storia
dell’architettura
e delle
immagini,
diventavano
il campo
di
sperimentazione
di nuove
tecniche
di
indagine,
di
rappresentazione,
di
applicazione
delle
più
avanzate
tecniche
tipografiche
ed
editoriali.
Come si
diceva,
la
revisione
dei
programmi
di
studio
per la
scuola
tecnica
ebbe una
diretta
ricaduta
sull’editoria
dei
volumi
scolastici.
La
necessità
di
fornire
guide
adeguate
per
l’apprendimento
portò
molti
docenti,
architetti
ed
ingegneri
ad
intraprendere
la
stesura
di testi
di
studio.
Tra
coloro
che
vollero
cimentarsi
in
questa
fatica,
oltre a
giovani
docenti
e
piccoli
professionisti,
vi erano
anche
uomini
di
grande
qualità
ed
impegno
che
ritenevano
col loro
lavoro
di
potere
incidere
direttamente
nell’organizzazione
quotidiana
dei
percorsi
didattici[21].
Negli
ultimi
decenni
dell’Ottocento
in
Italia
furono
pubblicati
alcune
decine
di
volumi
di
questo
tipo,
destinati
ai vari
gradi
della
scuola
tecnica.
Alcuni
autori
articolarono
la loro
offerta
a
seconda
dei
diversi
indirizzi
di
studio,
dando
origine
ad
edizioni
tra loro
lievemente
differenti[22].
Le opere
di
maggior
successo
–
decretato
dalle
vendite
e dai
premi
ottenuti
nelle
varie
esposizioni
nazionali
–
venivano
spesso
aggiornate,
ampliate
e
talvolta
dotate
di un
corredo
iconografico
di
migliore
qualità.
In
questo
panorama
editoriale,
tra i
più
diffusi,
spiccano
i volumi
didattici
di
Augusto
Garneri
[fig.
3],
Giuseppe
Boidi
Trotti,
Alessandro
Antilli,
Cesare
Torricelli[23],
utilizzati
dagli
studenti
dell’intero
territorio
nazionale
grazie
ad una
fitta
distribuzione,
pubblicati
ininterrottamente
per
decenni
senza
che si
perdesse
la loro
sobrietà,
riuscendo
così a
contenere
il
prezzo
di
vendita.
Come
emerge
dal
confronto
di
questi
ed altri
volumi
scolastici,
i libri
di testo
per
l’insegnamento
del
disegno
geometrico
nel
triennio
conclusivo
della
scuola
tecnica
avevano
tutti la
stessa
struttura
e
mostravano
la
medesima
organizzazione
della
disciplina.
Nel
corso
del
primo
anno
venivano
poste le
basi per
lo
studio
del
disegno:
allo
studio
dei
fondamenti
della
geometria
piana –
le
definizioni
degli
enti
geometrici
e la
nomenclatura
delle
varie
figure –
seguiva
l’esame
degli
strumenti
da
disegno,
di cui
veniva
mostrato
l’uso
corretto;
seguiva
l’illustrazione
delle
tecniche
di
tracciamento
più
elementari[24].
Queste
semplici
tecniche
erano di
seguito
applicate
alla
copiatura
di
semplici
disegni
ornamentali,
perlopiù
basati
su
poligoni,
stelle o
semplici
intrecci
[fig.
4]. Nel
corso
del
secondo
anno, si
studiavano
costruzioni
geometriche
più
complesse
utili
per
compiere
operazioni
sulle
aree[25],
si
affrontava
il
disegno
delle
coniche
e di
semplici
curve
meccaniche,
i
raccordi
tra
curve,
le
policentriche
e il
disegno
di
ornamenti
seriali
di una
certa
complessità,
oltre
che i
fondamenti
della
geometria
solida.
Un’applicazione
comune
del
disegno
delle
policentriche
era
generalmente
rappresentato
dal
disegno
del
profilo
curvilineo
dei vasi
[fig. 5][26].
Nel
corso
del
terzo
anno si
studiava
il
metodo
delle
doppie
proiezioni
ortogonali,
le
tecniche
di
riduzione
ed
ingrandimento
dei
disegni,
si
apprendevano
i
fondamenti
dell’architettura
civile,
studiando
generalmente
– pur se
in modo
succinto
– gli
ordini
di
Vignola
(nonostante
– come
si
diceva –
fossero
stati
eliminati
dai
programmi),
si
prendevano
in
considerazione
le
modanature
architettoniche,
la loro
costruzione
geometrica
e gli
effetti
che la
luce
produceva
di esse.
Si
studiavano
infine
ornamentazioni
geometriche
complesse
e si
dedicava
parecchio
tempo al
disegno
dei
trafori
lapidei
applicati
a rosoni
e
finestre
dalla
struttura
piuttosto
articolata.
Da
questo
esame
emergono
sostanzialmente
due
riflessioni.
Si può
osservare,
in primo
luogo,
la
straordinaria
coerenza
del
percorso
di studi
e come
ad ogni
nuova
nozione
corrispondesse
un
efficace
corredo
di
esercitazioni
e di
applicazioni,
compiute
ed
efficaci.
Le più
complesse
esercitazioni
del
terzo
anno
consentivano
di
mettere
in
pratica
tutti
gli
argomenti
affrontati,
proponendo
un’idea
solida e
progressiva
del
sapere
grafico
e delle
sue
potenzialità.
In
secondo
luogo,
gli
esempi
più
evoluti
riportati
nei vari
libri
per
l’insegnamento
mostrano,
nel
complesso,
una
precisa
attenzione
per la
storia
dell’architettura
e
dell’ornamento
di
periodo
medievale.
Gli
ornamenti
studiati
nel
corso
del
terzo
anno
sono
spesso
tratti
dalla
tradizione
bizantina,
islamica
o
arabo-normanna
ed i
trafori
lapidei
[fig. 6]
sono di
chiaro
gusto
gotico.
La
prima
edizione
del
volume
di
Gregorio
Izzi,
Corso
elementare
di
disegno
geometrico
per le
scuole
secondarie,
tecniche,
normali
e
industriali,
fu dato
alle
stampe
nel 1903
per le
edizioni
palermitane
di
Orazio
Fiorenza.
Il
volume
di 148
pagine,
con 22
tavole
fuori
testo[27],
accoglieva
i
materiali
di
studio
necessari
per il
corso di
disegno
nel
triennio
superiore
della
scuola
tecnica.
Izzi,
sicuro
della
qualità
del
proprio
lavoro,
ebbe
cura di
spedire
il
volume
ad
importanti
rappresentanti
della
cultura
ed allo
stesso
Ministro
dell’Istruzione;
decise
inoltre,
con
successo,
di
proporne
l’esposizione
presso
varie
esposizioni
campionarie[28].
All’edizione
del 1903
fece
seguito
un’edizione
nel
1905,
programmata
in tre
volumi,
quindi
ridotta
in
fascicoli
più
agili. A
quanto è
dato di
sapere,
di
quest’edizione
vide la
luce
esclusivamente
il terzo
volume,
probabilmente
il più
efficace,
visto il
corredo
di
splendide
illustrazioni
fuori
testo[29].
Nel 1908
fu
pubblicata
nuovamente
un’edizione
completa
[fig.
7],
rilegata
con cura
dalla
premiata
legatoria
Caneba,
di
Palermo[30].
Quest’edizione,
di 166
pagine,
accoglieva
anche 32
tavole
fuori
testo,
cromolitografate
presso
la
stamperia
palermitana
di
Andrea
Brangi.
Nonostante
in
copertina
fosse
indicato
l’editore
Fiorenza,
il
frontespizio
del
volume
rivela
che
questa
terza
edizione
dell’opera
era
edita –
e
distribuita
– dalla
casa
editrice
Paravia[31].
Una
nuova
edizione
del
1914, in
un unico
volume,
tornò ad
essere
pubblicata
da
Orazio
Fiorenza.
Anche
l’ultima
edizione
del
1921,
divisa
in
fascicoli,
venne
pubblicata
dall’editore
palermitano.
Nonostante
tra le
varie
edizioni
vi siano
alcune
differenze
– di
alcune
delle
quali si
dirà in
seguito
– la
struttura
del
volume
di
Gregorio
Izzi,
netta e
cristallina,
si
mantiene
inalterata
nel
corso
dei
vent’anni
di
edizione.
Se lo
schema
generale
cui si
fa
riferimento
è lo
stesso
descritto
per le
altre
analoghe
opere
didattiche,
tracciato
in
assoluto
ossequio
dei
programmi
ministeriali
di
insegnamento,
non si
possono
sottacere
alcune
peculiarità
di
grande
interesse.
In primo
luogo,
la
maggior
parte
delle
oltre
settecento
illustrazioni
in nero,
piuttosto
che
essere
raccolta
in
tavole
poste
alla
fine del
volume –
come
avviene,
ad
esempio,
nelle
opere di
Boidi,
Garneri
e
Antilli
– si
accompagna
al
testo.
In
questo
modo, a
tutto
vantaggio
dell’efficacia
didattica,
la
lettura
è
immediatamente
supportata
dall’esame
delle
figure.
Inoltre
Izzi
avvicenda
fittamente
e di
continuo
l’acquisizione
di nuove
nozioni
o di
nuove
tecniche
di
tracciamento
con
esercizi
applicativi
evitando
di
separare
questi
due
aspetti
strettamente
complementari
nel
percorso
di
apprendimento.
La
parte
dedicata
al terzo
anno
vede
alternarsi
lo
studio
della
geometria
solida
con
quello
delle
più
complesse
curve
meccaniche.
La
trattazione
degli
ordini
di
architettura,
svolta
con
sintesi
stringate
ma
efficaci
sulla
“regola”
di
Vignola,
precede
il
disegno
delle
sagome e
i più
complessi
problemi
di
tracciamento
degli
archi e
delle
finestre
con
ornamenti
polilobati
a
traforo.
Il
volume è
chiuso
da
alcune
pagine
in cui
si
forniscono
gli
elementi
basilari
del
disegno
in
prospettiva.
Nella
trattazione
delle
finestre
e delle
«rose
architettoniche»[32]
Izzi
mostra
attenzione
per
alcuni
esempi
dell’architettura
palermitana.
Riporta,
infatti,
le
regole
di
costruzione
grafica
della
«finestra
della
chiesa
di S.
Francesco
dei
Chiodari
in
Palermo»
[fig. 8][33],
seguite
dall’analisi
grafica
e dalla
costruzione
della
mirabile
«Finestra
di A.
Gaggini.
Palazzo
Arcivescovile
di
Palermo»
[fig. 9][34].
Nel
primo
caso –
graficamente
più
semplice
– il
disegno
analitico
si
affianca
all’immagine
definitiva.
Nel
secondo
caso la
costruzione,
descritta
ordinatamente
nel
testo, è
talmente
complessa
da non
potere
essere
rappresentata
se non
con un
tratto
“a filo
di
ferro”.
I
due
fascicoli
di
tavole a
colori
fuori
testo
legate
al
volume,
da
sedici
facciate
ciascuna,
sono
dedicati
esclusivamente
all’illustrazione
degli
ornamenti
geometrici.
Il primo
contiene
i
disegni
di
alcuni
pavimenti
con
bordura
[fig.
10], una
serie di
stelle
poligonali
e di
rosette
[fig.
11] ed
una
serie di
superfici[35].
Altri
ornamenti
sono
individuati
come
dettagli
della
«Cappella
S.
Pietro
di
Palermo»
[figg.
12 e
13].
Anche il
secondo
fascicolo,
posto
alla
fine del
volume,
riporta
esempi
generici
di
ornamentazione
[fig.
14] cui
si
affiancano
altre
immagini
di
superfici
musive
della
Cappella
Palatina.
In tutte
le
tavole
si
riportano
in basso
i nomi
degli
autori[36]:
Gregorio
Izzi
come
disegnatore
ed
Andrea
Brangi
come
litografo.
Come è
stato
scritto
in altre
occasioni[37],
attorno
alla
metà del
secolo a
Palermo
si
impianta
una
solida
tradizione
cromolitografica
che ha
sostenuto,
nel
corso di
alcuni
decenni,
la
realizzazione
di una
serie di
opere
editoriali
di
straordinaria
qualità
tipografica.
Per la
stampa
dell’opera
sul
Duomo di
Monreale
di
Domenico
Benedetto
Gravina
fu
coinvolto
Giorgio
Frauenfelder,
abile
collaboratore
della
litografia
napoletana
Richter
& Co.,
il quale
per
alcuni
anni si
trasferì
a
Palermo
per dare
corso al
lavoro
di
preparazione
delle
lastre.
La
presenza
attiva
di
Frauenfelder
in città
consentì
ad una
intera
generazione
di
tipografi
– tra
cui
anche
Andrea
Brangi –
di
estendere
il
proprio
panorama
tecnico
e
professionale.
Un
confronto
tra i
modi di
rappresentare
gli
ornamenti
geometrici
nei più
diffusi
volumi
per la
didattica
nella
seconda
metà
dell’Ottocento
può
aiutarci
a
comprendere
l’eccezionalità
del
lavoro
di
Gregorio
Izzi.
Come si
è già
ricordato,
in
ciascun
volume
sono
riportati
una
serie di
schemi
grafici
facilmente
applicabili
nella
realizzazione
di
mosaici,
singole
mattonelle
e nella
decorazione
di carte
o
pareti.
Perlopiù
questi
schemi –
spesso
desunti
da opere
di
respiro
più
ampio
come
quelle
di
Jones,
di
Racinet
o di
Bourgoin
già
citate –
venivano
riportati
privi di
un’indicazione
che
potesse
contestualizzarne
l’origine.
Generalmente
solo
nelle
opere
maggiori,
come le
grandi
‘enciclopedie’
dell’ornamento,
venivano
indicate
con
ordine
le fonti
delle
illustrazioni,
come
accade
per
Racinet
e per
Jones, e
come
accadrà
anche in
seguito,
nei
repertori
della
fine del
secolo[38].
Nel caso
quindi
di
disegni
realizzati
per la
didattica
della
scuola
tecnica,
se si
eccettua
qualche
generica
indicazione
nelle
tavole
dei
volumi
di
Garneri[39],
in
generale
le trame
geometriche
riprodotte
sui
volumi
costituivano
per lo
studente
esempi
astratti,
avulsi
dal
mondo
della
realtà,
connaturati
sostanzialmente
alla
logica
dell’esercizio
grafico.
Nella
maggior
parte
dei casi
i volumi
per lo
studio
del
disegno
erano
piccoli
libri in
sedicesimo,
che
misuravano
circa 10
x 15
centimetri.
Le
tavole
erano
stampate
in
bianco e
nero con
tecnica
litografica.
L’uso
del solo
inchiostro
nero
[fig.
15]
limitava
fortemente
la resa
delle
trame
più
complesse,
in cui
aumentavano
i
contatti
tra le
regioni
adiacenti[40].
Non
essendo
in ogni
caso
sufficiente
l’uso
esclusivo
del nero
sullo
sfondo
bianco
per il
disegno
degli
ornati,
si
ricorreva
a toni
intermedi,
che
venivano
resi con
tratteggi,
più o
meno
fitti,
che
suggerivano
le
diverse
tonalità
di
grigio
[fig.
16].
Spesso i
disegni,
affollati
nelle
piccole
tavole,
erano
ridotti
ai
limiti
della
leggibilità.
Questo
modo di
trattare
le
immagini
aveva
certamente
una
motivazione
di tipo
economico,
tutt’altro
che
irrilevante
nella
redazione
di libri
di testo[41].
Le
piccole
pagine
del
volume
di
Cesare
Torricelli
[fig.
17]
stampate
in
policromia
rappresentano
un raro
esempio
di gusto
ed
equilibrio.
Le belle
cromolitografie
a cinque
colori,
realizzate
presso
l’Unione
Tipolitografica
Bresciana,
saranno
state
una
fertile
fonte
d’ispirazione
per
diverse
generazioni
di
studenti.
Confrontando
le
tavole
disegnate
da Izzi
e
litografate
da
Brangi
con
questi
esempi,
anche i
più
pregevoli,
si vede
come
esse
riuscissero
nettamente
a
distinguersi
nel
panorama
generale.
Le
tavole
monocromatiche
fuori
testo di
Izzi non
facevano
ricorso
al
tratteggio
per la
resa dei
mezzitoni,
ma
utilizzavano
campiture
piene
affiancate
alle
stesse
tinte
desaturate,
come
avveniva
per le
tavole
in bruno
e in
verde.
Le
tavole a
colori
erano
realizzate
con
cinque
tinte
[fig.
18]. Il
colore
rosa
pallido
costituiva
lo
sfondo
delle
trame
ornamentali,
lasciando
così la
possibilità
di
utilizzare
il
bianco
della
carta
per
campire
gli
elementi
più
chiari.
Il
rosso,
il verde
e l’oro
consentivano
di
differenziare
le
diverse
parti e
utilizzando
dei
sottili
filetti
neri si
delimitavano
i vari
contorni.
Nelle
tavole
prive di
campiture
dorate,
le
costruzioni
geometriche
ed i
contorni
dei
singoli
elementi
erano
stampati
in nero
e le
varie
campiture
con il
celeste,
il rosa,
il
giallo
ed il
grigio
[fig.
19].
Anche ad
un esame
superficiale
si vede
come,
per
dimensione
e
qualità
delle
singole
immagini,
per
l’uso
dell’inchiostro
dorato e
per la
ineguagliabile
precisione
nella
stampa,
le
tavole
del
volume
di Izzi
sembrino
appartenere
più ad
uno dei
grandi
repertori
dell’ornamento
che ad
un
semplice
testo
didattico.
Come si
diceva,
accanto
alla
tipica
schiera
di
ornati
generici,
nel
libro di
Izzi si
trova
una
notevole
quantità
(circa
la metà)
di
disegni
nelle
tavole
fuori
testo
che
illustrano
dettagli
della
Cappella
Palatina
di
Palermo.
Questo
aspetto
– forse
più
delle
considerazioni
di
ordine
tipografico
fatte in
precedenza
– sembra
avvicinare
questo
lavoro
didattico
alle
grandi
opere
ottocentesche
e, come
si
vedrà,
ciò non
avviene
per
caso.
Non è
possibile
in
quest’occasione
ricostruire
la
storia
completa
dei
rilievi
della
Cappella
Palatina
palermitana.
Occorre
però
ricordare
come,
già
nella
prima
metà
dell’Ottocento,
Hittorff
e Zanth
nell’Architettura
Moderne
de la
Sicile
del 1835
avessero
dedicato
ben
quattro
tavole
alla
Cappella[42]
– una
pianta,
due
sezioni
trasversali,
una
sezione
longitudinale,
il
candelabro,
alcuni
dettagli
e ben
otto
trame
musive
[fig.
20],
fortemente
stilizzate
– e come
solo tre
anni
dopo,
nel
1838,
Serradifalco
in Del
Duomo di
Monreale
ed altre
chiese
arabo-normanne[43]
abbia
riservato
tre
tavole
al
monumento,
illustrandolo
con una
pianta,
due
sezioni
trasversali
ed una
sezione
longitudinale.
L’interesse
per la
Cappella
emerge
anche
nelle
opere
dedicate
esclusivamente
allo
studio
dell’ornamento
in cui
sono
riportati
i
rilievi
di
alcune
superfici
musive.
È il
caso del
lavoro
di
Friedrich
Maximilian
Hessemer,
Arabische
und
alt-italienische
Bau-Verzierungen[44],
del
1842,
che
dedica
due
tavole
policrome
al
disegno
di
quattro
complessi
decori
musivi
della
Cappella
[fig.
21]. Lo
stesso
Racinet[45],
in una
tavola
della
sua
opera,
riporta,
oltre a
tre
ornati
musivi
del
Duomo di
Monreale
ed uno
del
Duomo di
Salerno,
ben
dodici
trame
geometriche
della
Cappella
Palatina
[fig.
22].
Nel 1872
venne
data
alle
stampe
La
Cappella
di S.
Pietro
nella
reggia
di
Palermo[46],
un’opera
poderosa
con
testi di
Michele
Amari,
Saverio
Cavallari,
Luigi
Boglino,
Isidoro
Carini,
illustrata
con 68
tavole
di
grande
formato
disegnate
e
cromolitografate
da
Andrea
Terzi.
L’opera
è del
tutto
paragonabile
a quella
già
citata
sul
Duomo di
Monreale
di
Gravina,
pubblicata
tra il
1859 ed
il 1870.
Il
lavoro
di Terzi
– che da
solo
meriterebbe
un’attenzione
che in
questa
sede non
è
possibile
riservargli
– è
praticamente
coevo
all’opera
di
Gravina
e gli
ambienti
in cui
questi
due
straordinari
lavori
ebbero
origine
sono
strettamente
collegati.
La
struttura
delle
due
opere è
analoga,
come
anche la
qualità
delle
tavole
litografiche
al
tratto,
con
fitte
campiture
a
tratteggio,
e
cromolitografiche,
con
l’uso
generoso
dell’inchiostro
dorato
[fig.
23],
tutte
realizzate
con
profonda
attenzione
alla
forma
dell’architettura
ed alle
superfici
musive,
sia
figurate
che
geometriche.
Non vi è
alcun
dubbio
che, per
il suo
lavoro
sulla
Cappella,
Andrea
Terzi[47]
abbia
utilizzato
l’esperienza
maturata
con
Gravina.
Terzi –
assieme
a Paolo
di
Giovanni,
Michelangelo
Giarrizzo,
Giuseppe
Patricolo,
Achille
Albanese,
Carmelo
Giarrizzo
e
Giovanni
Cammarata
–
partecipò
alla
stesura
dei
disegni
del
Duomo di
Monreale.
Da
giovane,
ancora
diciassettenne,
educato
al
disegno
dallo
stesso
Gravina,
Terzi
ebbe
modo di
riscattare
la
propria
umile
origine
dando
prova
del suo
grande
talento
e del
suo
interesse
per il
disegno[48].
Nel
1872,
quando
diede
alle
stampe
il
volume
sulla
Cappella
Palatina,
Terzi
aveva
trent’anni
e
affrontava
nella
piena
maturità
delle
sue
forze un
lavoro
faticoso
e
complesso.
Le
tavole
de La
cappella
S.
Pietro
sono
quasi
tutte
firmate[49]
da
Terzi.
Nell’introduzione
al testo
e nella
stesura
dei
diversi
saggi
non
viene
ricordata
la
partecipazione
di altri
disegnatori
al
lavoro
di
rilievo,
disegno
e
trasferimento
litografico
delle
tavole.
Per la
realizzazione
delle
tavole
sul
Duomo di
Monreale,
hanno
lavorato
per anni
con
impegno
pieno
almeno
otto
diversi
disegnatori,
alcuni
dei
quali di
notevole
esperienza.
È
possibile
immaginare
che
Andrea
Terzi,
da solo,
nel
volgere
di pochi
anni,
avrebbe
potuto
portare
a
termine
un’opera
complessa
ed
estesa
come il
rilievo,
il
disegno
e la
preparazione
alla
stampa
di
un’opera
come
quella
sulla
Cappella?
Anche
come
litografo
Terzi
avrebbe
dovuto
svolgere,
in tempi
brevi,
un
lavoro
improbo
e
vertiginoso.
Anche se
alcune
tavole
sono
state
litografate
da
Frauenfelder[50],
nella
quasi
totalità
dei casi
è
indicato
come
litografo
lo
stesso
Terzi
assieme
al solo
Andrea
Brangi
come
litografo
e
stampatore,
senza
fare
alcun
cenno ad
altri
collaboratori.
Un
confronto
serrato
tra le
tavole
dell’opera
di Terzi
e quelle
del
volume
di Izzi
può
suggerire
alcune
riflessioni.
Le
tavole
dedicate
da Izzi
all’illustrazione
dei
mosaici
della
Palatina
sono
quattro
nel
primo
fascicolo
(le
tavole
X, XI,
XII e
XVI,
delle
quali
solo le
prime
due a
colori
con
l’uso
dell’inchiostro
dorato e
le altre
due
stampate
con due
toni
della
stessa
tinta
bruna) e
quattro
nel
secondo
fascicolo
(le
tavole
I, IV, V
e VIII,
tutte in
verde,
con due
toni
dello
stesso
inchiostro).
La
misura
di
ciascuna
tavola,
che
coincide
perfettamente
con la
pagina
del
volume,
è di
15,5 x
22
centimetri.
In
alcune
di esse,
come
nella XI
e XVI
del
primo
fascicolo
e nella
I del
secondo,
si
riporta
un’unica
trama
geometrica
[fig.
24][51],
mentre
nelle
altre si
riporta
un
numero
maggiore
di
disegni,
sino a
quattro
come
nell’VIII
del
secondo
fascicolo.
In
totale
si
riportano
diciassette
disegni
degli
ornati
musivi
della
Palatina,
di cui
tre in
policromia.
Gli
stessi
disegni
con lo
stesso
taglio e
le
stesse
identiche
dimensioni,
trovano
spazio
nelle
tavole
dell’opera
di
Terzi.
Anche ad
un
confronto
attento
e
ravvicinato
si vede
che non
si
tratta
di
disegni
simili,
magari
molto
somiglianti,
ma
comunque
di
rappresentazioni
differenti
degli
stessi
tessuti
musivi.
Si
tratta
proprio
degli
stessi
disegni.
I
complessi
mosaici
della
Cappella,
creati
utilizzando
tessere
e
frammenti
lapidei
di
dimensioni
minime,
ovviamente
–
nonostante
la cura
profusa
e la
grande
abilità
degli
artigiani
mosaicisti
–
proprio
per le
caratteristiche
fisiche
delle
pietre
dure e
delle
tessere
vitree
utilizzate,
non
potevano
essere
realizzati
con una
precisione
geometrica
assoluta.
Per
converso,
la
trascrizione
della
forma
del
mosaico
in uno
schema
geometrico
nitido,
in cui
ogni
incertezza
tecnica
viene
eliminata
per
rappresentarne
la
struttura
in modo
chiaro,
necessita
di un
intervento
complesso
e
consapevole.
Questa
necessaria
‘traduzione’
si
accompagna
necessariamente
ad una
serie di
semplificazioni
grafiche
che
consentono,
in modo
pressoché
univoco,
di
identificare
la
“mano”
del
disegnatore.
Un’altra
forma di
semplificazione
è data
dalla
riduzione
del
numero
dei
colori
del
mosaico
disegnato
rispetto
a quello
reale.
La
trasformazione
delle
tinte,
oltre a
costituire
una
necessità
per il
contenimento
delle
spese
tipografiche,
permette
di
comporre
tavole
di
grande
chiarezza
narrativa.
Queste
semplificazioni,
ovviamente,
sono
frutto
di
scelte
personali,
spesso
drastiche,
e
rivelano
con
precisione
la
personalità
e lo
stile
sia del
disegnatore
che del
litografo.
Da
questo
punto di
vista
non
esiste
alcun
dubbio
che le
diciassette
trame
geometriche
della
Cappella
Palatina
riportate
da Izzi
nelle
sue
tavole
siano
delle
riedizioni
di
alcuni
schemi
geometrici
pubblicati
in
cinque
tavole
del
volume
di
Terzi,
ovviamente
ricomposti
e
reimpaginati
in modo
differente[52].
Si
confronti,
a puro
titolo
di
esempio,
la
fotografia
del
bordo di
una
girale
del
Trono
Regio
con il
disegno
tratto
dalla
tavola
XI B
dell’opera
di Terzi
con la
figura 3
della
tavola X
del
volume
di Izzi
[fig.
25]. Si
vedrà
che gli
elementi
di
contatto
tra le
varie
stelle a
sei
punte,
introdotti
per
potere
assorbire
la
deformazione
della
corona
circolare,
sono
ripartiti
in
diverse
aree
triangolari.
La
geometria
di
questi
triangoli
nel
mosaico
reale
non è
immediatamente
chiara.
Le
singole
figure
non sono
riconoscibili
come
triangoli
notevoli
(equilateri,
rettangoli
o altro)
e nel
disegno
di
Terzi,
di
conseguenza,
vengono
trascritti
come
triangoli
scaleni,
senza
che
abbiano
grande
somiglianza
con
quelli
reali.
Per
potere
tracciare
un
disegno
di
questo
tipo,
era
indispensabile
giungere
ad una
schematizzazione
geometrica
delle
forme e
quella
proposta
da
Terzi,
pur se
imprecisa,
appare
comunque
convincente.
Nel
disegno
di Izzi,
la
trascrizione
geometrica
utilizzata
è
esattamente
la
stessa
ed i due
disegni
risultano
perfettamente
sovrapponibili.
Diversi
sono i
colori
ma
identico
è lo
schema
utilizzato.
Potrebbe
apparire
strano,
a questo
punto,
che lo
stesso
disegno
sia
stato
firmato,
nelle
due
diverse
opere,
coi nomi
di due
autori
differenti.
Come si
è detto,
però, è
molto
improbabile
che
Terzi
abbia
potuto
condurre
il
lavoro
di
rilievo,
di
disegno
e di
trascrizione
delle
immagini
tutto da
solo. È
possibile
e che la
scelta
di non
indicare
i nomi
dei
collaboratori,
ma solo
quella
del
‘regista’
dell’operazione,
fosse
una
scelta
di
carattere
editoriale.
Tra i
collaboratori
di
Terzi,
attorno
al 1870,
deve
esserci
stato
anche lo
stesso
Gregorio
Izzi,
altrimenti
non si
potrebbe
spiegare
come
quest’ultimo
avrebbe
potuto
intestare
a se
stesso
la
paternità
di quei
disegni,
essendo
esposto
ad
ambienti
in cui –
come
all’interno
della
litografia
di
Andrea
Brangi –
le
vicende
delle
singole
tavole,
pur se a
trent’anni
di
distanza,
potevano
essere
ancora
note.
L’opera
di Terzi
inoltre,
adesso
rara
anche
presso
il
mercato
antiquario,
alla
fine
dell’Ottocento
era
piuttosto
famosa.
Era
stata
premiata
nel 1873
all’Esposizione
Universale
di
Vienna e
nel 1878
a quella
di
Parigi.
Per il
suo
lavoro
sulla
Cappella
S.
Pietro,
Terzi
nel 1877
era
stato
proposto
per il
cavalierato
dall’allora
Ministro
per
l’Agricoltura,
Salvatore
Majorana
Caltabiano.
Negli
anni in
cui Izzi
pubblica
e
pubblicizza
i suoi
volumi,
spedendoli
anche al
Ministero,
Andrea
Terzi
era in
piena
attività,
abitava
a Roma e
– anche
attraverso
la
brillante
carriera
dei due
figli[53]
–
manteneva
un
contatto
fitto
con
l’ambiente
dei
disegnatori
scientifici,
pubblicitari
e con
l’editoria
del
tempo.
Sembra
probabile
che, in
occasione
della
pubblicazione
del suo
volume
didattico,
d’accordo
con
Brangi,
Izzi
abbia
rispolverato
i suoi
vecchi
lavori,
pubblicandoli
–
finalmente
– con la
sua
firma.
Il
motivo
per cui
il
manuale
di Izzi
possiede
un
corredo
iconografico
per
alcuni
aspetti
degno
delle
grandi
opere
dell’Ottocento
è adesso
chiaro:
quelle
immagini,
quei
disegni
litografati
provengono
realmente
da una
di
queste
grandi
opere,
discendono
da un
programma
articolato
e
trovano
posto,
nobilitandolo
ulteriormente,
in uno
straordinario
volume
didattico,
i cui
vari e
complessi
livelli
di
comunicazione
rifuggono
dagli
angusti
spazi in
cui
troppo
spesso
si
richiudeva
– e
spesso
si
rinchiude
ancora –
l’editoria
didattica.
La cura,
la
dedizione,
l’efficacia
e la
compostezza
con cui
Izzi
organizza
il suo
volume
didattico
pone
quest’opera
tra le
migliori
pubblicate
prima
della
riforma
degli
anni
Venti.
Non è
stato
possibile
ricostruire
in alcun
modo la
vicenda
umana di
Izzi e
nemmeno
tracciare
– in
questa
fase
iniziale
di
indagine
sui
disegnatori
siciliani
tra
l’Ottocento
ed il
Novecento
– le
tappe
fondamentali
della
sua
biografia.
Certo è
che
nell’edizione
del 1921
del
terzo
fascicolo
dell’opera,
la sesta
ed
ultima
edizione,
«riveduta
e curata
dal
Prof. A.
Rivela»,
il
corredo
di
disegni
a colori
viene
drasticamente
ridotto:
le
tavole
cromolitografiche
passano
da
trentadue
a sedici
solamente,
raccolte
in un
solo
fascicolo.
Si
elimina
l’uso
dell’inchiostro
dorato,
considerato
forse di
gusto
desueto.
Tra le
tavole
eliminate
vi sono
tutte e
otto le
tavole
con i
rilievi
della
Cappella
Palatina.
Una
revisione
così
profonda
e così
‘riduttiva’
del
volume
forse è
indice
del
fatto
che Izzi
probabilmente
non
poteva
più
occuparsi
del
proprio
lavoro.
La sesta
edizione
del
lavoro
di Izzi,
nel
perdere
la sua
prerogativa
più
evidente
e nel
rinunciare
a una
delle
sue
migliori
qualità,
trova
una
forma
complessiva
che, pur
mantenendo
un
livello
più che
dignitoso,
la
allinea
alle
opere
analoghe
più
diffuse,
come
quelle
già
discusse
di
Garneri,
di
Antilli
e di
Torricelli.
[1] Gregorio Izzi era professore ordinario di disegno e di calligrafia presso la Regia Scuola Normale Maschile di Palermo ed era perito calligrafo presso la corte di Appello di Roma. In questa fase delle ricerche sui disegnatori siciliani tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, si sono riuscite a ricavare solo poche notizie frammentarie sull’autore.
[2] Sulla storia della scuola italiana si veda C. Baldoni, L’insegnamento del Disegno nella scuola italiana postunitaria, Aracne, Roma 2006. Rilevanti in questo campo sono anche gli studi di Fabrizio Dal Passo come F. Dal Passo, Storia della scuola italiana, in Il codice della scuola vol. II, a cura di L. Barberio Corsetti, P. Cirillo, E. Ciarrapico, D. Croce, G. Scribano, La Scuola, Brescia 2003; F. Dal Passo, Storia della scuola italiana: dalle riforme dell’Illuminismo alla riforma Moratti, in “Semestrale di studi e ricerche di Geografia”, Abilgraf, Roma 2003.
[3] Si veda C. Baldoni, L’insegnamento del Disegno…, pp. 11-40.
[4] L’indirizzo di agrimensura forniva una preparazione analoga alla moderna scuola per geometri mentre l’indirizzo fisico-matematico viene considerato l’antesignano che del nostro liceo scientifico. Si veda C. Baldoni, L’insegnamento del Disegno…, pp. 14 e 17.
[5] Ivi, p. 27.
[6] Ivi, pp. 87-88.
[7] Ivi, p. 88.
[8] L’abolizione dell’insegnamento degli ordini di architettura secondo la regola di Vignola suscitò accese polemiche tra coloro che consideravano questo cambiamento come necessario e coloro che invece ritenevano che fosse motivo di imbarbarimento del corso di studi. Nella sostanza, però, l’inerzia culturale – favorita anche dalla capillare diffusione di un patrimonio immenso di manuali, studi, pubblicazioni illustrate – portò nelle aule ad una sostanziale riduzione del tempo dedicato a questo argomento senza che però esso fosse del tutto soppresso. In molte opere continuarono a essere pubblicate tavole sugli ordini di Vignola che rimasero nei volumi perfino ben oltre la riforma Gentile del 1923. Si veda E. Dotto, La regola e lo sguardo. La critica di Giuseppe Damiani Almeyda al libro dei cinque ordini di architettura di Vignola, in “TeCLa - Rivista”, n. 4, 2011, pp. 28-53 (http://www.unipa.it/tecla/rivista/4_rivista_dotto.php). Si veda anche C. Baldoni, L’insegnamento del Disegno…, p. 28.
[9] Pietro Selvatico Estense (Padova 1803 - 1880), formatosi alla giurisprudenza ed alla pittura, fu un architetto ed un teorico molto attivo, allievo di Giuseppe Jappelli con il quale intraprese dei viaggi di studio in Francia ed in Inghilterra. Direttore dell’Accademia di belle arti di Venezia, avversò il Neoclassicismo a vantaggio della cultura neogotica. Mentore di Camillo Boito, influenzò la realizzazione della facciata neogotica del Duomo di Firenze di De Fabris, suggerendogli la forma tricuspidata. Realizzò la facciata della chiesa di San Pietro a Trento. Sull’influenza di Selvatico nella scuola italiana si veda C. Baldoni, L’insegnamento del Disegno…, pp. 82-84. Per una bibliografia su Selvatico, si veda Storia dell’architettura italiana. L’Ottocento, a cura di A. Restucci, Electa, Milano 2005, p. 718.
[10] C. Baldoni, L’insegnamento del Disegno…, p. 28
[11] O. Jones, The Grammar of Ornament, Day and Son, London 1856; M. A. Racinet, L’Ornement polychrome, Fermin Didot, Paris 1869-73; J. Bourgoin, Théorie de l’ornement, A. Levy, Paris 1873.
[12] E. H. Gombrich, Il senso dell’ordine. Studio sulla psicologia dell’arte decorativa, Einaudi, Torino 1984, pp. 89-98.
[13] Ivi, pp. 109-156.
[14] Ivi, pp. 116-140.
[15] J. Bourgoin, Les éléments de l’art arabe, Firmin Didot, Paris 1879.
[16] C. Boito, Architettura del Medioevo in Italia, Hoepli, Milano 1880.
[17] D. Lo Faso Pietrasanta Duca di Serradifalco, Del Duomo di Monreale e di altre Chiese Siculo Normanne, Roberti, Palermo 1838.
[18] F. De Dartein, Etude sur l'architecture lombarde et sur les origines de l'architecture romano-byzantine, Paris 1865-1882. Sul lavoro di De Dartein si veda T. Bella, I rilievi della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano nei dossier d’archivio di Fernand De Dartein. Storia di una rappresentazione, tesi di dottorato di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione, Facoltà di Architettura di Siracusa, XXI ciclo, tutor G. Pagnano, dicembre 2008.
[19] D. B. Gravina, Il Duomo di Monreale. Illustrato e riportato in tavole cromolitografiche, Stabilimento tipografico di Francesco Lao, Palermo 1859-69.
[20] Come è noto, la Geometria Descrittiva è quella branca della Scienza della Rappresentazione che affronta i principi geometrici su cui si basano i comuni metodi di rappresentazione, come le proiezioni ortogonali, la prospettiva e l’assonometria. Dalla fine del Settecento, il disegno, grazie alla Geometria Descrittiva, poté finalmente assumere uno statuto scientifico e questo semplificò la trasmissione del sapere e consentì una revisione profonda dei modi di comunicazione grafica. Questo processo si andò compiendo, in Europa – pur con alcune vistose eccezioni – attorno al terzo decennio del XIX secolo.
[21] Professionisti di grande levatura come Giuseppe Boidi Trotti – attivo in Piemonte alla fine dell’Ottocento – o Giuseppe Damiani Almeyda si dedicarono, pur se con diverse energie, alla redazione di libri di testo. Sull’opera didattica di Damiani si veda P. Barbera, Giuseppe Damiani Almeyda. Artista architetto ingegnere, Palermo 2008, pp. 21-47. Si veda anche E. Dotto, La linea di equilibrio. Sensibilità geometrica e tecnica pittorica nei disegni di architettura, in P. Barbera, C. F. Carocci, E. Dotto, C. Tocci, Giuseppe Damiani Almeyda. Arte e scienza in architettura, Lombardi editori, Siracusa 2011.
[22] In una pagina allegata al Manuale di disegno lineare geometrico di Giuseppe Boidi Trotti, si trova l’elenco delle sue pubblicazioni, aggiornato al 1870. Vi si trovano ben 21 diversi volumi dagli argomenti più vari. Molti di essi erano simili tra loro, come ad esempio le Prime nozioni di disegno lineare e il Corso elementare di Ornato lineare. In altri casi si trattava di opere piuttosto diverse, come il Corso di Disegno applicato ai Lavori donneschi o il Disegno di Fiori. La dedizione di Boidi all’editoria didattica lo rese uno degli autori più studiati e diffusi del secondo Ottocento.
[23] Si tratta di una campionatura ragionata degli autori più noti, basata sull’effettiva diffusione e sulla qualità delle singole opere. Ciascuno degli autori indicati ha pubblicato un numero elevato di manuali. In questa occasione si citeranno esclusivamente le opere consultate per la stesura di questo saggio, nell’edizione disponibile. A. Antilli, Disegno Geometrico, Hoepli, Milano 1894; G. Boidi Trotti, Manuale di Disegno lineare geometrico, Paravia, Milano 1898; A. Garneri, Corso elementare di Disegno geometrico, Tipografia nazionale di G. Bertero, Roma 1895; C. Torricelli, Disegno Geometrico con tavole a colori, Unione Litotipografica Bresciana, Brescia 1894.
[24] Si iniziava dalla squadratura del foglio per passare alla costruzione grafica di perpendicolari e bisettrice, poi alla tripartizione dell’angolo retto e piatto, al tracciamento di parallele, alla divisione in parti uguali dei segmenti, sino al disegno di poligoni regolari inscritti o a partire da un lato. Questa sequenza è largamente utilizzata anche nella didattica attuale.
[25] Si tenga conto che, prima dell’introduzione estensiva delle calcolatrici automatiche, era molto conveniente effettuare operazioni di calcolo (somma, sottrazione divisione e trasformazione) delle aree non attraverso operazioni numeriche ma attraverso raffinate (e talvolta antichissime) costruzioni grafiche, ormai sostanzialmente desuete.
[26] La questione del tracciamento delle policentriche e delle esercitazioni sul disegno del profilo dei vasi meriterebbe un approfondimento, sostanzialmente per tentare di rintracciare i modelli cui si ispiravano i curiosi e complessi profili utilizzati.
[27] G. Izzi, Corso elementare di disegno geometrico per le scuole secondarie, tecniche, normali e industriali, Orazio Fiorenza, Palermo 1903.
[28] Nell’edizione del 1908 Izzi pubblica i risultati di questa sua campagna di diffusione, riportando lettere di apprezzamento del Ministro Nunzio Nasi e del suo successore, Vittorio Emanuele Orlando, di Ernesto Basile ed i lusinghieri giudizi pubblicati su due bollettini che illustravano gli articoli presentati all’Esposizione campionaria di Roma del 1903. Il volume fu premiato presso tale esposizione con la medaglia d’argento e con la Medaglia d’Oro, il Grand Prix e la Targa d’Oro in occasione dell’Esposizione Internazionale di Palermo del 1906.
[29] Ricerche automatiche nei cataloghi librari delle biblioteche italiane e ricerche presso il mercato antiquario non hanno consentito di individuare nemmeno una copia del primo o del secondo fascicolo di questa edizione.
[30] La premiata tipografia di G. Caneba aveva sede a Palermo in corso Vittorio Emanuele 412.
[31] In totale le edizioni del volume sono sei. La prima del 1903, la seconda del 1905, la terza del 1908, la quarta del 1914. Della quinta non si è riusciti ad avere alcuna notizia. La sesta edizione fu pubblicata nel 1921. Se si esclude l’edizione del 1908, pubblicata da Paravia, le altre furono tutte curate da Orazio Fiorenza.
[32] G. Izzi, Elementi di disegno geometrico…, pp. 152-155.
[33] Ivi, p. 155.
[34] Ivi, p. 156.
[35] Per ciascuna superficie veniva indicato un riferimento stilistico o geografico, come «moresco», «greco», «moderno», «medioevo», «celtico», «arabo», «stile ottocento», «Rinascimento inglese - Stile Elisabetta».
[36] In ciascuna tavola si legge «G. Izzi dis.» e «Lit. A Brangi - Palermo».
[37] D. Malignaggi, Tra neoclassicismo e accademia. Arti figurative a Palermo nella prima metà dell'Ottocento, in Immaginario e Tradizione. Carri trionfali e teatri pirotecnici nella Palermo dell'Ottocento, Novecento, Palermo 1993, pp. 26-28. E. Dotto, La prospettiva pratica di Antonio Morselli, Lombardi editori, Siracusa 2006, pp. 24-26.
[38] Anche nel caso in cui come in Bourgoin, le indicazioni sono piuttosto generiche, si tratta sempre di esempi reali, di manufatti rilevati dal vero che hanno subito un profondo processo di sintesi e che vengono offerti agli studiosi come puri schemi geometrici, privi del tutto di ogni connotazione materica o cromatica.
[39] Nel volume di A. Garneri, Corso elementare di Disegno geometrico, già citato, alle pagine 83-86 si trovano gli indici delle tavole di «applicazioni». Alcuni schemi musivi sono indicati per la loro provenienza, come alcuni reticoli tratti da S. Maria del Fiore a Firenze, dal Duomo di Monreale, dalle Terme di Caracalla o dall’Alhambra. Garneri pubblicò anche diverse edizioni di un Vademecum dell’Ornato, che contiene oltre 2400 diversi schemi con didascalie in sette lingue (tra cui il russo) nelle quali non di rado si indica l’origine dell’elemento decorativo illustrato.
[40] Come è possibile dimostrare (teorema dei cinque colori), per potere disegnare un qualunque partito geometrico colorando le aree adiacenti con tinte tra loro differenti, sono necessari – appunto – al massimo cinque colori. In generale si rivelano sufficienti quattro colori, anche per i casi più complessi. Nella trascrizione grafica era sempre possibile, quindi, ridurre il numero delle tinte nel caso in cui i tessuti musivi fossero composti utilizzando un numero elevato di materiali diversi.
[41] In qualche caso, però queste tavole monocromatiche risultavano essere migliori di altre in cui gli ornati venivano stampati a colori e su pagine di dimensioni maggiori. Le tavole nel volume di Stanislao Tamburrini, (S. Tamburrini, Guida pratica di disegno geometrico, Vallardi, Milano 1898) ad esempio, riportavano disegni fragili, privi di mordente ed inefficaci.
[42] J.-J. Hittorff, L. von Zanth, Architecture moderne de la Sicile, Paul Renouard, Paris 1835. Le tavole dedicate alla Cappella Palatina sono quelle dalla 45 alla 47.
[43] In D. Lo Faso Pietrasanta Duca di Serradifalco, Del Duomo di Monreale…, le tavole dedicate alla Cappella Palatina sono la XV, la XVI e la XVII.
[44] F. M. Hessemer, Arabische und alt-italienische Bau-Verzierungen, Reimer, Berlin 1842, tavv. 51 e 52 della II parte.
[45] M. A. Racinet, L’Ornement…, tav. XXXVI.
[46] M. Amari, L. Boglino, I. Carini, S. Cavallari, A. Terzi, La Cappella di S. Pietro nella reggia di Palermo, Brangi, Palermo 1842.
[47] Andrea Terzi nacque a Monreale nel 1842 da una famiglia umile. Assistito da uno zio canonico poté recarsi a Palermo dove imparò l’uso dell’acquerello e poté studiare con Giuseppe Patania. Giovanissimo fu coinvolto da Domenico Benedetto Gravina nella pubblicazione del lavoro Il Duomo di Monreale Illustrato, al quale contribuì con un numero cospicuo di disegni. Nel 1872 pubblicò il suo lavoro sulla Cappella Palatina, che gli valse alcuni premi ed il cavalierato. Il figlio Amedeo John Engel riuscì ad eccellere nel mondo del disegno scientifico, in modo particolare come disegnatore di insetti. Il figlio Aleardo fu uno dei più grandi disegnatori pubblicitari del primo Novecento. Andrea Terzi espose molte sue opere pittoriche e realizzò una Pianta topografica ed archeologica di Siracusa commessagli dal Ministero della Pubblica Istruzione. Morì a Roma nel 1918. Si veda la voce di M. A. Spadaro, Andrea Terzi, in L. Sarullo, Dizionario degli Artisti Siciliani. Pittura, vol. II, ad vocem, a cura di M. A. Spadaro, Novecento, Palermo 1993, pp. 522-523. Sul rilievo della Cappella Palatina si veda F. Agnello, Rilievo e rappresentazione del soffitto della navata centrale della Cappella Palatina, in La Cappella Palatina a Palermo, Franco Cosimo Panini, Modena 2010, vol. I, pp. 295-352.
[48] Si veda E. Dotto, Il “Duomo di Monreale illustrato” di Domenico Benedetto Gravina, in Ikhnos 2009, Analisi grafica e storia della rappresentazione, Lombardi Editori, Siracusa 2009, pp. 73-104.
[49] Praticamente in ciascuna delle tavole si trova la firma di Terzi come disegnatore, mentre più variegata è la schiera dei litografi. In aggiunta a Terzi, come litografo si trova indicato, in quasi tutte le tavole, anche il nome di Andrea Brangi. Più raramente G. Huber, e solo in un paio di casi G. Frauenfelder.
[50] Frauenfelder preparò la lastra litografica della tavola XI-A. Sono due le tavole con questa dicitura. Quella litografata da Frauenfelder è quella in nero con sottilissimi tratteggi per la resa dei toni di grigio.
[51] Nel primo fascicolo si trovano due mosaici della Cappella alla tavola X, uno soltanto alla tavola XI, tre alla tavola XII, uno alla tavola XVI. Nel secondo fascicolo si trova un solo mosaico della Cappella alla tavola I, due alla tavola IV, tre alla tavola V, quattro alla tavola VIII.
[52] I disegni pubblicati da Gregorio Izzi si trovano nelle seguenti tavole dell’opera di Terzi: tavola XI-A (a colori), due illustrazioni in alto; XI-B le quattro illustrazioni nella parte superiore; XI-C, tutte e tre le illustrazioni; XXX, sei illustrazioni ai bordi; XXXI-A due illustrazioni in alto al centro e a destra.
[53] Si veda la nota 47.