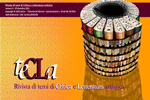In una recensione su “Corriere della
Sera” del febbraio 1933 Ugo Ojetti commentava
l’uscita della guida Sicilia, iv volume della
collana Attraverso l’Italia del Touring Club
Italiano[1]:
scrutando il rutilante diorama dell’isola –
«dove tre e quattro correnti di civiltà vengono
a incontrarsi e a frangersi facendo un gorgo
tanto fondo che, a fissarne il rigiro, d’impeto
e inerzia, di spavento e pace, di passione e
saggezza, di dubbio e fede, di rivolta e
rassegnazione, d’ingenuità e sottigliezza, si
resta affascinati» – Ojetti notava che più che
affascinati si rimaneva terrificati come dal
tocco meduseo, tanto da spaurire e distogliere
«gli scrittori dal darci un libro che descriva e
interpreti quest’isola la quale pure ha dato e
continua a dare tanti scrittori e di tanto
maschio rilievo»[2].
Perla rara in un così lacunoso quadro
di letteratura artistica era a suo vedere la
guida che recensiva, ricco Baedeker visivo con
testi di Giuseppe Antonio Borgese, Biagio Pace,
Pirro Marconi; eppure messo da parte questo
«ricco e gustoso volume, più d’immagini che di
parole» – dice il critico – «il libro italiano
sulla Sicilia ancora non c’è».
Oltre la recensione, si rilevava
un’inerzia in Italia negli studi di storia
dell’arte siciliana destinata a protrarsi dagli
anni Trenta in avanti; impasse ricambiata, per
così dire, dagli studiosi siciliani, le cui
ricerche, quasi esclusivamente abituate a una
dimensione locale e prive di altri sbocchi,
mostravano forti renitenze alla cultura italiana
o europea[3].
È da notare comunque che non avevano
mancato storici dell’arte, docenti universitari
o funzionari di soprintendenze, spesso non
siciliani, di impostare un fronte di ricerca
variegato ma asistematico e talora incongruente
nei programmi e nelle finalità: non solo gli
allievi di Venturi Emilio Lavagnino[4],
Enrico Mauceri[5]
o Maria Accascina[6],
ma Filippo Di Pietro e Roberto Salvini (il primo
assegnato alla soprintendenza di Palermo nel
1929 e fino al 1948, il secondo aggiunto dal
1939 al 1943) o Giorgio Vigni e Giovanni
Carandente (curatori della mostra Antonello da
Messina e la pittura del ’400 in Sicilia del
1953[7]).
L’università di Palermo vedrà poi
avvicendarsi alla cattedra di Storia dell’arte
medievale e moderna Giulio Carlo Argan, dal 1955
al 1959, quando rientra a Roma chiamato da
Lionello Venturi a sostituirlo nella sua
cattedra[8];
Cesare Brandi che, dopo aver vinto il concorso
per la cattedra, lascerà nel 1960 l’Istituto
Centrale del Restauro rimanendo a Palermo fino
al 1967[9];
Maria Grazia Paolini, prima assistente di Brandi
poi direttore dell’Istituto di Storia dell’arte
dal 1967 al 1970; e Maurizio Calvesi, ultimo
docente d’importazione temporanea (1970-’76),
cui si devono iniziative quali i “Quaderni dell’a.f.r.a.s.”[10].
Sono da considerarsi occasioni di aggiornamento
di metodi e contenuti indebolite dall’interim
che sfavoriva continuità e possibilità di
ampliamenti della scuola oltre la figura del
“maestro”. L’articolo di Ojetti, che toccava
anche la spinosa questione della mancanza di
originalità che la scuola artistica siciliana
presentava al cospetto della storia dell’arte
italiana – sulla quale il critico romano aveva
già detto la sua spalleggiando Antonio Maraini
in occasione della Biennale di Venezia del 1928[11]
–, è ripubblicato su alcune riviste degli anni
Cinquanta[12],
anni contraddistinti da un fitto discorso sul
tema dell’identità siciliana[13].
Tratteggiando con larga approssimazione un
quadro generale, si ha di fronte un lasso di
tempo saturo di criticità per l’opaca gestione
politica, per quelle contraddizioni e antinomie
ben restituite dal reportage di Carlo Levi[14],
e in cui non mancano defezioni e “fughe” da una
«rete di arretratezza e di feudo» per usar le
parole di Renato Guttuso[15].
La difficile ricostruzione postbellica,
cui dal 1943 al 1955 aveva in parte provveduto
la Soprintendenza ai Monumenti con funzionari
quali l’architetto veneto Mario Guiotto e
l’architetto napoletano Armando Dillon[16],
accompagna un faticoso rinnovamento nel campo
della disciplina storico-artistica, della
relativa editoria specialistica, e una
trasformazione sul versante della cultura
artistica, come documentato dal primo Congresso
internazionale delle Arti figurative (itinerante
nel 1953 in alcune città siciliane, in cui fra
gli altri serrarono le fila del dibattito Maria
Accascina, Stefano Bottari, Pippo Rizzo[17])
e dal Congresso internazionale dei Critici
d’arte del 1957 (tenutosi a Napoli e Palermo
sotto l’egida di Lionello Venturi[18]).
Né andrebbe trascurato il ruolo della
stampa periodica – sovente esclusivo campo delle
ricerche storico-artistiche, di divulgazione, di
mediazione col pubblico e verso il mercato – o
delle produzioni cinematografiche, in testa
quelle della Panaria Film che, con la pratica
neorealista nel film e nel documentario,
facilitarono la definizione del paesaggio
dell’isola o del “carattere” dei siciliani[19].
Fra le iniziative di politica culturale
promosse con un piano programmatico
dall’attività di amministratori e funzionari,
l’Assessorato Turismo e Spettacolo della Regione
mette in cantiere la rivista “Sicilia” pensando
a uno strumento privilegiato di propaganda per
il turismo internazionale. Su tale esperimento –
che vede il “territorio” farsi ristretto campo
di analisi e la Regione (nata con lo statuto
speciale del 1946) indagata in tutti i suoi
risvolti nel reticolo del periferico e del
minore – la rivista qualifica, con ricchezza di
interventi, alcune istanze di una modernità in
affanno per un eccessivo regionalismo, tentando
fra gli anni Cinquanta e i Settanta un
rinnovamento del sistema dell’arte, in un campo
di «derelizione sconsolante», come notava Cesare
Brandi[20],
perché carente nella programmazione (assenza di
vincoli e piani regolatori[21])
e privo di adeguate referenze.
La rivista è affidata all’editore
palermitano Salvatore Fausto Flaccovio[22],
infaticabile promotore di cultura formatosi alla
scuola del libraio Filippo Ciuni[23],
che nel 1938 aveva aperto i battenti della
libreria di via Ruggero Settimo sotto l’emblema
di una gazzella rampante, tuttora logotipo delle
edizioni della casa editrice. Flaccovio approda
alla pubblicazione della rivista “Sicilia” dopo
la significativa esperienza di “Chiarezza.
Settimanale di vita sociale”,
pubblicato per un anno a ridosso del secondo
dopoguerra (1946-1947), proseguita nel 1962 con
la rivista parlata “Collage. Dialoghi di
cultura”, fondata da Gaetano Testa, Paolo Emilio
Carapezza e Antonino Titone, nella stagione
delle Settimane Internazionali Nuova Musica
(1960-1968), fondamentale capitolo della storia
delle avanguardie[24].
Con i Convegni di cultura e arte (dal
1949) e con la Galleria Flaccovio inaugurata nel
1954 negli stessi locali della libreria – che
organizza rassegne di pittura e grafica di
grande richiamo su artisti e movimenti
contemporanei (Guttuso, Attardi, Soffici, Rosai
per citarne alcuni), riallacciando i fili con la
tradizione espositiva anteguerra[25]
– l’editore porta avanti un ambizioso gioco di
sponda fra libri, riviste e mostre.
“Sicilia” è stampata dal 1953 al 1982, per i
primi dieci anni dall’ottimo stabilimento Arti
Grafiche G. Zangara di Palermo, con la
collaborazione, per la tiratura delle tavole in
policromia, dello stabilimento Pizzi di Milano
(le annate successive escono invece dalle
macchine lito-tipografiche dell’E.S.A.
Poligrafico di Palermo). Questa prima serie[26]
si chiude con ottantanove numeri in tutto, con
periodicità altalenante su base trimestrale (ma
il piano editoriale contempla anche uscite
annuali[27]).
Il formato di 32x24 cm conta una cinquantina
variabile di pagine, compresa la pubblicità
quasi unicamente locale. Si tratta di una
rivista di lusso (costa 1.500 lire il numero e
ne costerà 5.000) pensata per un pubblico
ristretto e per un turismo internazionale, al
quale si rivolgeva con articoli in lingua
inglese, francese e tedesca, riproponendo anche
pagine di viaggiatori stranieri dei secoli
passati[28]
o ripercorrendo tappe di autori contemporanei,
si vedano le annotazioni dello scrittore
saggista svizzero Daniel Simond[29].
Il senso di simili aperture al di là
dei ristretti confini regionali, vedremo, è il
tentativo di collocare l’isola in una
prospettiva non solo nazionale.
La rivista è arricchita da un
bollettino informativo che aggiorna su eventi,
rassegne, novità editoriali, e da appendici con
notizie utili per il viaggiatore.
La redazione, dapprima in via Torrearsa,
traslocherà in varie sedi dell’assessorato, fra
cui villa Igiea, insediandosi infine nei locali
della libreria Flaccovio; il direttore
responsabile è il veneto Giuseppe Orlandi, grand
commis dell’assessorato, mentre la direzione
artistica è affidata a Bruno Caruso, artista con
un forte ascendente espressionista dalla lezione
della Nuova Oggettività tedesca[30],
autore di un progetto di raffinata sensibilità
grafica che ne fa prodotto editoriale eccentrico
nel panorama italiano, non solo per il grande
formato e le belle copertine in cui titolo e
sommario cambiano corpo, carattere grafico,
colore in ogni numero.
Stampata in offset, che allora era un
procedimento rivoluzionario rispetto alla
tipografia tradizionale delle macchine piane,
eravamo spesso costretti per l’urgenza (e per
economia) a disegnare i titoli e le lettere con
matite litografiche, da far sì che la rivista
fosse parzialmente stampata in litografia
originale: un ripiego che la rese ovviamente
molto preziosa. Restringemmo il numero delle
“linee” tipografiche per dare gli effetti del
rotocalco. Altri innumerevoli accorgimenti
tecnici suscitarono i molti consensi che
riscuotemmo[31].
La veste tipografica di “Sicilia” è
articolata, con una sofisticata compenetrazione
fra testo e immagine: il gusto polimaterico
nell’alternanza fra carta bianca/colorata e
cartoncini, intercalati da pagine ripiegate o da
tavole inserite in tasche interne, scandisce i
livelli di una formidabile stratigrafia visiva,
caratteristica soprattutto delle prime annate,
che andrà attenuandosi in progressiva
normalizzazione negli anni a seguire. L’accurata
incamiciatura del fascicolo si spinge nella
quarta di copertina che, mai bianca, presenta
una particolare accentuazione decorativa, sempre
in rapporto con l’immagine utilizzata per la
fronte.
All’interno della rivista l’apparato
iconografico si trova isolato nell’impaginazione
e, a volte del tutto irrelato dal contesto
semantico, restituisce l’ampiezza spettacolare
dell’immagine (siano fotografie, grafica
settecentesca o contemporanea, dipinti). Il
congegno grafico, proseguito da Gaetano Armao,
Gabriella Saladino e Santuzza Calì (assistente
di Oskar Kokoschka a Salisburgo), risultò tanto
riuscito che Caruso lo rielaborò per il mensile
di cultura e arte “Ciclope” diretto da Beppe
Fazio (1957).
Il pittore sarà anche il direttore
artistico della Flaccovio per la collana Grandi
Opere, inaugurata nel 1960 dal volume I mosaici
di Monreale di Ernst Kitzinger, primo capitolo
di una trilogia intorno al duomo magnifica anche
grazie alle fotografie di Enzo Sellerio[32].
“Sicilia” si inserisce in un panorama
dinamico che aveva visto nascere esperienze
editoriali di segno diverso, cui si dava scopo
di scandagliare i fondali della cultura isolana:
faccio il caso di “Dafni. Quindicinale
letterario, artistico, folcloristico siciliano”
(1946); del settimanale “L’Illustrazione
Siciliana” (1948); di “Galleria. Rassegna
bimestrale di cultura” (1949); de “La Giara” e “Sicania”
(1952); di “Sicilia turistica” (1954): sono
spazi aperti in cui confluiscono diversi
interessi, caratterizzati da uno specialismo più
o meno accentuato rispetto ai temi
storico-artistici. La critica d’arte periodica
svolge una concreta e flagrante relazione con un
panorama più ampio e tracima anche nei
quotidiani “Giornale di Sicilia”, “L’Ora” e “la
Voce della Sicilia” (testate in cui si leggono
gli scritti di piglio militante di Franco
Grasso), o sulla terza pagina di “Sicilia del
Popolo” dove appaiono articoli e recensioni
anche di Eugenio Battisti e Bernard “Bernardo”
Berenson[33].
Dunque, la proposta di Fausto Flaccovio
ha origine da questa rosa di modelli di poco
anteriori, che avevano segnato, con un forte
radicamento nel territorio, una ripresa
dell’editoria siciliana dopo gli anni della
guerra, ai quali va aggiunto il pochissimo
conosciuto almanacco “Mediterranea” (1949), uno
dei punti di riferimento del giovane editore, in
particolare per la grafica curata da Gino Morici
e Natale Varetti. Se la rivista ha l’obiettivo,
fissato nella nota editoriale del primo numero[34],
di dar fondo a una ricapitolazione che più che
altro doveva assolvere il compito di instradare
il turismo verso la Sicilia, la redazione getta
ami in un mare ricchissimo: arti figurative,
architettoniche e decorative, cinema e musica,
teatro (adeguato margine occupano le
rappresentazioni classiche di Siracusa);
tradizioni etnoantropologiche; letteratura e
storia. Il trascorrere degli articoli dimostra
la carica vitale della rivista che solo in un
caso focalizza un argomento monografico (n. 88,
1981 dedicato ai Whitaker). Attorno a questa
miscellanea di temi identitari, restitutiva di
un’ampia porzione di quel diorama di cui parlavo
in apertura, si addenserà l’attenzione di
scrittori, giornalisti-critici, artisti, storici
dell’arte e battitori liberi che profondono il
loro impegno verso il pubblico con una varietà
di registri linguistici e espressivi sempre
giocata col primato dell’immagine e della
fotografia, che nel reportage (magistrali Il
gioco del lotto[35]
di Enzo Sellerio o il Reportage sulle Catacombe
dei Cappuccini[36]
e il Thunfischfang[37]
di Herbert List) si fa racconto letterario
compiuto[38].
In questa sede vorrei proporre un breve
resoconto del longevo corso della rivista,
enumerandone i collaboratori, fra un novero
ampio e assai qualificato, e cercando di fermare
in alcuni casi il discorrere dei contributi su
ciò che più ci interessa: gli articoli diramati
in vari ambiti riguardano arti figurative
antiche e moderne, museologia e critica d’arte,
patrimonio librario e archivistico,
paesaggistico e ambientale. Questa sequenza di
ampio spettro è sostenuta da una molteplicità di
firme, fra cui Edmonde Charles-Roux, Jean
Cocteau, René Herval, Roger Peyrefitte, Luigi
Bartolini, Anton Giulio Bragaglia, Irene Brin,
Paolo Emilio Carapezza, Beniamino Joppolo,
Gioacchino Lanza Tomasi, Ercole Patti, Alberto
Savinio, Leonardo Sinisgalli, Corrado Sofia.
L’apporto di Leonardo Sciascia si mostra
scandito da scritti su “fatti diversi” anche con
importanti nervature storico-artistiche (sul
Barocco di Noto, su Gaetano Tranchino o sulla
Vucciria di Guttuso)[39].
Altrettanta sensibilità verso le arti visive
contemporanee è restituita nelle pagine di
Natale Tedesco[40].
Gli scritti di etnoantropologia di
Antonino Buttitta, Giuseppe Cocchiara, Aurelio
Rigoli, Antonino Uccello, Mario Verdone e Janne
Vibaek spaziano da approfondimenti sulla cultura
materiale all’arte popolare, pittorica (i
cartelloni dell’opera dei pupi, la pittura su
vetro e gli ex voto) o musicale, fino alla
museologia folklorica[41].
Altro rilevante nucleo tematico per
numero di contributi e analisi è costituito
dall’archeologia: illuminano l’eterogenea
stratificazione storica dell’isola (né mancano
gli spunti nuovi forniti dall’archeologia
subacquea) e gli aspetti peculiari delle civiltà
fenicio-punica e greco-romana gli scritti di
Dinu Adamesteanu, Nicola Bonacasa, Aldina
Cutroni Tusa, Vittorio Giustolisi, Sabatino
Moscati, Biagio Pace, Ida Tamburello, Vincenzo
Tusa.
Le arti figurative siciliane sono
affrontate in un ampio raggio di ricerca, nel
tentativo di rendere presente e viva una
tradizione. I temi di pittura e scultura moderna
appaiono sempre scevri di riverberi teorici o
metodologici e di segno cronistico-commentario[42],
pur con puntuali agganci alla relativa
letteratura artistica storica (fonti erudite,
vite, periegetica). Congrue, infine, le aperture
verso i centri minori, sia per l’arte sia per
discipline affini[43].
Un campo particolarmente battuto quello
legato all’architettura e all’urbanistica dal
Medioevo all’Eclettismo: i temi sono formulati
da Giuseppe Bellafiore, Stefano Bottari (che
negli anni ’50 ancora prosegue l’indirizzo di
studi di architettura del maestro Enrico
Calandra), Gianluigi Ciotta, Stefano Giordano,
Maria Giuffrè, Rosario La Duca, Luciana Natoli,
Maria Antonietta Spadaro[44].
Il côté contemporaneista vede impegnati
nella scrittura Ugo Attardi, Giacomo Baragli,
Giovanni Carandente, Pietro Consagra, Enrico
Crispolti, Nino Garajo, Franco Grasso, Lia
Pasqualino Noto, Maria Poma Basile, Albano
Rossi, Giuseppe Sciortino, Miklos N. Varga con
articoli incentrati su primi bilanci del
contemporaneo[45],
su avvenimenti espositivi[46],
artisti e movimenti: Guttuso e la stagione del
realismo[47],
le Biennali e Quadriennali[48],
le suggestioni siciliane di Antonietta Raphaël[49]
o di Piero Gauli[50],
la scultura monumentale classica di Giulio
Ciniglia[51].
C’è poi da valutare l’interessamento verso
artisti naïf o outsider fuori dai percorsi
convenzionali, che conseguono qui i primi
riconoscimenti della loro cifra irregolare e
eccentrica[52].
Reiterati gli affondi su Corrado Cagli – le cui
opere furono esposte nella retrospettiva alla
Civica Galleria d’arte moderna “Empedocle
Restivo” nel 1967[53]
– e sulla sua eclettica produzione artistica fra
astrazione e figurazione, che, com’è noto, trovò
nell’esperienza in Sicilia fonti di ispirazione
per il suo discorso figurativo intorno al
simbolo e al mito, quell’aspetto di «componente
“siciliana”, come veicolo alla mitografia
mediterranea» indicato dal ciclo delle
Siciliane, iniziato dall’artista anconetano a
Taormina nel 1962[54].
Accanto al divenire del contemporaneo si attesta
un’attenzione per le arti decorative che in
“Sicilia” assumono un rilievo apprezzabile, in
anni in cui si andranno a indagare in maniera
specialistica le forme e le tecniche delle arti
in grossi studi monografici come quelli di Maria
Accascina[55]
o di Antonino Ragona[56].
Questo vitale momento per lo sviluppo delle arti
cosiddette applicate è ben registrato nella
rivista e negli articoli, oltre dei due autori
citati, di Sofia Cuccia, Angela Daneu Lattanzi e
Antonio Daneu[57]
che aggrediscono una materia composita e
sfaccettata: corali miniati e libri d’ore[58],
i Serpotta e gli apparati decorativi in stucco[59],
oreficeria e argenterie sacre, smalti, coralli e
avori trapanesi, maioliche, tessuti[60].
I numerosi contributi in tedesco di Angelo
Lipinsky[61]
– indirizzati alle arti suntuarie medievali, a
centri di produzione, a nuclei di opere (le
argenterie di Canicattini Bagni) o a singoli
manufatti come la quattrocentesca ferula
vescovile di Troina – screziano i suoi studi
monografici sull’oreficeria normanna del
Medioevo.
Anche i musei, o mostre di grande
richiamo – segnalo scritti di Iole Bovio
Marconi, Renzo Collura, Filippo Pottino,
Vincenzo Scuderi, Giorgio Vigni – offrono più
spunti di argomento. L’inaugurazione nel 1954
della Galleria Nazionale di palazzo Abatellis
allestita da Carlo Scarpa[62],
il riordino del Museo Pepoli di Trapani a opera
di Franco Minissi[63],
i musei diocesani e i tesori di chiese e
cattedrali[64],
o collezioni di opere siciliane in musei europei[65],
contribuiscono ad altrettante aperture
conoscitive quasi a preparare il momento del
varo della legge n. 80 del 1977, relativa
all’ordinamento di musei e gallerie[66].
[1]
Sicilia,
Bertieri, Milano
1933. Osservo
come la
tipicizzazione
artistica della
regione passi
nel volume del
TCI attraverso
un ricco corredo
fotografico (dai
cataloghi delle
grandi ditte
fotografiche
dell’Istituto
Luce e delle
Arti Grafiche di
Bergamo, Alinari
e Anderson,
Brogi,
Interguglielmi,
Cappellani,
etc.),
estremamente
puntuale nella
documentazione
d’arte, di
paesaggio o di
ambiente
storico. E
Ojetti: «[…]
nelle vedute le
nevi eterne si
succedono ai
parchi di
palmizi, le
tetre rupi agli
aranceti, i
templi dorici
alle cupolette
arabe, i teatri
greci alle
chiese normanne,
i mosaici
bisantini agli
stemmoni
spagnoleschi».
[2]
U. Ojetti,
Sicilia, in
“Corriere della
Sera”, a. 58, n.
43, 1933. Per
Ojetti rinvio a
M. Nezzo,
Ritratto
bibliografico di
Ugo Ojetti, in
“Bollettino
d’Informazioni”,
Scuola Normale
Superiore di
Pisa, Centro di
Ricerche
Informatiche per
i Beni
Culturali, XI,
1, 2001; G. De
Lorenzi, Ugo
Ojetti critico
d’arte. Dal
“Marzocco” a
“Dedalo”, Le
Lettere, Firenze
2004.
[3]
Cfr. G.
Bellafiore,
Condizione e
problemi degli
studi di storia
dell’arte
siciliana negli
ultimi cento
anni, in La
presenza della
Sicilia nella
cultura degli
ultimi cento
anni, atti del
Congresso
Storico
Internazionale
(Palermo, 20-25
ottobre 1975), a
cura della
Società
siciliana per la
Storia Patria,
vol. II, Palumbo,
Palermo 1977,
pp. 631-659.
[4]
Per i
soprintendenti
attivi in
Sicilia si
rinvia a
Dizionario
biografico dei
Soprintendenti
Storici
dell’Arte
(1904-1974),
Bononia
University
Press, Bologna
2007, ad voces.
[5]
Cfr. S. La
Barbera, Enrico
Mauceri
connoisseur,
museologo e
storico
dell’arte, in
Enrico Mauceri
(1869-1966).
Storico
dell’arte tra
connoisseurship
e conservazione,
atti del
convegno
internazionale
di studi
(Palermo, 27-29
settembre 2007),
a cura di S. La
Barbera,
Flaccovio,
Palermo 2009,
pp. 31-57. Per
il momento di
studi e il
rapporto dei
siciliani con
Adolfo Venturi
rimando a S. La
Barbera, Dalla
connoisseurship
alla nascita
della Storia
dell’arte in
Sicilia: il
ruolo di Adolfo
Venturi, in
Adolfo Venturi e
la Storia
dell’arte oggi,
atti del
convegno (Roma,
25-28 ottobre
2006), a cura di
M. D’Onofrio,
Panini, Modena
2008, pp.
309-328.
[6]
Cfr. M.C. Di
Natale, Maria
Accascina
storica
dell’arte: il
metodo, i
risultati, in
Storia, critica
e tutela
dell’arte nel
Novecento.
Un’esperienza
siciliana a
confronto con il
dibattito
nazionale, atti
del convegno
internazionale
di studi in
onore di Maria
Accascina (Palermo-Erice,
14-17 giugno
2006), a cura di
M.C. Di Natale,
Sciascia,
Caltanissetta
2007, pp. 27-50.
[7]
Per la quale
cfr. Antonello e
la Pittura del
‘400 in Sicilia,
catalogo della
mostra (Messina,
30 maggio – 30
giugno 1953) a
cura di G. Vigni,
G. Carandente,
Alfieri, Venezia
1953; G.
Barbera, Mostra
Antonello da
Messina e la
pittura del ‘400
in Sicilia,
Messina, palazzo
Zanca, 30
marzo-31 agosto
1953, in Carlo
Scarpa. Mostre e
Musei 1944-1976.
Case e paesaggi
1972-1978,
catalogo della
mostra (Verona,
10 settembre
2000 – 7 gennaio
2001) a cura di
G. Beltramini,
K.W. Forster, P.
Marini, Electa,
Milano 2000, pp.
120-125. Cfr.
pure R. Longhi,
Frammento
Siciliano, in
“Paragone”, n.
47, 1953, pp.
3-44.
[8]
«A Palermo non
c’era né un
insegnamento
regolare né un
istituto di
storia
dell’arte,
nulla; ho dovuto
partire da zero,
ma per fortuna
Giuseppe
Cocchiara,
ottimo etnologo
e allora preside
della Facoltà,
mi ha aiutato. I
giovani erano
pieni di
entusiasmo,
lavorare con
loro mi
affezionò subito
all’insegnamento».
G.C. Argan,
Intervista sulla
fabbrica
dell’arte, a
cura di T.
Trini, Laterza,
Roma-Bari 1980,
p. 48. Argan
costituirà nel
dicembre del
1958 l’Istituto
di Storia
dell’arte, con
statuto
approvato dal
Consiglio della
Facoltà di
Lettere
dell’Università
di Palermo.
[9]
Sull’esperienza
siciliana si
veda C. Brandi,
Sicilia mia,
Sellerio,
Palermo 1989.
[10]
Gli intenti
della cattedra
sono spiegati
nella nota
redazionale in
A. Giardina,
Michele Catti,
“Quaderni dell’a.f.r.a.s.”,
n. 1, i.l.a.
palma,
Palermo-San
Paulo 1974, p.
3. Per questo
tema posso
rendere noto in
anticipo D.
Malignaggi, La
realtà storica
dell’opera
d’arte in
Sicilia nel
procedimento
metodico dei
“Quaderni dell’a.f.r.a.s”,
in c.d.s.
[11]
U. Ojetti,
Pittori d’oggi.
La XVI Biennale
di Venezia, in
“Corriere della
Sera”, a. 53, n.
124, 1928. Per
la polemica cfr.
G. De Marco, La
Biennale di
Venezia del
1928: materiali
dal quotidiano
“L’Ora”, in
“Quaderni della
Donazione
Eugenio Da
Venezia”, 17,
2008, pp. 55-65.
[12]
U. Ojetti,
Sicilia, in “Sicania.
Rivista d’Arte e
di Turismo”, a.
I, n. 1, 1952,
pp. 2-4;
Comunicazione
del Dott.
Calogero Bonavia
su «Sicilia» di
Ugo Ojetti, in
“La Giara.
Rassegna
siciliana della
cultura,
dell’arte, della
scuola”, numero
speciale
dedicato al 1o
Congresso
internazionale
delle Arti
Figurative
(Palermo,
Catania,
Messina,
Taormina,
Siracusa, 15-20
aprile 1953), a.
2, nn. 2-3,
1954, pp.
139-144. In
entrambi i casi,
è segnalato
erroneamente
come articolo
inedito e
postumo.
[13]
Cfr. L’identità
difficile.
Immagini e
simboli della
Sicilia
1946-1964,
catalogo della
mostra (Marsala,
18 luglio – 4
ottobre 1998) a
cura di S.
Troisi, Charta,
Milano 1998, in
part. pp. 13-30.
Per il quadro
generale cfr. G.
Giarrizzo,
Sicilia oggi
(1950-1986), in
Storia d’Italia.
Le regioni
dall’Unità a
oggi. La
Sicilia, a cura
di M. Aymard, G.
Giarrizzo,
Einaudi, Torino
1987, pp.
601-696.
[14]
C. Levi, Le
parole sono
pietre. Tre
giornate in
Sicilia,
Einaudi, Torino
1955.
[15]
R. Guttuso, Un
pittore parla
agli
intellettuali
siciliani, in
“la Voce della
Sicilia.
Quotidiano del
popolo
siciliano”, a.
II, n. 93, 1947.
[16]
Per gli aspetti
salienti
dell’attività
dei due
soprintendenti,
legata
all’emergenza
dei
bombardamenti
del 1943 e al
restauro dei
monumenti
danneggiati,
rinvio a M.
Guiotto, I
monumenti della
Sicilia
occidentale
danneggiati
dalla guerra.
Protezioni,
danni, opere di
pronto
intervento,
Pezzino, Palermo
1946; A. Dillon,
Del restauro,
Agate, Palermo
1950. Si vedano
anche i
contributi in
Memoria del 9
maggio 1943,
catalogo della
mostra (Palermo,
9-25 maggio
2003), Edizioni
Salvare Palermo,
Palermo 2008.
[17]
“La Giara.
Rassegna
siciliana della
cultura,
dell’arte, della
scuola”, numero
speciale
dedicato al 1o
Congresso
internazionale
delle Arti
Figurative
(Palermo,
Catania,
Messina,
Taormina,
Siracusa, 15-20
aprile 1953), a.
2, n. 2-3, 1954.
Si veda anche N.
D’Alessandro,
Situazioni della
pittura in
Sicilia
(1940-1970),
Celebes, Trapani
1975, pp. 70-93.
[18]
V. Pannini, Il
Congresso dei
Critici d’arte,
in “Ciclope.
Rivista mensile
di attualità e
problemi
siciliani”, a.
I, n. 2, 1957,
p. 31.
[19]
Un tema molto
caro all’editore
Fausto Flaccovio
che aveva
pubblicato V.
Brancati, F.
Maraini, M.
Simili, Volto
delle Eolie,
Flaccovio,
Palermo 1951; E.
Bonanno, Il
cinema in
Sicilia,
Flaccovio,
Palermo 1953. Si
vedano anche Le
Eolie della
“Panaria Film”.
1946-1949, a
cura di R.
Cedrini, 2
voll., Edizioni
del Centro Studi
Lipari, Palermo
1995; S. Gesù,
La Sicilia della
memoria. Cento
anni di cinema
documentario
nell’isola,
Maimone, Catania
1999. Per la
Panaria Film A.
Romeo, Storia
della Fotografia
e Cinematografia
subacquea in
Italia, La
mandragora,
Imola 2009, in
part. pp.
80-109.
[20]
«[a Palermo] con
la creazione
della Regione si
è sovrapposta
una città e una
funzione, che,
mentre
sembrerebbe la
logica ripresa e
prosecuzione del
vice-reame, in
realtà innova
completamente,
immettendo di
colpo la città
da una struttura
feudale in una
struttura
neocapitalista.
La dinamica
fatale di questa
ristrutturazione
porta con sé il
fatto […] che si
è del tutto
infranta una
continuità di
vita fra la
vecchia Palermo
e quella nuova:
al punto che,
neppure chi
sarebbe
finanziariamente
in grado di
farlo, ambisce a
riscattare il
palazzo
settecentesco o
la villa ad
abitazione di
pieno decoro.
Chi sta nella
città vecchia,
ci sta in attesa
di fare il salto
sul grattacielo
o sulla villetta
nuovissima
all’Aspra. Donde
la derelizione
sconsolante dei
vecchi palazzi e
delle ville,
verso cui la
Regione stessa
ha la medesima
diffidenza dei
cittadini che
potrebbero e non
vogliono
servirsene.
Palermo, così,
non è stata
quasi toccata
dalla
rivalutazione
dell’antiquariato,
che è fenomeno
generale e per
nulla transeunte
del nostro
tempo: e proprio
questa mancanza
di legame col
passato
rappresenta il
più grande
pericolo per la
conservazione di
un patrimonio
architettonico
degno del più
vigile
rispetto». C.
Brandi,
Introduzione, in
G. Lanza Tomasi,
Le ville di
Palermo, Il
punto, Palermo
1965, p. 6.
[21]
Cfr. B. Zevi,
Assalto a Villa
Deliella, in
“L’Espresso”, a.
6, n. 1, 1960,
p. 16; O.
Cancila,
Palermo,
Laterza,
Roma-Bari 1999,
pp. 511-512. La
vicenda della
demolizione nel
1959 di Villa
Deliella di
Ernesto Basile è
indicativa di
una sciagurata
politica
culturale,
denunciata anche
da Carlo
Ludovico
Ragghianti su “seleArte”
(la campagna Si
distrugge
l’Italia del
1954) e da
Antonio Cederna
su “Il Mondo”.
Per il periodico
di Ragghianti
cfr. M. Negrini,
Percorsi della
conoscenza
artistica: ”seleArte”
di Carlo
Ludovico
Ragghianti
(1952-1966),
Canova, Treviso
2011.
[22]
Per la figura di
Flaccovio rinvio
a N. Aquila, Una
storia
esemplare, in
Salvatore Fausto
Flaccovio
libraio editore.
Cinquant’anni di
promozione
culturale a
Palermo,
catalogo della
mostra (Palermo,
10-30 maggio
2000),
Assessorato alla
Cultura Comune
di Palermo,
Palermo 2000,
pp. 43-53.
[23]
M. Ciuni, Le
librerie del
Novecento fulcro
della vita
culturale
cittadina fino
agli anni’80, in
“Per. Giornale
della fondazione
Salvare Palermo
onlus”, n. 28,
2010, pp. 42-46.
[24]
Per questi
aspetti si veda
M. Giordano,
Palermo ‘60.
Arti visive:
fatti, luoghi,
protagonisti,
Flaccovio,
Palermo 2006,
pp. 33-70; M.
Giordano,
“Collage”:
un’esperienza di
esoeditoria
d’avanguardia
nella Palermo
degli anni
Sessanta, in “teCLa
– Rivista di
temi di Critica
e Letteratura
artistica”, n.
2, 29 dicembre
2010, pp.
108-129 (ISSN:
2038-6133
DOI:10.4413/RIVISTA,
http://www.unipa.it/tecla/rivista/3_rivista.php);
F. Tessitore (a
cura di),
Visione che si
ebbe nel cielo
di Palermo. Le
Settimane
Internazionali
Nuova Musica
(1960-1968),
Rai-Eri, Roma
2003. La rivista
pubblica L.
Agnello, La
nuova musica in
Sicilia, in
“Sicilia”, n.
33, 1962.
[25]
Cfr. C. Alaimo,
Il sistema
dell’arte a
Palermo.
Istituzioni
pubbliche e
gallerie private
1900-1970, Kalós,
Palermo 2006,
pp. 60-70. Per
un quadro della
situazione
precedente si
veda S. Troisi,
Una vicenda del
Novecento: la
collezione
d’arte moderna
della Regione
siciliana, in Da
Sciuti a Dorazio.
La collezione
d’arte moderna
della Regione
siciliana,
catalogo della
mostra (Palermo,
6 dicembre 2011
– 6 febbraio
2012) a cura di
S. Troisi,
Regione
Siciliana,
Soprintendenza
per i BB.CC.AA
di Palermo,
Palermo 2011,
pp. 12-25.
[26]
Nel 2000 Sergio
Flaccovio ha
ripreso le
pubblicazioni
della rivista,
con una doppia
numerazione che
affianca al
numero 1 della
seconda serie il
numero 90 della
prima.
[27]
Come desunto da
C. Latino,
“Sicilia” di
Salvatore Fausto
Flaccovio
(1953-1982),
Tesi di Laurea
Triennale,
Università degli
Studi di
Palermo,
relatore Prof.
S. La Barbera,
a.a. 2010-2011.
[28]
Si veda
per esempio
A. von
Platen,
Aus dem Hymnus
aus Sizilien, in
“Sicilia”, n. 8,
1954.
È
un’impostazione
che ricorda la
linea editoriale
de “La Sicile
illustrée”,
periodico
pubblicato a
Palermo dal 1904
al 1911, e
rivolto a un
turismo
internazionale
d’élite.
[29]
D. Simond,
Splendeur de
Palerme, in
“Sicilia”, n. 7,
1954; D. Simond,
De Messine a
Tindari, in
“Sicilia”, n.
11, 1955; D.
Simond, La
Sicile Romaine,
in “Sicilia”, n.
12, 1955; D.
Simond, La
Sicile Normande,
in “Sicilia”, n.
34, 1962; D.
Simond,
Decouverte de
Centuripe, in
“Sicilia”, n.
60, 1969; D.
Simond, De Naxos
a Taormine, in
“Sicilia”, n.
71, 1973.
[30]
Per l’artista si
veda E.
Bilardello,
Bruno Caruso,
Flaccovio,
Palermo 1987;
nella rivista si
trova L.
Sinisgalli, Il
disegno di
Caruso, in
“Sicilia”, n.
74, 1974.
[31]
B. Caruso, Per
ricominciare, in
“Sicilia”, n. 1
(90), 2000, p.
13.
[32]
E. Kitzinger, I
mosaici di
Monreale,
Flaccovio,
Palermo 1960; R.
Salvini, Il
Chiostro di
Monreale e la
scultura
romanica in
Sicilia,
Flaccovio,
Palermo 1963; W.
Kronig, Il duomo
di Monreale e
l’architettura
normanna in
Sicilia,
Flaccovio,
Palermo 1965.
Per il fotografo
cfr. Enzo
Sellerio.
Fotografie
1950-1989,
catalogo della
mostra (Palermo,
10 marzo – 3
maggio 2000),
Federico Motta
Editore, Milano
2000.
[33]
B. Berenson,
Maniera e
manierismo, in
“Sicilia del
popolo.
Quotidiano della
Democrazia
Cristiana”, a.
VII, n. 39,
1951, p. 5; B.
Berenson,
Momenti del
Caravaggio, in
“Sicilia del
popolo.
Quotidiano della
Democrazia
Cristiana”, a.
VII, n. 87,
1951, p. 3.
[34]
P. Romani,
Presentazione,
in “Sicilia”, n.
1, 1953.
[35]
“Sicilia”, n. 8,
1954.
[36]
Ibidem.
[37]
“Sicilia”, n.
10, 1955.
[38]
Per questi
aspetti vedi D.
Mormorio, Note
per una storia
della
rappresentazione
della Sicilia,
in L’identità
difficile...,
pp. 97-107.
[39]
L. Sciascia,
L’ingegnosa
Noto, in
“Sicilia”, n.
22, 1959; L.
Sciascia,
Tranchino: una “recherche”
siciliana, in
“Sicilia”, n.
72, 1973; L.
Sciascia, La “Vucciria”
di Guttuso, in
“Sicilia”, n.
76, 1975.
[40]
Si vedano N.
Tedesco, Il
giorno e la
notte nel mito
mediterraneo di
Zancanaro, in
“Sicilia”, n.
65, 1971; N.
Tedesco, Piraino
e i Lirici greci
di Quasimodo, in
“Sicilia”, n.
72, 1973.
[41]
Fra cui M.
Verdone, Ex
Voto, in
“Sicilia”, n.
10, 1955; G.
Cocchiara, Das
Sizilianische
Folklore, in
“Sicilia”, n.
21, 1959; A.
Buttitta,
Pitture popolari
su vetro, in
“Sicilia”, n.
33, 1962; A.
Uccello, Una
casa museo a
Palazzolo
Acreide, in
“Sicilia”, n.
55, 1967; G.
Palmeri, Il
Museo Pitrè a
Palermo, in
“Sicilia”, n.
65, 1971; J.
Vibaek, The
posters of the
marionette
theatre, in
“Sicilia”, n.
83, 1979.
[42]
G. Russo Perez,
Van Dyck in
Sicilia, in
“Sicilia”, n.
10, 1955; G.
Etna, Filippo
Liardo pittore
di Garibaldi, in
“Sicilia”, n.
31, 1961; G.
Sommariva, Un
siciliano in
oriente, in
“Sicilia”, n.
36, 1962 (sui
disegni del
missionario
teatino
Cristoforo
Castelli); S.
Giordano,
Ignazio
Marabitti,
scultore, in
“Sicilia”, n.
47, 1965; I.
Arnone Montana,
La sicilianità
di Onofrio
Tomaselli, in
“Sicilia”, n.
50, 1966; S.
Cuccia, Gli
affreschi di
Olivio Sozzi, in
“Sicilia”, n.
51, 1966; V.
Scuderi, Del
Manierismo e di
Filippo Paladini
in Sicilia, in
“Sicilia”, n.
53, 1967; G.
Novelli,
Antonello da
Messina, in
“Sicilia”, n.
85, 1979; S.
Giordano, Il
pittore senza
sorriso, in
“Sicilia”, n.
89, 1982 (su
Pietro Novelli);
C. Valenziano,
Iconi di
Sicilia, in
ibidem.
[43]
M. Taccari,
L’Abbazia di S.
Martino delle
Scale, in
“Sicilia”, n.
28, 1960; P.
Stone, The
mosaics and
cloisters of
Monreale, in
“Sicilia”, n.
29, 1961; F. de
Santis, Il
Castello della
Fawara, in
“Sicilia”, n.
31, 1961; S.
Cuccia, Le terme
arabe di Cefalà
Diana, in
“Sicilia”, n.
36, 1963; B.
Alessi, Storia e
architettura del
Castello di
Mussomeli, in
“Sicilia”, n.
73, 1973; G.
Romeo, Il
Castello di
Giuliana, in
“Sicilia”, n.
46, 1965; S.
Giordano,
L’oratorio di
Carini, in
“Sicilia”, n.
59, 1969; A.
Mogavero Fina,
Gli affreschi
trecenteschi di
Castelbuono, in
“Sicilia”, n.
75, 1974; R.
Santoro, Il
Castello di
Caccamo, in
ibidem; P.
Allegra, Il
Trittico di
Polizzi
Generosa, in
“Sicilia”, n.
77, 1975; P.
Gulino,
Caltagirone
città della
ceramica, in
ibidem; P. Di
Giovanni, Il
castello dei
Ventimiglia, in
“Sicilia”, n.
79, 1976; S.
Giordano, La
Collegiata di
Monreale, in
ibidem; S. Di
Fazio, Storia e
arte a S. Marco
d’Alunzio, in
“Sicilia”, n.
84, 1979; M.A.
Platania, Il
Casale di
Misterbianco, in
“Sicilia”, n.
87, 1981; M.
Guttilla
Nicolosi, La SS.
Trinità di Delia
a Castelvetrano,
in “Sicilia”, n.
89, 1982.
[44]
S. Bottari, Il
Castello Ursino
di Catania, in
“Sicilia”, n. 3,
1953; G.
Bellafiore,
Decorazione
architettonica
siciliana
nell’età
barocca, in
“Sicilia”, n.
28, 1960; V.
Scuderi,
Architettura
barocca
trapanese, in
“Sicilia”, n.
30, 1961; R. La
Duca, Ville
settecentesche
nella Piana dei
Colli, in
“Sicilia”, n.
42, 1964; M.
Giuffrè, Palazzo
Moncada a
Caltanissetta,
in “Sicilia”, n.
63, 1970; L.
Natoli, Le ville
della Conca
d’Oro, in
“Sicilia”, n.
69, 1972; L.
Natoli, La
struttura urbana
di Cefalù, in
“Sicilia”, n.
72, 1973; L.
Natoli, Un parco
archeologico
come occasione
di loisir e di
cultura, in
“Sicilia”, n.
73, 1973; G.L.
Ciotta, Chiese
basiliane in
Sicilia, in
“Sicilia”, n.
80, 1976; M.
Giuffrè, Messina
luogo “forte” e
città porto, in
“Sicilia”, n.
82, 1978; L.
Natoli, Note
sull’urbanistica
siciliana del
Cinquecento, in
“Sicilia”, n.
83, 1979; M.A.
Spadaro,
L’architettura
del paesaggio
nella Palermo
fine ’700, in
“Sicilia”, n.
87, 1981.
[45]
R. Giani, Una
intelligenza
siciliana, in
“Sicilia”, n. 2,
1953.
[46]
V. Fagone,
Scultori
siciliani a
Enna, in
“Sicilia”, n.
75, 1974; G.
Orlandi,
Rassegna
nazionale del
sacro nell’arte
contemporanea,
in “Sicilia”, n.
80, 1976.
[47]
G. Etna, Renato
Guttuso, in
“Sicilia”, n.
34, 1962; L.
Pasqualino Noto,
Il gruppo dei
quattro
siciliani, in
ibidem; L.
Pasqualino Noto,
Pittori
siciliani, in
“Sicilia”, n.
51, 1966; M.
Poma Basile,
Pittori
siciliani, in
“Sicilia”, n.
46, 1965; N.
Garajo,
Sicilianità di
Guttuso, in
“Sicilia”, n.
50, 1966; R.
Giani,
Autobiografia di
Guttuso par l’Image,
in “Sicilia”, n.
61, 1970; V.
Fagone, Giuseppe
Migneco, uomo
del Sud, in
“Sicilia”, n.
64, 1970; F.
Grasso, Guttuso,
in “Sicilia”, n.
65, 1971; G.
Baragli,
Giambecchina
pittore
siciliano, in
“Sicilia”, n.
77, 1975. Sullo
scultore segnalo
G. Lanza Tomasi,
Per Baragli, in
“Sicilia”, n.
67, 1971.
[48]
E. Baggio,
Sicilia e
siciliani alla
vii
Quadriennale,
“Sicilia”, n.
13, 1956; G.
Etna, I
Siciliani alla
Quadriennale di
Roma, in
“Sicilia”, n.
26, 1960; R.
Giani, Pittori
siciliani a
Roma, in
“Sicilia”, n.
31, 1961; A.
Querèl, La
Sicilia alla
Biennale di
Venezia, in
“Sicilia”, n.
36, 1962; D.
Querel, Gli
artisti
siciliani alla
ix Quadriennale
d’arte italiana,
in “Sicilia”, n.
49, 1966.
[49]
F. Grasso,
Approdo in
Sicilia di
Antonietta
Raphael, in
“Sicilia”, n.
72, 1973.
[50]
F. Grasso, Il
discorso di
Gauli sulla
Sicilia, in
“Sicilia”, n.
73, 1973; R.
Santoro, Gli
antichi mercati
panormiti visti
da Gauli, in
“Sicilia”, n.
80, 1976.
[51]
F. Grasso,
Incontri
siciliani di
Franco [!]
Ciniglia, in
“Sicilia”, n.
76, 1975.
[52]
R. Romano, Il
podere dalle
teste scolpite,
in “Sicilia”, n.
9, 1955 (su
Filippo
Bentivegna); A.
Uccello, Sabo,
in “Sicilia”, n.
66, 1971; E.
Mandarà, Il
pittore
contadino, in
“Sicilia”, n.
60, 1969 (su
Francesco
Giombarresi); M.
Consoli Sardo,
Il pittore
mandriano, in
“Sicilia”, n.
85, 1979 (su
Antonio Mancuso
Fuoco). Per gli
outsider cfr.
http://outsiderart.unipa.it/index.php/it/sicilia/gli-artisti.
[53]
Mostra
antologica di
Cagli, catalogo
della mostra
(Palermo, 25
marzo – 25
aprile),
Flaccovio,
Palermo 1967.
L’anno seguente
la Galleria La
Robinia di
Palermo allestì
una seconda
mostra
sull’artista.
[54]
E. Crispolti, La
Sicilia di
Corrado Cagli,
in “Sicilia”, n.
52, 1966; M.N.
Varga, Cagli e
la Sicilia, in
“Sicilia”, n.
58, 1969; U.
Attardi, L’Etna
di Corrado
Cagli, in
“Sicilia”, n.
67, 1971.
[55]
M. Accascina,
Oreficeria di
Sicilia,
Flaccovio,
Palermo 1974; M.
Accascina, I
marchi delle
argenterie e
oreficerie
siciliane, Busto
Arsizio 1976.
Nella rivista è
pubblicato M.
Accascina, I
“begli arredi”
di Ragusa, in
“Sicilia”, n.
55, 1967.
[56]
A. Ragona, La
maiolica
siciliana dalle
origini
all’Ottocento,
Sellerio,
Palermo 1977.
Nella rivista si
possono leggere
N. Ragona, La
maiolica
siciliana del
periodo arcaico,
in “Sicilia”, n.
14, 1956; A.
Ragona, L’arte
dei figurinai di
Caltagirone, in
“Sicilia”, n.
52, 1966; A.
Ragona, Le
maioliche
siciliane, in
“Sicilia”, n.
66, 1971.
[57]
A. Daneu
Lattanzi,
Simboli e
profezie nel
medioevo, in
“Sicilia”, n.
12, 1955; A.
Daneu, Rosso e
Oro, in
“Sicilia”, n.
19, 1957; A.
Daneu Lattanzi,
I coralli della
Fondazione
Whitaker, in
“Sicilia”, n.
88, 1981.
L’articolo di
Daneu anticipa
l’opera A. Daneu,
L’arte trapanese
del corallo,
Banco di Sicilia
– Fondazione
Ignazio Mormino,
Palermo 1964,
uscita postuma a
cura di Angela
Lattanzi.
[58]
G. Sommariva, I
corali miniati
di Ciminna, in
“Sicilia”, n.
48, 1965; V.
Adragna, Il
“libro d’ore”
della Biblioteca
Fardelliana, in
“Sicilia”, n.
66, 1971.
[59]
L. De Libero,
Serpotta danza e
vola, in
“Sicilia”, n. 6,
1954; P. Stone,
Giacomo Serpotta,
“Sicilia”, n.
35, 1962; G.
Novelli, Barocco
e putti del
Serpotta, in
“Sicilia”, n.
54, 1967; G.
Macaluso, I “Serpotta”
di Casa
Professa, in
“Sicilia”, n.
66, 1971; V.
Agnesi, Gli
oratori
palermitani di
Giacomo Serpotta,
in “Sicilia”, n.
83, 1979.
[60]
Segnalo a mo’ di
esempio L.
Bartolini, La
ceramica
calatina, in
“Sicilia”, n. 3,
1953; G.
Cocchiara, I
Pastori del
Matera, in
“Sicilia”, n.
36, 1962; G.
Romeo, Gli
arazzi di
Marsala, in
“Sicilia”, n.
37, 1963; B.
Fazio,
Mattonelle
maiolicate
siciliane, in
“Sicilia”, n.
38, 1963; G.
Cocchiara,
L’arte dei
Bongiovanni
Vaccaro, in
“Sicilia”, n.
45, 1965; S.
Cuccia, Crocette
lignee bizantine
in Sicilia, in
“Sicilia”, n.
56, 1967; L.
Liotta, Il Tiraz
di Palermo, in
ibidem; C.
Bernardi
Salvetti,
Presepi d’arte e
maestri «pasturari»
in Sicilia, in
“Sicilia”, n.
57, 1968; E.
Maggio
Palazzolo,
Sonagli
d’argento, in
“Sicilia”, n.
62, 1970; G.
Cardella, Vecchi
smalti
siciliani, in
“Sicilia”, n.
64, 1970; F.
D’Angelo, La
ceramica del
Palazzo dei
Normanni, in
ibidem; E.
Sellerio, Gli
smalti della
Cattedrale di
Agrigento, in
“Sicilia”, n.
69, 1972; F.
Sgroj, L’ambra
del Simeto, in
“Sicilia”, n.
73, 1973; S.
Cuccia, Avori e
coralli, in
“Sicilia”, n.
80, 1976; M.T.
Valenti Leser,
Der töpferort S.
Stefano di
Camastra, in
“Sicilia”, n.
89, 1982.
[61]
A. Lipinsky,
L’arte orafa dei
Normanni di
Sicilia, in
“Sicilia”, n.
20, 1958; A.
Lipinsky,
Siziliens Krone,
in “Sicilia”, n.
23, 1959; A.
Lipinsky, Die
Kirchenschätze
von Randazzo, in
“Sicilia”, n.
33, 1962; A.
Lipinsky, Die
Heilige Agathe
Schutzpatronin
von Catania, in
“Sicilia”, n.
39, 1963; A.
Lipinsky, Die
Heilige Rosalie,
in “Sicilia”, n.
50, 1966; A.
Lipinsky, Die
Apfel der
Hesperiden, in
“Sicilia”, n.
55, 1967; A.
Lipinsky,
Sizilianische
Marchenschiffe,
in “Sicilia”, n.
61, 1970; A.
Lipinsky, Der
Silberschatz von
Canicattini
Bagni, in
“Sicilia”, n.
68, 1972; A.
Lipinsky, Der
Bischofsstab von
Troina, in
“Sicilia”, n.
73, 1974.
[62]
G. Vigni, La
Galleria
Nazionale della
Sicilia, in
“Sicilia”, n. 8,
1954. Vigni
comunicava i
risultati dei
lavori di
allestimento
dell’Abatellis
anche in G.
Vigni, La
Galleria
Nazionale della
Sicilia a
Palermo, in
“Bollettino
d’arte”, n. 2,
1955, pp.
185-190. Cfr. V.
Abbate, Galleria
Nazionale della
Sicilia (palazzo
Abatellis)
1953-1954, in
Carlo Scarpa.
Mostre e Musei
1944-1976…, p.
126. Fra gli
articoli della
rivista dedicati
al museo segnalo
G. Quatriglio,
Gli inediti di
palazzo
Abbatelli, in
“Sicilia”, n.
50, 1966; V.
Scuderi,
Restauri presso
la Galleria
Nazionale, in
“Sicilia”, n.
64, 1970.
[63]
V. Scuderi, Il
Museo Pepoli, in
“Sicilia”, n.
50, 1966.
[64]
S. Giordano, Il
Tesoro del Duomo
di Monreale, in
“Sicilia”, n.
37, 1963; F.
Pottino, Il
Museo Diocesano
di Palermo, in
“Sicilia”, n.
40, 1963; F.
Pottino, Il
tesoro della
Cappella
Palatina, in
“Sicilia”, n.
63, 1970; S.
Prestifilippo,
Il Tesoro del
Duomo di
Messina, in
“Sicilia”, n.
71, 1973.
[65]
G. Quatriglio,
Un tesoro
siciliano nel
cielo di Vienna,
in “Sicilia”, n.
83, 1979
(dedicato alle
arti suntuarie
nella Weltliche
Schatzkammer del
Kunsthistorisches
Museum di
Vienna).
[66]
Per questi temi
cfr. Museo e
Società, atti
del convegno
(Palermo, 8-11
novembre 1979),
Assessorato
BB.CC. e P.I.,
Palermo 1980. Si
veda pure A.
Buttitta, Per un
Museo della
civiltà
siciliana, in
“Sicilia”, n.
64, 1970.