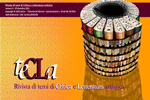L’arrivo della
Compagnia di
Gesù a
Caltanissetta
nel 1588 per
volere del
principe
Francesco II
Moncada e della
madre Aloisia de
Luna y Vega
suggella la
lunga amicizia
che legava ormai
da tempo i
Gesuiti ai
Moncada e
contribuisce con
la costruzione
del collegio
alla
riorganizzazione
urbanistica
della città,
avviata nel
tardo
Quattrocento con
l’apertura della
croce di strade
incernierata nel
trecentesco
piano dila
Nuntiata. Tale
processo
prosegue nel
1566 con il
trasferimento
della piazza
Maggiore
dall’antico
borgo medievale
di origine araba
al piano dila
Nuntiata,
compiendosi
negli anni
ottanta del
Cinquecento, con
l’apertura dello
‘Stradone del
Collegio’ al
termine del
quale viene
edificata la
chiesa di S.
Agata[1].
Il
progetto del
collegio venne
realizzato
dall’architetto
gesuita Alfio
Vinci: una
figura molto
cara ai Moncada
per il suo
coinvolgimento
nei numerosi
cantieri di
architettura
sacra e civile
affidatigli
dalla famiglia[2].
Il disegno del
complesso,
impostato su
un’organizzazione
degli spazi in
quattro
quadranti di
quaranta canne
di lato
ciascuno, sarà
oggetto di
discussione nei
primi anni del
Seicento per le
difficoltà
tecniche legate
alla sua
esecuzione.
Molti saranno,
infatti, gli
architetti
coinvolti nel
cantiere dopo la
morte di Vinci
nel 1592,
impegnati a
portare avanti i
lavori di
costruzione
dell’edificio e
a risolvere le
sue numerose
problematiche
esecutive.
Dopo il
coinvolgimento
in cantiere
dell’architetto
Giacomo Frini[3],
subentrato a
Vinci nel 1592,
il disegno del
complesso verrà
fortemente messo
in discussione
nei primi anni
del Seicento da
Natale Masucci e
dal rettore
Francesco
Costarella[4].
In
quella
circostanza si
darà mano
all’elaborazione
di soluzioni
architettoniche
alternative
all’idea di
partenza, ma
nessuna di
queste troverà
effettiva
realizzazione,
lasciando
pressoché
immutato il
disegno di
Vinci. Unica e
significativa
variante allo
schema
progettuale
approvata tra il
1601 e il 1603 è
rappresentata
dal nuovo
orientamento
stabilito per la
facciata della
chiesa di S.
Agata, la cui
apertura non
doveva più
essere
sull’antica
strada Maggiore
o strata Magna,
bensì sullo
‘Stradone del
Collegio’. Con
tale decisione
si portava a
compimento il
progetto di
strada con
fondale voluto
dai Moncada
nell’ambito del
programma di
modernizzazione
dello Stato
feudale nisseno.
Nello sviluppo
del progetto di
Vinci si dà
precedenza al
compimento dei
locali del
ginnasio e della
clausura dei
Gesuiti,
lasciando per
diversi anni
quasi immutato
il sito dove
andava edificata
la chiesa. Per
tale ragione,
quando nel 1617
l’architetto
Tommaso Blandino
subentra a
Masucci nella
direzione dei
cantieri
gesuitici di
Sicilia e,
dunque molto
probabilmente,
anche in quello
nisseno,
dell’edificio di
S. Agata
risultava
definito
soltanto il
perimetro
basamentale
secondo l’idea
d’impianto a
croce greca
stabilita nel
Cinquecento[5].
La costruzione
della chiesa va
dal 1617 al
1622, anno della
sua apertura al
culto,
proseguendo
tuttavia con
Bartolomeo e
Giovanni
Battista
Serpotta di
Monreale e Marco
la Porta di
Ciminna nel
1647, impegnati
nell’intaglio
del portale
esterno e del
finestrone
centrale di
facciata, e nel
1654 con
maestranze
nissene attive
nell’esecuzione
della facciata
dell’edificio e
dello scalone
monumentale di
accesso al
sagrato del
tempio,
quest’ultimo
eseguito con la
direzione
dell’architetto
fra’ Pietro da
Genova,
impegnato in
quel tempo nella
costruzione di
palazzo Moncada[6].
Ma se
il Seicento
risulta per il
complesso
gesuitico e per
la chiesa, in
particolare, il
secolo in cui si
portano a
compimento tutte
quelle
trasformazioni
architettoniche
necessarie per
dare sviluppo
alla fabbrica
secondo le
scelte
progettuali
maturate da
Vinci e i
ripensamenti
seicenteschi,
bisognerà
guardare al
Settecento per
assistere allo
sviluppo del
ricco programma
di lavori che
interesserà
l’architettura
interna del
tempio. Le opere
realizzate
verranno rese
possibili dai
ricchi legati
testamentari
disposti a
favore della
chiesa da
notabili ed
ecclesiastici
del luogo,
determinando
l’arrivo in
città di diversi
esponenti del
commesso
marmoreo
siciliano,
impegnati nella
realizzazione
delle opere
decorative per
la cappella di
S. Ignazio di
Loyola e per
l’abside di S.
Agata[7].
Interessanti
fonti d’archivio
attestano la
volontà di
tradurre in
chiave
monumentale la
cappella di S.
Ignazio di
Loyola molto
prima della
realizzazione
dei lavori che
ne avrebbero
definito a
inizio
Settecento
l’immagine oggi
conosciuta. Tale
dato emerge dal
testamento del
chierico
Leonardo Abbate
del 1658, che
finanziava la
realizzazione di
una struttura
marmorea con
pietre dure per
l’altare del
santo:
in
abbellimento di
fabrica per
ditta cappella
di Sant’Ignatio
in doratura,
petri mischi,
colonni, marmi
et altri cosi
necessarij che
ricerchirà decta
fabrica di decta
cappella e
finuta che sarà
decta cappella
di decti
ornamenti di
fabrica decti
renditi di supra
assignati si
habbia d’erogari
e spendiri in
tanti giogali
per servitio di
detta cappella[8].
Si
tratta di un
intervento mai
realizzato, ma
assai vicino per
forma alla
volontà
testamentaria
dell’abate
Giuseppe Sbernia
del 1688, con la
quale si dà
effettivo inizio
alle
trasformazioni
della cappella
col
coinvolgimento
di marmorari
trapanesi e
messinesi:
totum
restans ditte
hereditatis
debeat applicari,
erogari et
expendi pro
beneficio ditte
cappelle tam pro
fabrica et
struttura
marmorea et in
alijs lapidibus
pretiosis quam
pro jocalibus,
argenteis et
aureis benevisis
reverendo
procuratori
ditte
hereditatis, ita
quod fructus
dicte
hereditatis non
possint expendi
nisi tantum pro
benefitio et
ornamento dicte
cappelle et non
aliter nec alio
modo. Item
voluit dittus
testator quod
cappella
predicta sit et
intelligatur
confinata et
clausa usque ad
pilastra
Ecclesie
predicte
vicioniora ipsi
cappelle et
succedente[9].
I
lavori nella
cappella di S.
Ignazio di
Loyola iniziano
nel 1702 col
trapanese
Giovanni
Battista
Lombardo,
impegnato a
realizzare su
richiesta di
padre Antonio
Maria de
Valenza,
procuratore di
Sbernia,
l’impalcato
architettonico
centrale
dell’altare,
organizzato con
colonne binate
arricchite da
motivi fitomorfi
e da prominenze
scultoree che
raffigurano
cherubini
contornati di
turgidi trionfi
di frutta. Al di
sopra delle
colonne binate,
oltre la
trabeazione, due
spezzoni di
frontone
chiudono
l’intera
composizione.
Nell’opera trova
ampio spazio
l’uso di «marmi
bianchi
rabiscati di
pietri, cioè di
pietra paragone,
di pietra gialla
di Mezzo Juso,
di pietra di
libeccio e di
pietra bardiglia
di Genova giusta
la forma delli
disegni e lavori
che sono fatti
nel disegno
fatto frà d’essi
contrahenti e
sottoscritto da
ditto mastro di
Lombardo»[10].
La
lavorazione di
tutti i marmi
avviene a
Trapani nella
bottega dello
scultore, ad
eccezione delle
quattro colonne
marmoree
scolpite a
Caltanissetta
«in octo pezzi
cioè ogni
colonna in dui
pezzi […] e pure
d’haverli a
stricare et
allustrare
lustri e
lucenti».
Il
programma dei
lavori nella
cappella non si
limita al solo
impalcato
architettonico
centrale, ma
prosegue nel
1709 con
maestranze
messinesi
esperte nella
lavorazione
delle pietre
dure, impegnate
nell’esecuzione
del progetto che
Francesco Natale
Juvarra,
fratello del
celebre
architetto
Filippo, elabora
per la
decorazione
delle ali
laterali
dell’altare.
Francesco Natale
appartiene ad
una delle più
importanti
botteghe di
maestri
argentieri
attive a Messina
tra Sei e
Settecento, al
cui interno
compaiono
assieme a lui il
padre Pietro, il
fratello minore
Filippo e il
fratellastro
maggiore
Sebastiano.
Pietro emancipa
il figlio
Francesco Natale
nel 1692,
consentendogli
di diventare
«famoso
professore di
scultura
d’argento o
cesellatore»
grazie a
proficue
collaborazioni
professionali
con importanti
personaggi del
tempo come
Giacomo Amato
nell’esecuzione
di arredi
preziosi e
Francesco Lo
Judice nella
realizzazione
dei candelieri
del duomo di
Messina[11].
L’esperienza
nissena risulta
in tal senso una
novità
nell’operato
dello scultore,
rappresentando
di fatto allo
stato attuale
degli studi il
primo caso di
progettazione
architettonica a
lui affidato.
Tuttavia non va
esclusa la
possibilità che
nel disegno
della cappella
abbia avuto
parte
determinante il
fratello
Filippo, i cui
pensieri
potrebbero aver
suggerito a
Francesco Natale
il programma
decorativo per
le fasce
parietali
collaterali
all’altare
ignaziano. Primi
ad essere
coinvolti
nell’esecuzione
dell’opera sono
nel 1709 i
messinesi
Pancrazio Bosco,
Blasio e
Pasquale d’Amato
e Giuseppe
Vizzari[12],
impegnati a
realizzare un
«palio di marmo
ad arabeschi
commessi […]
quali pietre da
mettersi per
ditti mastri
habiano da
essere dure e
non molli come
si è detto e
colorite secondo
l’altro dissegno
farà don /
Francesco
Juvarra in
grande»[13].
Si tratta di un
paliotto
d’altare
disegnato per la
cappella di S.
Ignazio, ma mai
effettivamente
usato perché
costruito
difformemente
all’idea di
progetto[14].
Per tale ragione
nel 1710 si
ordina la sua
sistemazione
nell’altare
maggiore della
chiesa, venendo
più tardi
rimosso per
trovare spazio
con molta
probabilità
nella cappella
di San Francesco
Saverio. La
tavola marmorea
potrebbe secondo
tale ipotesi
identificarsi
col paliotto che
riproduce
l’effigie di S.
Ignazio
nell’atto di
ricevere dalla
Madonna il libro
degli esercizi
spirituali nella
grotta di
Manresa[15].
Nuovi
«marmorari» si
impegnano nel
1709 a lavorare
al progetto
juvarriano. Si
tratta dei
maestri Santo e
Lorenzo Bara,
padre e figlio,
chiamati a
realizzare per
il prezzo di 50
onze l’«opera di
marmi piani,
commessi e
scorniciati
dell’ala
sinistra della
sudetta
venerabile
cappella»[16].
Nello
stesso anno
accanto ai Bara
lo scultore
Giacomo Antonino
Marchetta lavora
alla fattura dei
putti e delle
statue dei santi
collocate entro
le nicchie
conchigliate
ricavate nelle
fasce parietali
collaterali
all’altare di S.
Ignazio.
All’ala
sinistra fa
seguito nel 1710
l’elaborazione
dei marmi
commessi per
l’ala destra
della cappella,
assieme alla
lavorazione
della lapide
sepolcrale
dell’abate
Giuseppe Sbernia
«di arabeschi
commessi con le
sue armi». A
questo si
aggiunge la
costruzione di
un nuovo
paliotto
d’altare
eseguito su
progetto di
Innocenzo
Trabucco:
di più
ditto mastro
Sancto s’obliga
fare a ditto
reverendo padre
Sbernia ditto
nomine un novo
palio di
commesso in due,
che doverà
aprirsi secondo
il disegno
concertato […]
con doverli
ancora dare
ditto reverendo
padre il pezzo /
del verde antico
venato da
Catania nec non
e doverli pagare
la metà del
disegno di ditto
palio fatto da
ditto di
Trabucco così di
pacto. Item che
ditto di Barra
sia tenuto tutti
li uccelli come
nel disegno
lavorarli e
commetterli
conforme
richiede l’arte
cosi di pacto[17].
Innocenzo
Trabucco si
inserisce nel
progetto
juvarriano col
disegno delle
scale e del
nuovo paliotto
per l’altare di
S. Ignazio, non
più «in tabula
marmorea
integra» come
quello
precedente, ma
su due piani
commessi,
decorato con la
riproduzione di
motivi floreali
e uccelli[18].
Lo sviluppo del
cantiere nella
cappella va
avanti sino al
1710, quando i
Bara abbandonano
i lavori
incorrendo nella
lunga vertenza
legale contro la
Compagnia
nissena con
l’accusa di
«furto e
baratteria»[19].
Per tale ragione
i lavori
verranno
affidati ai
messinesi Masi,
Pasquale e
Blasio D’Amato e
Pancrazio Bosco,
impegnati a
rifare tutte
quelle parti del
progetto
juvarriano mal
eseguite dai
Bara.
I
lavori nella
chiesa di S.
Agata proseguono
nel 1753 con la
riqualificazione
architettonica
della parete
absidale.
Ciò è
attestato dalla
licenza che il
provinciale
Vespasiano
Trigona concede
al gesuita
Antonio Calafato
per dar corso
alla decorazione
dello spazio
sacro:
Le
significo
inoltre d’aver
jo dato al padre
Antonio Calafato
la licenza di
continuare gli
incominciati
ornamenti de
marmi per il
cappellone,
purché lasciate
intatta la
scalèa
dell’altare
maggiore, per
cui vostro
rettore dimostra
/ principalmente
avere il suo
impegno,
contentandosi
per ora di
portare a
perfezione li
due prospetti
collaterali
dell’altare
maggiore, per li
quali egli
trovasi non che
impegnato ma
altresì
obbligato in
virtù
d’alberano:
molto più che
avendo jo
osservato il
disegno delli
nominati
prospetti non mi
è sembrato o per
la qualità delli
marmi o per la
loro
combinazione
disdicevole alla
magnificenza di
cotesta basilica[20].
Nell’esecuzione
dell’opera
vengono
coinvolti lo
scultore
palermitano
Giovanni
Battista Marino,
allievo di
Francesco
Ignazio
Marabitti, e il
catanese
Domenico
Battaglia. Il
sodalizio
artistico tra le
due figure è
comprovato dal
trasferimento di
Marino intorno
al 1750 a
Catania, dove
assieme a
Battaglia lavora
in diversi
cantieri di
architettura
come a Siracusa
tra il 1729 e il
1767 nella
costruzione
dell’altare a
colonne tortili
dell’ala
sinistra del
transetto del
duomo e nel 1744
nella stessa
città nella
scalinata della
chiesa del
collegio,
facendovi
ritorno qualche
anno dopo al
fianco di
Marabitti per la
decorazione
dell’altare di
S. Ignazio,
opera portata a
termine nel 1752
con Battaglia su
progetto di
Melchiorre
Spedalieri[21].
A
Caltanissetta
Marino non viene
chiamato
soltanto ad
intervenire
sulla parete
absidale di S.
Agata, ma esegue
per la cappella
di
S.
Ignazio
l’altorilievo
marmoreo che
raffigura il
santo con le
quattro parti
del mondo, sul
modello
dell’apoteosi di
S. Ignazio
realizzata da
Marabitti tra il
1749 e il 1751
per la chiesa
dei Gesuiti di
Catania[22].
L’intervento di
Marino e
Battaglia
consiste nel
«foderare di
pietre marmoree,
cioè di marmo
bianco di
Saravezza, di
rosso di
Francia, di
verde di Venezia
e di pietra di
libice, il fondo
del cappellone
della chiesa di
ditto venerabile
collegio»[23],
mantenendo
inalterata su
richiesta del
padre
provinciale la
scalea
dell’altare.
Il
programma dei
lavori, eseguito
probabilmente su
progetto degli
stessi scultori,
pone al centro
della parete
absidale la
grande pala
d’altare che
raffigura il
martirio di S.
Agata,
impreziosita da
una cornice in
pietra di
paragone al di
sopra della
quale viene
disposto uno
scudo,
arricchito da
due putti
realizzati da
Marino. A lui si
devono pure i
putti e i
simulacri di san
Michele e della
Madonna inseriti
nelle nicchie
aperte nelle ali
collaterali
all’altare
maggiore[24].
Appendice
documentaria
Segni
diacritici usati
nella
trascrizione dei
documenti:
/
inizio di una
nuova carta
[…]
omissione di
parte del
documento
…
parte non
decifrabile del
documento
1702, 1
novembre.
Capitoli sulla
costruzione
dell’altare di
S. Ignazio di
Loyola col
coinvolgimento
dello scultore
trapanese
Giovanni
Battista
Lombardo
Testamur quod
magister Joannes
Battista
Lombardo
scarpellinus
civis huius
urbis Drepani
mihi notaro
cognito presens
coram nobis
sponte teneatur
et debeat prout
promisit et
promittit seque
sollemniter
obligavit et
obligat
reverendo patri
Antonio Maria de
Valenza
Societatis Jesu
uti procuratori
reverendi patris
Hieronimi
Sbernia eiusdem
Societatis Jesu
tamquam
administratoris
generalis
hereditatis
quondam
reverendissimi
abbatis […] don
Joseph Sbernia
eius olim
fratris a quo
fuit instituta
heres
universales
venerabilis
cappella divi
Ignatij Loijole
Collegij
Societatis Jesu
civitatis
Calatanissette
vigore sui
testamenti et
codicillorum in
actis quondam
notarii Joseph
Falci dicte
civitatis
Calatanissette
diebus
preteritis
virtute
huiusmodi
procurationis
cum potestate
ampliandi
celebrate in
actis notarii
Pauli Curcuruto
Calatanissette
sub die vigesimo
tertio maij none
indicionis 1701
et stante
potestate
predicta /
ampliandi dictus
pater de
Valentia
procuratorio
nomine predicto
dictam
precalendatam
procurationem
elargavit et
elargat ac
ampliavit et
ampliat ad
faciendum et
stipulandum
presentem
contractum et
omnia et singula
in presenti
contractu
contenta omni
meliori modo
mihi etiam
notario cognito
presenti et
ditto nomine
stipulanti etiam
me notario pro
dicta hereditate
dicti quondam
reverendissimi
abbatis don
Joseph Sbernia
seu pro dicta
cappella divi
Ignatij Loiole
dicti Collegij
Societatis Jesu
civitatis
Calatanissette
legitime
stipulante ut
dicitur di
havere a fare e
construere una
cappella di
marmi bianchi
rabiscati di
pietri, cioè di
pietra paragone,
di pietra giarla
di Mezzo Juso,
di pietra di
libeccio e di
pietra bardiglia
di Genova giusta
la forma delli
disegni e lavori
che sono fatti
nel disegno
fatto frà d’essi
contrahenti e
sottoscritto da
ditto mastro di
Lombardo, da
detto padre
procuratore e
dal reverendo
sacerdote don
Antonino Castro
con che li dui
scalini della
pradella /
dell’altare
habbiano di
essere di pietra
nigra del petro
palazzo di
questa città di
Trapani et il
sudetto mastro
di Lumbardo
tutti li lavori
e disegni delli
sudetti marmi
bianchi
rabiscati come
sopra scalini et
ogn’altra cosa
sia obligato di
haverli a fare e
quelli habbiano
d’essere di
quella
grandezza,
altezza,
larghezza,
lavori, disegni,
colonnati et
altri come sopra
descritti,
annotati e fatti
in detto disegno
fatto e
sottoscritto di
loro proprie
mani come sopra,
esclusi però li
quattro colonni
nudi tantum et
dumtaxat per li
quali sudetti
quattro colonni
nudi tantum il
sudetto mastro
di Lumbardo non
sia tenuto né
obligato farli e
che la sudetta
cappella di
detti marmi
bianchi
rabiscati come
sopra detto
mastro di
Lombardo l’habbia
da fare qui in
Trapani per
servitio della
detta cappella
di Santo Ignatio
Loijola di detto
Collegio di
Caltanissetta e
per fare e
lavorare detta
cappella di
detti marmi
bianchi
rabiscati come
sopra scalini et
ogn’altra cosa /
giusta il
sudetto disegno
il sudetto
mastro di
Lombardo sia
obligato così
per il materiale
di detti marmi e
di detti
rabischi pietre
et di ogn’altro
materiale ch’è
necessario in
ordine alli
pietri tantum et
dumtaxat come
per tutte le
mastrie che ci
vorranno et
habbia da
incominciare di
dimane innante e
seguire
successivamente
con tutti quelli
mastri che sono
necessarij senza
mai levare mano
e darla lesta di
tutto punto ad
altius per tutto
il mese di
aprile dell’anno
duodecima
inditione 1704
et ogni cosa di
detta cappella
s’habbia da
consignare
delata e posta
qui in Trapani
nella potega di
detto mastro di
Lombardo di
havere ad
assistere così
al carricato di
detta cappella
come al
discarricare et
anche habbia
d’assistere
all’assettare la
sudetta cappella
con essere pure
obligato detto
mastro di
Lombardo ad
andarvi
personalmente
benché li
sudetti pezzi di
marmi, rabischi
et altri di /
detta cappella
habbiano
d’andare a
risico, periculo
e fortuna di
detto padre
procuratore
dicto nomine e
la sudetta
cappella detto
mastro di
Lombardo sia
obligato di
haverla a fare
del modo e forma
come sopra bene
e
magistrabilmente
conforme ricerca
l’arte et ogni
cosa sia a
benvista del
sudetto
reverendo
sacerdote don
Antonino Castro
alias. Pro
pretijs et
magisterij in
totum unciarum
quatricentarum
in pecunia justi
ponderis ut
dicitur a muzzo
et accordio
inter dictos
contrahentes
habito et
tractato
sollemni
stipulatione
vallato et
iuramento
firmato in
compotum quarum
quidem unciarum
quatricentarum
dictus magister
de Lumbardo
dixit et fatetur
habuisse et
recepisse a
dicto reverendo
patre de
Valentia
procuratorio
nomine predicto
stipulante
uncias viginti
in pecunia iusti
ponderis de
contanti
renunciando. Et
reliquas uncias
tricentas
octuaginta
dictus
reverendus pater
de Valentia
procuratorio
nomine predicto
dare et solvere
promisit et
promictit ac /
se obligavit et
obligat dicto
magistro de
Lumbardo
stipulanti seu
persone legitime
pro eo hic
Drepani in
pecunia justi
ponderis
successive
videlicet
laborando
solvendo in
pacem. Processit
ex patto che
detto mastro di
Lombardo oltre
dette onze
quattrocento
habbia e debbia
d’havere quando
và in
Caltanissetta e
da ditta città
di Caltanissetta
ritorna in
questa città di
Trapani accesso
e recesso
franco, assieme
con
l’infrascritte
tre altre
persone e mentre
dimora in detta
città di
Caltanissetta
pure habbia d’havere
mangiare e
bevere franchi
assieme con tre
altre persone
che porterà per
assistere così
al discarricato
come
nell’assettare
detta cappella.
E più detto
mastro di
Lombardo sia
tenuto et
obligato
conforme in
virtù del
presente s’ha
obligato et
obliga al
sudetto
reverendo padre
di Valenza
procuratorio
nomine predicto
stipulante d’havere
a lavorare li
quattro colonni
di pietra di
libeccio che ci
deve consignare
il sudetto /
padre di Valenza
ditto nomine in
octo pezzi cioè
ogni colonna in
dui pezzi quali
quattro colonni
in detti otto
pezzi detto
mastro di
Lombardo sia
obligato
lavorarli in
detta città di
Caltanissetta e
pure d’haverli a
stricare et
allustrare
lustri e lucenti
a specchio con
quell’altri
mastri che ci
vorrà fare
lavorare ditto
di Lombardo et
habbiano da
essere bene e
magistribilmente
lavorati
conforme li
vorrà detto
reverendo padre
procuratore
dicto nomine e
di quando
incomincia a
lavorarli e
stricarli et
allustrarli come
sopra detto di
Lumbardo non
possa levare
mano per infino
che sono lesti
di tutto punto
et anche detto
mastro di
Lombardo sia
obligato dette
quattro colonni
in detti otto
pezzi d’haverle
a commettere seu
unire con li
suoi perni e
tutto il
materiale ce l’habbia
da dare detto
padre
procuratore
solamente sia
obligato detto
di Lombardo per
le semplici
mastrie tantum
et dumtaxat
alias. / Pro
magisterio ad
rationem
tarenorum
quatuor in
pecunia iusti
ponderis singulo
die pro persona
dicti magistri
de Lumbardo et
pro alijs
personis
laborantibus in
dictis columnis
ad rationem
tarenorum duorum
in pecunia iusti
ponderis etiam
singulo die pro
quolibet persona
et ultra cum esu
et potu tam pro
dicto de
Lumbardo quam
pro dictis alijs
personis
laborantibus in
columnis
predictis quod
quidem
magisterium
dictus pater
procurator de
Valentia dicto
nomine dare et
solvere promisit
et promictit ac
se obligavit et
obligat dicto
magistro de
Lumbardo
stipulanti seu
persone legitime
pro eo in dicta
civitate
Calatanissette
in pecunia justi
ponderis succe.
videlicet
laborando
solvendo in
pacem […].
(ASCl,
Corporazioni
religiose
soppresse, vol.
184, ff. 68 r -
71 v).
1709,
18 gennaio.
Contratto
d’obbligo per la
costruzione di
un paliotto
d’altare in
marmi mischi
nell’altare di
S. Ignazio di
Loyola ad opera
dei messinesi
Brancasio Bosco,
Blasio e
Pasquale d’Amato
e Giuseppe
Vizzari
Jesus.
Presenti innanti
noi nomine
testimonijs
infrascripti li
mastri Brancasio
Bosco del
quondam
Vincentio,
Blasio d’Amato e
Paschale d’Amato
del quondam
Giovanni Maria e
Giuseppe Vizzari
figlio maritato
[…] Messani da
me notaio
conosciuti
sponte insolidum
renunciando si
obligarono et
obligano fare al
reverendo padre
Heronimo Sbernia
della Compagnia
di Gesù presente
cognito et
interveniente
come procuratore
et
amministratore
dell’eredità
della venerabile
cappella di
Sant’Ignazio nel
devoto Collegio
di Caltanissetta
un palio di
marmo ad
arabeschi
commessi giusta
la forma del
disegno
sottoscritto da
ambedue esse
parti rimasto in
potere di ditto
reverendo padre
di Sbernia con
mettere il marmo
e le pietre dure
e non molli li
sudeti mastri
eccettuata la
pietra di
calcara, la
pietra agata, el
corallo quali li
habia di dare
ditto reverendo
padre di Sbernia
ditto nomine a
ditti mastri
serrati e boni
per patto. Quali
pietre da
mettersi per
ditti mastri
habiano da
essere dure e
non molli come
si è detto e
colorite secondo
l’altro dissegno
farà don /
Francesco
Juvarra in
Grande. … di
patto che ditto
palio l’habiano
da lavorare nel
venerabile
Colleggio della
Compagnia di
Messina e darlo
finito di tutto
punto per tutta
la festa di
Pasqua
Resurectione
proxima ventura
1709. Ita che
ditto palio
habia da essere
ben visto al
ditto di Juvarra
et al reverendo
padre Salvadore
Costa di ditta
venerabile
Compagnia alli
quali ditti
mastri donano
facoltà di
potere
aggiungere e
levare secondo
dimanda l’arte
[…]. E questo
per raggione di
prezzo, mastria
et ogn’altra
cosa a raggione
di tarì 18 lo
palmo incluso lo
marmo mastria et
ogn’altra cosa
così di accordio
e in conto e pro
modo li ditti
mastri in
solidum
confessano
havere havuto e
ricevuto dal
ditto reverendo
padre di Sbernia
ditto nomine
stipulante onze
otto di denari
contanti di
giusto prezo e
numero come
costa, lo resto
per quanto
importerà lo
ditto reverendo
padre s’obliga
pagarlo alli
ditti mastri in
/ in solidum
travagliando
pagando coll’exequtione
per patto. In
patto che lo
disegno di ditto
di Juvarra l’habiano
di pagare esse
parti a metà
così di patto.
[…].
(ASCl,
Corporazioni
religiose
soppresse, vol.
184, ff. 258 r -
259 r).
1753, 4
agosto.
Contratto
d’obbligo per la
trasformazione
della parete
absidale della
chiesa di S.
Agata col
coinvolgimento
degli scultori
Giovanni
Battista Marino
e Domenico
Battaglia
Noi
sottoscritti
Giovanni
Battista Marino
della città di
Palermo ed al
presente
abitatore di
questa città di
Catania e mastro
Domenico
Battaglia di
questa sudetta
città insolidum
in virtù del
presente scritto
seu alberano ci
oblighiamo al
venerabile
Collegio della
Compagnia di
Gesù della città
di Caltanissetta
e per essa al
reverendissimo
padre Michele
Calafato di
ditta Compagnia
di Gesù come
procuratore del
sudetto
venerabile
Collegio di
foderare di
pietre marmoree
cioè di marmo
bianco di
Saravezza, di
rosso di
Francia, di
verde di Venezia
e di pietra di
libice il fondo
del cappellone
della chiesa di
ditto venerabile
Collegio in un
colli due
pelastri di
detto
cappellone, da
farsi però ditti
pelastri a libro
e di più far la
cornice del
quadro
dell’altare
maggiore di
pietra paragone
e questo a
tenore del
disegno a tal
effetto seriam.e
fattosi colla
specificazione
della diversità
delle pietre
sudette con
dovere noi
sudetti e
sottoscritti di
Marino e
Battaglia
mettervi tutto
il materiale di
marmo bianco e
pietre diverse
sudette e per
conseguenza
dovrà da noi
medesimi sudetti
e sottoscritti
di Marino e
Battaglia
comprarsi ditto
materiale a
nostre spese ed
a nostre spese
pure di tutto
punto lavorarsi,
lustrarsi a
specchio tutti
li pezzi e
finalmente
collocarsi poi
in ditta chiesa
seu foderarsi il
cappellone e
pelastri e farsi
e collocarsi la
cornice e scudo
e sudetti
coll’assistenza
di noi medesimi.
Tal modo che
tanto per il
materiale
sudetto lavoro e
lustro di esso
quanto per la
collocazione del
medesimo in
niente sia
obligato il
ditto venerabile
Collegio e per
esso ditto
reverendissimo
padre Calafato
procuratore come
sopra solamente
però detto
venerabile
Collegio e per
esso io sudetto
e sottoscritto
padre Michele
Calafato
procuratore in
virtù del
presente scritto
seu alberano mi
obligo far la
fabrica di calce
ed arena che
abbisognerà
farsi al di
dietro sopra la
quale dovranno
collocarsi dalli
ditti e
sottoscritti di
Marino e
Battaglia li
sudetti pezzi,
cornice e scudo
lavorati e
lustrati a
specchio come
supra siccome
devo io sudetto
e sottoscritto
padre Michele
ditto nomine far
trasportare da
Catania sino a
Caltanissetta
tutto ditto
materiale a mie
spese ed a mie
spese pure
locarsi le
cavalcature che
necessiteranno
per l’accesso e
ricesso di detti
di Marino e
Battaglia e
dell’altri
mastri che li
medesimi
dovranno ivi
mandare. Caso
che però se /
per accidente si
fracassasse e
scantonasse
qualche pezzo
per strada
dovranno li
sudetti di
Marino e
Battaglia
riconciarlo a
loro spese e
travagli sovra
luogo come noi
sudetti e
sovrascritti di
Marino e
Battaglia in
virtù del
presente ci
oblighiamo
riconciarlo o
rifarlo a nostre
spese e travagli
siccome ci
oblighiamo a ben
commettere i
pezzi sudetti di
tutto detto
servizo nel
collocarli come
fare comparire
tutto un pezzo
li pelastri, la
cornice, lo
scudo el
cappellone
sudetti e
finalmente in
virtù del
presente ci
oblighiamo
comprar detto
marmo paragone e
pietre sudette
di tutta qualità
siccome di tutta
qualità fare il
lavoro senza che
vi fossero pezzi
scantonati anche
in minutis
minima parte né
collocare pezzi
che non ben
commettessero
l’un coll’altro
e sopra
ogn’altro tutto
ditto materiale,
lavoro, lustro
ed altri sudetti
devono essere
benvisti al
ditto padre
Calafato ditto
nomine ed al
procuratore del
sudetto
venerabile
Collegio a
segnocchè se le
pietre comprande
non sarranno di
qualità o se di
qualità non ben
lavorate non
lustrate a
specchio o non
ben commesse sia
lecito a ditto
padre Calafato
ditto nomine
rifiutarle per
rifarsi da noi
sudetti e
sottoscritti di
Marino e
Battaglia o
farseli fare
ditto padre
Calafato ditto
nomine da altri
virtuosi a
nostri danni,
spese ed
interessi con
doversi tutto
allestirsi e
collocarsi pel
mese di marzo
venturo 1754 per
pacto in pacem
alias come supra.
E questo per
ragione di
staglio tra
marmo, pietre,
lavoro, lustro e
tutt’altro
sopraditti in
tutto alla
ragione di tarì
otto il palmo
cioè tarì 8 per
ogni palmo
quadro
superficiale
apparente per
patto a riserva
però dello scudo
sudetto pel
quale sia
obligato io
sudetto e
sottoscritto
padre Calafato
ditto nomine
pagare ai
sudetti di
Marino e
Battaglia onze
... come patto.
In conto noi
sudetti e
sottoscritti di
Marino e
Battaglia
confessiamo in
virtù del
presente aver
ricevuto dal
sudetto padre
Michele ditto
nomine onze
cento trenta
quattro e lo
resto io sudetto
e sottoscritto
padre Michele
ditto nomine in
virtù del
presente m’obligo
soccorrere di
tempo in tempo
ai sudetti di
Marino e
Battaglia / e
collocato poi e
terminato ditto
servizio
allestirsi e
questo per libro
in potere di me
sudetto
sottoscritto
procuratore
Michele ditto
nomine al quale
come patto in
pace ed in
denari alias. Di
più io sudetto e
sottoscritto
Giovanni
Battista Marino
solo in virtù
del presente m’obligo
al ditto padre
Michele ditto
nomine fargli
per ditta chiesa
di ditto
venerabile
Collegio due
statue di marmo
bianco cioè una
della Madonna
Santissima e
l’altra di san
Michele Glorioso
siccome numero
sei pottini pure
di marmo bianco
da
perfezzionarsi e
consegnarsi
ditte statue e
pottini nel
sudetto mese di
marzo proximo
venturo 1754
come pacto in
pacem alias come
supra col patto
però che se non
piaceranno a
ditto padre
Michele ditto
nomine dovrò io
sudetto e
sottoscritto di
Marino rifarli a
mie spese come
patto. E questo
per ragione di
staglio tra
marmo e lavoro
cioè in quanto
alle due statue
a ragione di
onze trentadue
l’una ed in
quanto alli sei
pottini a
ragione di onze
cinque l’uno
collocate e
buone. […].
(ASCl,
Corporazioni
religiose
soppresse, vol.
190, ff. 331 r -
332 r).
________________________
[1] L’apertura dello Stradone, nata dalla necessità di offrire al collegio un sito piuttosto centrale all’interno della città, avviene secondo il modello della strada diritta con fondale tipico della moderna cultura urbanistica. Sulla chiesa di S. Agata si veda F. Pulci, Storia ecclesiastica di Caltanissetta, Ed. del Seminario, Caltanissetta 1977, pp. 398-406; A.I. Lima, Architettura e Urbanistica della Compagnia di Gesù in Sicilia, Novecento, Palermo 2001, pp. 173-181. Per un approfondimento sul progetto del collegio gesuitico e sul suo ruolo nel riordino urbanistico di Caltanissetta si veda il volume in corso di stampa di G. Giugno, Caltanissetta: i Moncada e il progetto di città moderna, Lussografica, Caltanissetta 2012.
[2] Sulla figura dell’architetto gesuita Alfio Vinci di estrema importanza è il contributo di N. Aricò, Libro di Architettura. Da L.B. Alberti ad anonimo gesuita siciliano del tardo secolo XVI, vol. I, GBM, Messina 2005.
[3] Giacomo Frini nasce a Messina nel 1543. Divenuto architetto lavora a Palermo come coadiutore di Natale Masucci per la chiesa del Gesù. Cfr. L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani. Architettura, vol. I, a cura di M.C. Ruggieri Tricoli, Novecento, Palermo 1993, p. 186; A.I. Lima, Architettura e Urbanistica…, p. XXXII.
[4] Sulla figura di Natale Masucci si veda ibid., pp. XXII-XXIII.
[5] Sulla figura di Tommaso Blandino si veda ibid., pp. XXII-XXIII.
[6] Sul ruolo di fra’ Pietro da Genova nel cantiere gesuitico si veda D. Vullo, Palazzo Moncada a Caltanissetta, in La Sicilia dei Moncada. Le corti, l’arte e la cultura nei secoli XVI-XVI, a cura di L. Scalisi, Domenico Sanfilippo Editore, Catania 2006, p. 295.
[7] Tra le donazioni stabilite per riformare l’immagine architettonica della chiesa ricordiamo quella di 400 onze nel 1625 voluta da Francesco Moncada, fratello del futuro principe di Paternò Luigi Guglielmo. Archivio di Stato di Caltanissetta (d’ora in poi ASCl), Not. F. Volo, vol. 1035, f. 663 r. Alla donazione di Francesco Moncada nel 1625 farà seguito quella dell’abate di Santo Spirito Gaspare Romano nel 1636, la cui volontà di trovare sepoltura nella cappella di S. Ignazio è accompagnata dall’offerta al collegio di un «crucifisso di ramo supra dorato integro come sta una con lo supradicto / quatretto della Madonna et santo Dominico con li cornici di ramo dorato supra expressato nella cappella di esso testatori et lo suo messali grandi novo» (ASCl, Corporazioni religiose soppresse, vol. 36, f. 260 r).
[8] Sulla cappella di S. Ignazio di Loyola nella chiesa di S. Agata si veda F. Pulci, Lavori sulla…, pp. 398-406; M.R. Basta, Natura ed esotismo nei paliotti a marmi mischi della chiesa di Sant’Agata al collegio gesuitico di Caltanisetta, in Sicilia barocca. Maestri, officine, cantieri, a cura di F. Maurici, G.E. Viola, “Quaderni Lumsa”, 25, Roma 2005, pp. 73-85; S. Piazza, I colori del Barocco. Architettura e decorazione in marmi policromi nella Sicilia del Seicento, Flaccovio, Palermo 2007, pp. 57-59; G. Giugno, La cappella di Sant’Ignazio di Loyola…, pp. 40-48.
[9] Il riordino della cappella di S. Ignazio avviato dopo la morte nel 1688 dell’abate Giuseppe Sbernia è diretto da padre Geronimo Sbernia, nominato dall’ecclesiastico amministratore dei suoi beni (ASCl, Not. G. Falci, vol. 886, f. 5 r; ASCl, Corporazioni religiose soppresse, vol. 30, s.n.). Un codicillo testamentario dell’abate afferma che qualora non fosse stata concessa a Sbernia sepoltura nella chiesa di S. Agata, bisognava in tal caso devolvere l’intera somma di denaro prevista per la trasformazione della cappella alla chiesa di San Sebastiano, «ad effetto in quella fondarsi l’oratorio della congregazione di san Philippo Neri delli padri dell’Olivella» (ASCl, Corporazioni religiose soppresse, vol. 30, s.n.).
[10] Cfr. infra Doc. 1.
[11] Sulla collaborazione artistica tra Francesco Natale Juvarra e Francesco Lo Judice si veda G. Musolino, Argentieri messinesi tra XVII e XVIII secolo, Di Nicolò, Messina 2001, pp. 139-153; G. Musolino, L’ostensorio della chiesa di San Giorgio a Modica e l’attività “eccellentissima” di Francesco Lo Judice e Francesco Natale Juvarra. Proposte ed ipotesi, in Il Tesoro dell’Isola. Capolavori siciliani in argento e corallo dal XV al XVIII secolo, a cura di S. Rizzo, vol. I, Giuseppe Maimone, Catania 2008, pp. 191-205. Sul rapporto con Giacomo Amato si veda D. Malignaggi, L’effimero barocco negli studi, rilievi e progetti di Giacomo Amato conservati alla galleria regionale di Sicilia, in “BCA Sicilia”, a. II, ff. 3-4, Palermo 1981, pp. 27-41, nota 18.
[12] Pasquale Amato o d’Amato, scultore messinese, pare sia l’ideatore del monumento funebre dell’arcivescovo Migliaccio nel duomo di Messina, realizzato con i fratelli Antonio e Biagio nel 1728. Cfr. S. Bottari, Il Duomo di Messina, La Sicilia, Messina 1929.
[13] Cfr. infra Doc. 2.
[14] A causa della mancata esecuzione del progetto juvarriano verrà chiesto ai «marmorari» di costruire un nuovo paliotto in un’unica tavola marmorea con l’uso di pietre dure «ut vulgo dicitur nuovo turchino, novo corallo, nova venturina e novo lapislazoli» (ASCl, Corporazioni religiose soppresse, vol. 188, f. 354 r).
[15] Dopo la trasformazione della cappella di S. Ignazio la Compagnia intende tradurre in chiave monumentale anche la prospiciente cappella di San Francesco Saverio, con un progetto architettonico e decorativo del tutto simile a quello juvarriano. Ciò viene documentato nel 1730 dal testamento di Ludovico Morillo, che dispone il pagamento di 100 onze per «abbellire la ditta venerabile cappella, con colonne e statue marmorie come quella in frontispitio di Sant’Ignazio Lojola […] che deve essere marmoria rabiscata con statue e metterci li miei armi» (ASCl, Corporazioni religiose soppresse, vol. 58, f. 79 r). Un nuovo legato giunge alla cappella nel 1738, con l’ingresso nella Compagnia del barone Michele Calafato, «pro donazione di ditta chiesa in edificio di marmo o pure d’argento per servigio di ditta cappella». (ASCl, Corporazioni religiose soppresse, vol. 39, f. 566 r).
[16] ASCl, Corporazioni religiose soppresse, vol. 188, f. 526 r.
[17] ASCl, Corporazioni religiose soppresse, vol. 186, f. 500 r.
[18] ASCl, Corporazioni religiose soppresse, vol. 186, f. 431 r.
[19] ASCl, Corporazioni religiose soppresse, vol. 188, f. 347 r.
[20] ASCl, Corporazioni religiose soppresse, vol. 48, ff. 215 r-215 v.
[21] Giovanni Battista Marino è probabilmente figlio dello scultore Giuseppe Marino, autore dell’arcangelo Raffaele posto ai piedi della statua dell’Immacolata Concezione nella piazza S. Domenico a Palermo. Assai proficuo risulta il suo operato soprattutto nella parte orientale della Sicilia. Tra le sue opere ricordiamo in particolare le statue per la balaustrata antistante la chiesa di S. Sebastiano ad Acireale realizzate nel 1754 su disegno del pittore Paolo Vasta. Cfr. U. Thieme, F. Becker, Allgemaines Lexikon der Bildenden Künstler, vol. XXIV, Verlag von E.A. Seemann, Leipzig 1930, p. 108.
[22] Sullo scultore Francesco Ignazio Marabitti si veda D. Malignaggi, Ignazio Marabitti, in “Storia dell’Arte”, n. 17, 1974, pp. 1-61. Sulla realizzazione dell’altorilievo per l’altare di S. Ignazio di Loyola nella chiesa dei Gesuiti di Caltanisetta si rimanda a D. Malignaggi, La scultura della seconda metà del Seicento e del Settecento, in Storia della Sicilia, vol. X, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Palermo 1981, p. 102.
[23] La lavorazione dei manufatti marmorei per l’abside della chiesa avviene nella bottega dei maestri marmorari a Catania. Solo successivamente l’opera è trasferita a Caltanissetta. Cfr. infra Doc. 3.
[24] Nonostante l’espulsione dei Gesuiti dall’isola nel 1767, non verrà meno l’attenzione per il decoro interno della chiesa di S. Agata. Infatti, nel tempo in cui il collegio diviene monastero delle Benedettine di Santa Croce, alcuni provvedimenti vicereali come quello del 1781 della Real Segreteria dispongono a favore della chiesa così come accade per i collegi di Trapani e Casa Professa di Palermo la somma di 466.27.15 onze, da impiegare «per le fabbriche, marmii, giogali ed arredi sacri» del tempio (ASCl, Archivio storico comunale, vol. 90, f. 165 r).