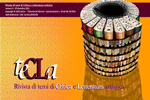Scrivere della
pittura
siciliana del
XVII secolo, ove
non si sia già
fatta ampia luce
sulle vicende
della cultura
figurativa del
Siglo de oro
isolano,
comporta
inevitabilmente
fare i conti con
una larga
divaricazione
tra due mondi
diversissimi: da
un lato la
grande, e per
molti versi
irripetibile,
esperienza di
Pietro Novelli
che rappresentò
la svolta
rispetto agli
esiti di un
tardo Manierismo
solo
parzialmente
innovato dalla
non lontana
parentesi di
Filippo Paladini
e dai testi
pittorici di
Michelangelo
Merisi;
dall’altro la
schiera di
epigoni più o
meno tributari
del Monrealese,
che – talora in
virtù delle loro
origini
“nordiche” –
tentarono una
mediazione tra
il ricco
eclettismo del
maestro e i
retaggi della
loro cultura
d’origine. Si
trattò in
qualche caso di
artisti
estremamente
dotati dal punto
di vista tecnico
e inventivo
(viene in mente
il luminismo
neocaravaggesco
di Matthias Stom[1],
che tuttavia ben
poco seguito
attrasse fra gli
artisti locali),
molto attenti al
gusto della
committenza
laica ed
ecclesiastica;
in qualche altro
di pittori
indubitabilmente
“secondari” (o
addirittura in
una posizione di
“classifica”
ancor più
bassa), la cui
produzione –
tuttavia – dà
conto di un
panorama in ogni
caso multiforme.
In
questo
intervento
presenterò tre
opere sin qui
abbastanza
trascurate dalla
storiografia
artistica le
quali, mi
sembra,
presentano però
i tratti del più
grande interesse
a ricostruire il
retroterra
pittorico
siciliano del
Seicento. Mi
riferisco a un
gruppo di
dipinti
cronologicamente
omogenei
(appartengono
tutti alla prima
metà del XVII
secolo), certo
non
qualificabili
come
“capolavori”, ma
che pure val la
pena di
conoscere o di
riscoprire
poiché –
sconosciute o
erratamente
attribuite –
s’inseriscono
esattamente nel
milieu cui
accennavo: si
tratta di una
Pentecoste
(1624) custodita
presso la
Basilica di San
Francesco
d’Assisi a
Palermo, opera
inedita di un
quasi ignoto
Giuseppe
Schettino; di
una Immacolata
(1634)
conservata nel
Seminario
Vescovile di
Trapani, da
assegnare a
nostro avviso al
minnitesco
siracusano
Giuseppe Reati;
e di una Madonna
del Rosario
(1647), nella
chiesa della
Badia Nuova a
Trapani,
giustamente
attribuita (ma
solo di
passaggio) al
fiammingo
Geronimo Gerardi,
per analogia con
altre opere del
pittore.
Qui darò conto,
ovviamente con
brevità, delle
ragioni che mi
inducono a
formulare queste
attribuzioni.
La data
della Pentecoste[2]
di Giuseppe
Schettino si
desume dal
relativo
contratto
stipulato dal
pittore con i
frati
francescani, già
citato in
transunto da
Giovanni Mendola
nel 1999
[3].
Tale contratto
riguardava anche
una
Resurrezione,
spazzata via
dalle bombe del
1943; il tutto,
curiosamente –
ma eravamo già
in tempi di
pestilenza –
solo in cambio
di “vitto e
alloggio” per il
pittore e un suo
famulo, per
tutta la durata
del lavoro
pittorico.
Premesso ancora
che delle opere
anzidette si
trovano già
sparute
citazioni
nell’Otto e
Novecento[4],
entriamo nel
merito della
raffigurazione.
Che colpisce a
prima vista – al
di là delle
disastrose
condizioni di
tutta la
superficie
dipinta –, per
l’affollata
rappresentazione
dell’ambiente
del Cenacolo
mariano, al
centro del quale
spicca
l’imponente
figura della
Vergine a
braccia aperte
tra apostoli e
discepoli che
coprono l’intero
spazio di primo
piano. Nel
secondo
s’intravedono
monumentali
architetture di
gusto classico,
che terminano
sul fondo con
un’alta esedra
illuminata da
una luce
ranciata,
immediato
richiamo al più
vivo arancione
dei manti degli
apostoli sul
proscenio. Pur
nelle
tristissime
condizioni
dell’intera
superficie
pittorica (anche
per effetto di
un maldestro
restauro “di
ricostruzione”
del dopoguerra),
l’immagine della
Madonna ha
ancora un che di
nobile e di
elegante: quasi
miracolosamente
illesa (da
quanto sembra)
nel bianco collo
e nel tenero
volto.
Quattro apostoli
di spalle, dagli
scultorei
mantelli
rosso-arancione
intrisi di luce,
formano come una
conca nel piano
inferiore della
tela, che poi si
colma con
l’affollata
assemblea
attorno alla
Vergine nella
zona centrale;
purtroppo di
assai difficile
lettura.
Composizione a
parte, tre sono
gli aspetti
preminenti del
linguaggio
formale che
sembrano
caratterizzare
interessi,
cultura e gusto
del nostro
sacerdote-pittore:
la vivezza e il
cangiantismo
cromatico, la
peculiare
tipologia della
Vergine, il
naturalismo
luministico
attraverso cui
vuol renderci le
figure popolane
di apostoli e
discepoli. Sono
tutti aspetti,
se non andiamo
errati, che ci
inducono a
collocare il
pittore
nell’area della
produzione
bazzanesca e
alviniana; a
quest’ultima
soprattutto, con
riferimento più
diretto alla
Allegoria
dell’Immacolata
Concezione
(1624) in Santa
Maria la Nuova a
Palermo di
Pietro Alvino,
figlio di
Giuseppe, il cui
calzante
confronto ci
viene
amichevolmente
suggerito da
Vincenzo Abbate[5];
nel rammarico
che le ripetute
forti
manomissioni
delle figure non
ci consentano di
risalire in
maniera più
sicura a quel
soffio di
intenso
naturalismo e
luminismo, forse
di radice
caravaggesca o
di contagio
novellesco,
affiorante, come
già accennato,
nei volti degli
apostoli. Resta
solo da
auspicare
vivamente, anche
se forse,
utopisticamente,
un nuovo e
coraggioso
restauro, che
possa consentire
un più sicuro
riconoscimento
di forme e
valori originali
e residui della
tela stessa.
L’Immacolata con
figura di
committente[6]
di Giuseppe
Reati (?,1634),
sebbene di un
decennio
successiva,
appartiene a un
Manierismo
diverso e ben
più remoto
rispetto a
quello che
esprime la tela
dello Schettino.
L’arcaismo
dell’impostazione
(l’icona della
Vergine con i
simboli
lauretani in
altrettanti
riquadri e la
figura del
committente
inginocchiato in
basso) richiama
a prototipi
addirittura
quattrocenteschi
(viene in mente
la Madonna del
Carmelo di
Tomaso de
Vigilia nella
palermitana
chiesa del
Carmine
Maggiore, datata
1492),
evidentemente
mai tramontati
nell’ambito
della pittura
devozionale del
XVII secolo.
Unica
concessione al
“verosimile” il
ritratto del
committente
chiaramente
identificato
dalla dedica
entro lo scudo
in primo piano:
“Fra Nicola
Cavarretta
Priore di
Venetia 1634”;
frate e priore
dell’Ordine di
Malta,
ovviamente, come
si evince dalla
bianca croce a
otto punte
ostentata sul
mantello[7].
Nessuno
ci ha saputo
dire come e
quando la tela
sia arrivata
nella sede
attuale; si può
solo immaginare,
credibilmente,
che essa abbia
avuto come sede
originaria una
cappella privata
della nobile
famiglia del
committente, in
un palazzo della
stessa a Trapani
o a Palermo[8].
L’opera è stata
resa nota nel
2004, ma con
l’attribuzione
difficilmente
sostenibile a
due mani diverse
che avrebbero
operato a
distanza di
oltre un
trentennio tra
di loro[9].
Analizzando,
tuttavia, i modi
figurativi delle
varie parti del
dipinto appare
evidente che non
due, ma tre mani
addirittura
possono portare
ad autori
diversi sebbene
comunque
nell’ambito
della stessa
bottega e dello
stesso momento
esecutivo,
testimoniato
dalla piena
omogeneità della
superficie
pittorica. Gli
accennati
diversi modi
figurativi
riguardano,
chiaramente, la
figura centrale
della Vergine, i
quadretti degli
stilizzati
simboli
lauretani
attorno a essa e
la rude figura
del
committente-devoto
inginocchiato in
basso. Una
preziosa notizia
storiografica
relativa al
pittore per cui
noi propendiamo
ci aiuterà a
capire da dove
provengano
queste
differenze; ma
vediamo,
intanto, in che
cosa esse
realmente
consistano. È
evidente, nella
pur monumentale
e quasi espansa
figura della
Vergine avvolta
nel manto
verdone a larghe
pieghe[10],
il permanere
dell’iconismo
controriformato,
addirittura
accentuato, in
questo caso,
dalla grande
mandorla ovale
dorata in cui la
figura è
racchiusa e
isolata, in una
sua dimensione
sacrale e “senza
tempo”[11].
Né vale a
rompere del
tutto tale
atmosfera un più
moderno effetto
di luce
naturale, tenera
e sfumata, sul
volto
aggraziato,
unico e modesto
segno di nuova
sensibilità
umana e
culturale
espresso dal
pittore.
Di ben
diversa cultura
manieristica,
tendente quasi
al geometrico e
all’astratto,
appaiono gli
stilizzati
quadretti con i
simboli delle
litanie lungo il
perimetro della
tela; anche se
lo stesso
pittore sa
applicarsi, in
certe
raffigurazioni
di fiori e
piante, in una
ricerca quasi
fiamminga di
verità naturale.
L’unica parte
del dipinto che
può dirsi
appieno
“moderna” e
consona alla più
diffusa cultura
naturalistica
del tempo è
quella che ci
presenta, pur
sommariamente
delineata, la
figura del
committente
inginocchiato,
dal volto
rossastro,
marcato e
rugoso. Non è
difficile
trovare la
spiegazione di
tale “fattura a
più mani”
coniugando tre
dati di
riferimento,
diretti o
indiretti e
ancorché
eterogenei.
Eccoli,
schematicamente:
il linguaggio
complessivo
della pittura
che – come mi
suggeriscono
amici
conoscitori
dell’area della
Sicilia
orientale –
indirizza
chiaramente
verso la bottega
minnitesca, di
cui attivamente
faceva parte
Giuseppe Reati;
l’autore più
probabile, a
nostro avviso,
di questa tela;
un dato
documentario
della biografia
del committente,
che sino al 1622
era Referendario
presso la
Commenda
gerosolomitana
di San Giovanni
a Caltagirone[12],
da dove avrà
potuto
apprezzare
l’anzidetta
bottega
minnitesca,
ricordandosene
più tardi quando
da Venezia,
forse all’apice
della sua
carriera,
ordinava il
dipinto,
devozionale e
autocelebrativo
al tempo stesso;
terzo e ultimo
(ma non meno
significativo)
dato, un cenno
storiografico di
Luigi Sarullo[13]
secondo il quale
il Reati teneva
a bottega ben
sedici allievi,
ovviamente con
talenti e
compiti diversi.
Non ci
resta, credo,
che ricercare
ogni riscontro
possibile tra
l’opera di cui
ci occupiamo e i
dipinti di più
sicura e
accreditata
attribuzione ai
citati pittori
siracusani, da
parte della
critica degli
ultimi decenni
(Campagna
Cicala, Barbera,
Spagnolo, Vella…).
Per
brevità, ci
limitiamo a
citare qui
alcune
morfo-tipologie
evidenti nella
tela trapanese,
e nella figura
della Vergine in
particolare,
ampiamente
riscontrabili in
alcune opere
abbastanza
affini di Mario
Minniti e di
Giuseppe Reati
custodite in
diversi luoghi
della Sicilia
orientale.
Figura e posa,
anzitutto, del
personaggio
principale, la
Madonna appunto;
colore rosso
acceso,
piegature rigide
e fitte con alta
accollatura
della veste;
lunghi capelli
sciolti, volto
aggraziato e
modellato (in
questo caso più
che in altri)
dallo sfumare
della luce; mani
affusolate ma
anche un po’
legnose… Tutto,
anche se
variamente,
riscontrabile
dalle due
Immacolate del
Minniti del
Museo di Messina
ma, ancor più,
nelle tele del
Reati:
l’Immacolata di
San Filippo Neri
a Siracusa, il
Miracolo di San
Domenico a
Soriano a
Modica, la
Madonna del
Carmine con i
Santi Agata e
Carlo Borromeo
di Noto[14].
Tutto questo,
peraltro, a
prescindere dai
significati
linguistici da
connettere alle
differenze di
tempi esecutivi,
cui non possiamo
dedicarci se non
per sottolineare
che la nostra
tela è datata,
come abbiamo
visto, al 1634
mentre quelle
già citate dello
stesso Reati si
collocano, com’è
stato
puntualmente
notato[15],
tra il ’38 ed il
’42. Altri potrà
indagare,
eventualmente,
con migliori
letture degli
aspetti e dei
linguaggi,
rispetto a
questi spunti.
L’ultimo dei
dipinti che qui
presentiamo, la
Madonna del
Rosario con i
Santi Domenico e
Caterina da
Siena[16]
di Geronimo
Gerardi[17]
(1647),
appartiene
invece alla fase
più aggiornata
della pittura
siciliana del
Seicento, quella
per intenderci
immediatamente
contigua alla
cerchia di
Pietro Novelli.
Questa bella e
colorata tela
posta
sull’altare
maggiore della
chiesa
ex-domenicana al
centro di
Trapani, a
differenza delle
precedenti non è
né inedita né
misconosciuta,
ma semplicemente
e marginalmente
nota agli
specialisti che,
di passaggio,
l’hanno citata
per analogia con
altre tele (a
Palermo, Cefalù,
etc.) dello
stesso pittore[18].
Ma essa merita
certamente, per
i motivi che
vedremo, una più
specifica
attenzione.
Ricordato,
anzitutto, che
la sua datazione
– 1647, dipinta
in basso sul
dorso del libro
adagiato sul
manto della
Santa Caterina –
era stata già
divulgata dagli
eruditi
trapanesi
dell’Ottocento
che avevano
concordemente
ammirato la
pittura «d’inavanzabile
pennello
fiammingo»[19]
e senza
indugiare sulla
descrizione,
rileviamo subito
che tra i valori
formali che la
caratterizzano
spicca
soprattutto la
componente
cromatica; per i
bianchi e neri
toccati dalla
luce dei sài
monacali ma,
ancor più, per
l’azzurro e il
rosso immersi
nella luce del
manto spazioso e
della veste
della Vergine.
Un
aspetto, poi,
che distingue
questa tela
dalle consorelle
palermitana e
cefaludese già
studiate, è
l’aggiunta nella
parte superiore
della mossa e
colorata
ghirlanda (quasi
di aerei
palloncini) con
episodi della
vita di Cristo e
di Maria. Ma, al
di là delle pur
strette affinità
con le tele
anzidette quanto
alla
composizione
piramidale delle
tre figure sacre
che incarnano i
rispettivi
soggetti, è
quell’animato
coronamento che
lega piuttosto
questa tela
domenicana a
un’altra pittura
trapanese dello
stesso Gerardi,
antecedente di
un decennio e
non meno
caratterizzata
da interessi
cromatico-spaziali:
la grande
Immacolata
Concezione che i
Gesuiti nel 1636
avevano
collocato
sull’altare
della loro
Chiesa del
Collegio,
distante da
quella
domenicana solo
qualche
centinaio di
metri[20].
L’accennata
ricerca di
“movimento
colorato” come
potremmo
definirlo, qui
rappresentata
dall’arco di
medaglioni
collegati da
serti floreali
nella parte alta
del dipinto,
poteva già
vedersi, infatti
– e anche assai
più ricca –
nella tela
dell’Immacolata,
nell’ampia e
festosa danza
dei floridi
puttini
rubensiani che
si svolgeva
tutt’attorno
all’alta figura
della Vergine,
emergente in un
azzurro ovale di
cielo. La
«squillante
ricchezza
cromatica» che –
utilizzo le
parole di
Vincenzo Abbate[21]
– caratterizza
la pittura del
Gerardi, qui
emerge in tutta
la sua fascinosa
evidenza.
Sempre
sul filo
dell’incidenza
stilistica dei
valori di colore
e luce, ma anche
di spazio e
movimento nel
linguaggio del
Gerardi di
questo tardo
tempo trapanese,
ritengo sia pure
da richiamare la
grande tela
carmelitana con
la Sacra
Famiglia con i
Santi Gioacchino
e Anna,
recentemente
attribuitagli da
Giovanni Mendola
e, quasi
sicuramente, di
questi stessi
anni quaranta[22].
Al
tirare allora
delle somme, ed
essendo stato
scritto che «le
opere del
Gerardi
presentano
caratteri più
spiccatamente
naturalistici in
cui non
risultano mai
troppo
accentuati i
toni cromatici,
rimanendo
evidenti
piuttosto
contrastanti
valori di
luce-ombra»[23],
non sembra di
assistere, con
queste ultime
tele del
fiammingo
proprio a un
orientamento
opposto, per il
quale proprio il
colore – non
senza apporti di
luce, spazio e
movimento –
sembra
interessare
maggiormente al
pittore e alla
sua committenza?
[1] Per il soggiorno siciliano di Matthias Stom, mi permetto di rinviare a V. Scuderi, Caravaggeschi nordici (e di «nazioni italiane») operanti in Sicilia. La posizione di Pietro Novelli, in Caravaggio in Sicilia: il suo tempo, il suo influsso, catalogo della mostra, Sellerio, Palermo 1984, pp. 183-224; cfr. inoltre A. Zalapì, Il soggiorno siciliano di Matthias Stom tra neostoicismo e «dissenso». Nuove acquisizioni documentarie sull’ambiente artistico straniero a Palermo, in Porto di mare. Pittori e pittura a Palermo, 1570-1670, catalogo della mostra a cura di V. Abbate et al., Electa, Napoli 1999, pp. 147-157; A. Zalapì, Matthias Stom. Un caravaggesco nella collezione Villafranca di Palermo, Museo Diocesano di Palermo, Palermo 2010.
[2] Si tratta di un olio su tela, cm 350 x 280, custodito nella parete destra presbiterio della Basilica di San Francesco di Assisi a Palermo.
[3] Prima del 1999, quando Giovanni Mendola (Dallo Zoppo di Ganci a Pietro Novelli. Nuove acquisizioni documentarie, in Porto di mare…, cit., pp. 57-87, a p. 73) citava il contratto con i Francescani, un altro contratto del 1632 era emerso a Trapani. Da esso risulta che Schettino si impegnava con i Carmelitani a dipingere nella cappella della Madonna una serie di riquadri entro un apparato di stucchi di Giuseppe Ferraro: tutto, oggi, perduto (cfr. G. Bongiovanni, Vicende della Cappella della Madonna, in M. C. Di Natale, V. Abbate (a cura di), Il Tesoro nascosto: gioie e argenti per la Madonna di Trapani, Novecento, Palermo, 1995, pp. 67-75, a p. 75). Da aggiungere, infine, che Giuseppe Schettino, prima di impegnarsi con i Francescani di Palermo per la Pentecoste e per la Resurrezione, doveva aver lavorato all’interno del Convento: nel contratto per le tele si parla infatti anche della eventuale ripresa di affreschi nel chiostro, oggi scomparsi.
[4] Cfr. G. Palermo, Guida per Palermo e suoi dintorni (ed. a cura di G. Di Marzo Ferro), Palermo 1858, p. 238; e F. Rotolo, La Basilica di San Francesco di Assisi, Palermo, 1952, p. 120. Impossibile verificare, oggi, quanto il Palermo affermava circa una data “1618” dipinta su di un libro in mano ad un apostolo. Nella nuova edizione del suo volume (La Basilica di San Francesco d’Assisi e le sue cappelle. Un monumento unico nella Palermo medievale, Provincia di Sicilia dei Frati Minori Conventuali Ss. Agata e Lucia, Palermo 2010, p. 328), padre Rotolo afferma che la tela fu restaurata nel 1970 dal pittore napoletano Stefano Macario.
[5] La tela di Pietro Alvino di Santa Maria La Nuova è stata pubblicata da T. Viscuso, Per la pittura in Sicilia occidentale nei primi del Seicento, in Contributi alla storia della cultura figurativa della Sicilia occidentale tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo. Palermo, 1985, p. 28; cfr. anche G. Mendola, Dallo Zoppo di Gangi…, cit., pp. 62-63.
[6] Si tratta di una tela, cm 281 x 203, custodita presso il Seminario vescovile di Trapani.
[7] Sulla nobile famiglia trapanese dei Cavarretta, vedi G. M. Di Ferro, Biografia degli uomini illustri trapanesi, Trapani 1830, tomo III, p. 68 e segg.
[8] Si conosce il palazzo privato della famiglia a Trapani, mentre se ne può anche ipotizzare uno a Palermo, dove Nicola Cavarretta disponeva di “soggiogazioni” da cui attingeva ampiamente i fondi per armare, ogni cinque anni, una galera per i Cavalieri di Malta. Cfr. L. Buono e G. Pace Gravina, (a cura di), La Sicilia dei Cavalieri. Le istituzioni dell’Ordine di Malta in età moderna (1530-1826), Fondazione Donna Maria Marullo di Condojanni, Roma 2003, p. 133, n. 7.
[9] M. Vitella, Su alcune immagini dell’Immacolata Concezione nel trapanese, in L’Immacolata nell’arte in Sicilia, catalogo della mostra a cura di M. C. Di Natale e M. Vitella, Palermo 2004, p. 134.
[10] In cui soprattutto sono evidenti ampi e non proprio felici rifacimenti di un restauro attuato un decennio addietro.
[11] Uso qui, ovviamente, la formula di Federico Zeri a proposito della pittura di Scipione Pulzone, che costituisce il titolo di uno dei suoi studi più fortunati, Pittura e Controriforma. L’“arte senza tempo di Scipione da Gaeta”, Neri Pozza, Vicenza 1997 (prima ed. Einaudi, Torino 1957).
[12] L. Buono e G. Pace Gravina, (a cura di), La Sicilia dei Cavalieri…, cit., p. 133.
[13] L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani, vol. II – Pittura, Novecento, Palermo 1993, ad vocem “Reati, Giuseppe” a cura di C. Di Giacomo, p. 447.
[14] Per un confronto alle opere anzidette, rimando a AA.VV, Mario Minniti, l’eredità di Caravaggio a Siracusa, Electa Napoli 2004, passim; Opere d’arte restaurate nelle province di Siracusa e Ragusa, 1990-92, Palermo 1994, passim.
[15] D. Spagnolo, schede 4-4 a/d, in Opere d’arte restaurate nelle province di Siracusa e Ragusa, II (1989), pp. 30 e ss.
[16] Si tratta di un olio su tela, cm 420 x 253, custodito a Trapani presso la Chiesa della Badia Nuova.
[17] Per Geronimo Gerardi (Anversa, 1595 ca.-Trapani, 1648), cfr. la scheda biografica a cura di G. Mendola, in Porto di mare…, cit., p. 273; cfr. inoltre gli studi di T. Viscuso, Pittori fiamminghi nella Sicilia occidentale al tempo di Pietro Novelli. Nuove acquisizioni documentarie, in Pietro Novelli e il suo ambiente, catalogo della mostra, Flaccovio, Palermo 1990, pp. 101-114; di G. Mendola, Un approdo sicuro. Nuovi documenti per Van Dyck e Gerardi a Palermo, in Porto di mare…, cit., pp. 88-105; e di
V. Abbate, Un’aggiunta a Geronimo Gerardi e qualche precisazione a margine del suo soggiorno siciliano, in Interventi sulla «questione meridionale». Saggi di Storia dell’arte, a cura del Centro di studi sulla civiltà artistica dell’Italia Meridionale «Giovanni Previtali», Donzelli, Roma 2005, pp. 223-228; N. Gozzano, Mercanti fiamminghi in Italia nel Seicento: agenti, artisti, consoli, “Bollettino Telematico dell’Arte”, n. 595, 22 Febbraio 2011, on line su http://www.bta.it/txt/a0/05/bta00595.html (visitato il 12 marzo 2012).
[18] S. Grasso, Dipinti inediti di G. Lo Verde, in “BCA Sicilia”, a. IV, nn. 1-4, 1983, pp. 107-122; e G. Mendola, La Madonna del Rosario con i Santi Domenico e Giacinto, scheda n. 33, in Porto di mare…, cit., pp. 238-239.
[19] G. M. Di Ferro, Guida per gli stranieri in Trapani, presso Manone e Solina, Trapani 1825, p. 36; e F. Mondello, Breve guida artistica di Trapani, Trapani, 1883, p. 82.
[20] M. P. Demma, Scheda n. 5, in Opere d’arte restaurate, 1987-1996, Trapani 1998, p. 35.
[21] V. Abbate, Un’aggiunta a Geronimo Gerardi…, cit., p. 225.
[22] Ringrazio ancora Giovanni Mendola per la comunicazione verbale su questa attribuzione, come ho già avuto modo di fare in V. Scuderi, La Madonna di Trapani e il suo Santuario, Edizioni del santuario della Madonna di Trapani, ivi 2011, p. 93.
[23] T. Viscuso, Pittori fiamminghi nella Sicilia occidentale…, cit., p. 106.