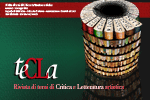Anche questo terzo numero di teCLa offre ai lettori alcuni interessanti contributi che prendono in esame aspetti particolari della cultura artistica sia europea che nazionale, ma anche siciliana, in un arco di tempo compreso tra gli albori dell’Ottocento e la prima metà del secolo successivo.primo articolo, Un grande corrispondente europeo. Aubin-Louis Millin tra Francia, Germania e Italia, proposto in due parti distinte da Monica Preti-Hamard e da Bénédicte Savoy, prende in esame la figura di Aubin-Louis Millin, uno dei principali attori della vita intellettuale e delle istituzioni culturali nella Francia post- rivoluzionaria. Oltre ai ruoli ufficiali che lo impegnarono soprattutto nella riorganizzazione degli istituti di istruzione pubblica – il Louvre e la Biblioteca nazionale di Francia – che erano stati arricchiti dalle campagne di confisca delle opere d’arte e di libri praticate da Napoleone in Italia (1796), fu raffinato intellettuale in contatto con numerosi studiosi. Le due autrici ricordano l’importanza del viaggio in Italia compiuto dal settembre 1811 al novembre 1813, durante il quale Millin visitò diverse città della Penisola e le cui tappe sono solo parzialmente descritte nel Voyage en Savoie, en Piémont, à Nice et à Génes, edito a Parigi nel 1816, sulla scia dei viaggi di studio e di ricerca quali quelli di Lanzi, di Cicognara, di Seroux d’Agincourt e sui quali Gianni Carlo Sciolla ha fornito illuminanti disamine. Soprattutto, dalle autrici sono analizzati i rapporti che il francese ebbe con intellettuali in particolare tedeschi ed italiani, individuando all’interno della sua corrispondenza due importanti carteggi che contengono gli scambi epistolari con l’archeologo tedesco Karl August Böttiger e con l’erudito romano Francesco Cancellieri e dalla lettura dei quali le informazioni fornite consentono di evidenziare i forti rapporti culturali che caratterizzavano lo spazio europeo del sapere nei primissimi anni del secolo XIX. Da questa corrispondenza risaltano sia le scelte di gusto dei corrispondenti sia gli aspetti del collezionismo del periodo, anche “il fissarsi di una storia della disciplina archeologica e dei suoi metodi, con interessanti riflessioni teoriche che palesano sia i modelli di erudizione e di circolazione ereditati dal XVIII secolo sia la creazione di strumenti moderni, democratici, rapidi e istituzionalizzati di diffusione del sapere”>
Nicoletta Di Bella, analizzando gli Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852), affronta gli stessi temi in un ambito più ristretto, ma non per questo meno interessante, quale è spesso quello della letteratura artistica siciliana, in questo caso messinese dell’Ottocento. L’articolo prende in esame la figura di Carmelo La Farina, intelligente conoscitore della cultura locale, indagandone alcune pubblicazioni, in particolare le ΄lettere artistiche΄ destinate ai più autorevoli membri della intellighenzia isolana e raccolte, nel 1835, in un volume intitolato Intorno le Belle Arti, e gli artisti fioriti in varie epoche in Messina – Ricerche ordinate in più lettere. Egli privilegia in modo innovativo per i suoi tempi, l’aspetto filologico piuttosto che quello descrittivo, spesso riscrivendo le vicende più salienti della storia artistica della città del Faro, ritornando nelle Lettere sulle tradizionali attribuzioni della precedente storiografia locale, correggendone diverse, facendo anche più volte nuova luce intorno alle notizie biografiche che riguardavano gli artisti messinesi.
Anche l’articolo di Carmelo Bajamonte Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo è dedicato ad un conoscitore siciliano, l’erudito palermitano Agostino Gallo, il cui breve saggio, pubblicato nel 1863, ha come argomento precipuo le arti decorative siciliane (argenteria e oreficeria, marmi mischi, maiolica ecc.) e le attività dei più importanti artisti attivi fra la fine del XVIII e il XIX secolo ai quali più volte, come attestano le varie Notizie intorno agli artisti siciliani raccolte e consultabili nei manoscritti da lui redatti e oggi conservati presso la Biblioteca Regionale di Palermo, dedica particolare attenzione analizzando anche le cause che avevano favorito il fiorire di questa particolare produzione. L’intento dichiarato dall’autore, che lo accomuna ai quasi coevi esiti di Giuseppe Meli e di Gioacchino Di Marzo con i quali la storiografia artistica siciliana inizierà ad approdare al rango di critica d’arte, è quello “di riabilitare la fortuna critica della scuola artistica siciliana in un più ampio contesto storiografico e di creare un momento unificante, all’insegna di un’arte italiana, proprio all’indomani dell’Unità”.
Lo scritto di Iolanda Di Natale, Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica allo studio della storia dell’arte siciliana dal tardo antico al barocco, prende appunto in esame l‘attività di questo storico dell’archeologia e dell’arte siciliane. Agnello, i cui lavori sulla produzione artistica paleocristiana e medievale isolana sono stati fondamentale punto di riferimento per le successive generazioni di studiosi, ha fornito con le sue numerose e pluritematiche ricerche un interessante proseguo e approfondimento degli studi di Gioacchino Di Marzo, Paolo Orsi ed Enrico Mauceri, soprattutto, un significativo contributo alla conoscenza del sistema artistico sia siracusano sia della Sicilia tutta, con riferimento anche alle arti decorative e alla produzione artistica del Barocco isolano.
In Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte. Erwin Panofsky e l’educazione estetica in presenza di disabilità visiva, Roberta Priori analizza una particolare applicazione che il metodo iconologico teorizzato da Erwin Panofsky trova nell’ambito dell’educazione estetica nei casi di disabilità visiva.
La studiosa si sofferma sulle fasi che caratterizzano il metodo didattico sviluppatosi alla fine degli anni Novanta presso il Museo tattile di Pittura antica e moderna Anteros dell’Istituto per ciechi Francesco Cavazza di Bologna. La percezione sensoriale (che corrisponde alla panofskiana lettura preiconografica), la cognizione (che corrisponde alla lettura iconografica) e l’interpretazione (che corrisponde alla lettura iconologica) dell’opera d’arte, nella lettura della Priori si evidenziano come i tre momenti che possono aiutare i non vedenti e gli ipovedenti per una più profonda comprensione dei manufatti. L’autrice parte dall’analisi di alcune opere giovanili e del periodo amburghese di Erwin Panofsky, in cui lo studioso si confronta con la tradizione critico-metodologica fornitagli dagli studi di Heinrich Wölfflin e di Alois Riegl ma anche dalle teorie di Aby Warburg e di Ernst Cassirer, evidenziando come nel percorso che lo porta alla sistematizzazione teorica del metodo tripartito, sia possibile rintracciare quelle possibilità, che prendendo spunto dal pensiero panofskiano, si possono indirizzare non soltanto all’educazione estetica dei non vedenti e anche “all’applicabilità degli aspetti educativo - pedagogici all’interno del complesso dibattito su percezione e significazione delle forme dotate di valore estetico”.
Infine, Marcella Marrocco, nello scritto Il museo negli scritti di Giulio Carlo Argan, pone degli interrogativi sull’attualità delle posizioni arganiane osservando che il critico durante tutta la sua attività, di studioso prima e di politico poi, ha considerato i musei, analizzati sia in riferimento alla loro struttura, soprattutto alla loro funzione sociale, quali oggetto di studio e di quella riflessione critica che lo ha quindi portato ad occuparsi della città intesa quale Gesammtkunstwerk, come oggetto estetico e come soggetto politico. La Marrocco ripercorre il percorso critico di Argan che partendo dalla lettura di Read e Dewey ed avendo i fondamenti metodologici nel pensiero dei suoi maestri, Venturi e Panofsky, nel definire la sua imago urbis assegna un ruolo centrale proprio ai musei che come luogo di incontro tra istanze storiche e istanze estetiche si pongono come spazio didattico privilegiato per l’educazione del cittadino.
Con quella che la studiosa definisce ‘lucida previsione’, Argan anticipa i concetti di musei-scuola e anche di una nuova scena urbana, di una nuova piazza che non è solamente luogo di incontro e di scambio culturale, ma anche metafora dei valori della società. In questa lucida previsione di quelli che sono oggi i nuovi modelli museali, “dalla critica del museologo, del museo-archiscultura all’apprezzamento di quei musei capaci di porsi come nuova «direttrice urbana», la Marrocco individua nelle posizioni arganiane spunti di riflessione ancora validi per il dibattito contemporaneo.Ancora una volta concludo questo breve editoriale con un ringraziamento ai colleghi che in qualità di componenti del comitato scientifico e di attenti e generosi revisori hanno contribuito con le loro osservazioni e suggerimenti, alla possibilità di offrire ai lettori un materiale che spero risulti di interessante ed utile lettura